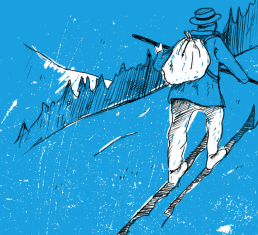Trail-food
Era bello fermarsi con gli amici a bere una birra dopo una sciata, certo. Per non parlare della comodità di poter pernottare in quota e raggiungere la cima dopo una colazione al caldo. Ma era ciò che ci motivava a partire? L’assenza di punti di appoggio gestiti in montagna obbliga a ingegnarsi col fai-da-te, e non è necessariamente una brutta cosa. Uno dei primi punti da affrontare, soprattutto per gite sugli sci di più giorni in autosufficienza in ambiente innevato, è proprio il cibo. Viaggiare leggeri e con una buona scorta di nutrienti a disposizione è una questione cruciale in inverno, ma non è facile. Un buon pasto caldo richiede lunghi tempi di preparazione, strumenti di cottura sofisticati e altrettanto spazio per essere trasportato. D’altra parte, il classico panino veloce e poco ingombrante dopo un po’ stanca, non si conserva a lungo e finisce per sbriciolarsi tra l’attrezzatura. La buona notizia è che gestire tutto ciò non solo è possibile, ma diventa anche un’ottima occasione per riflettere sul valore dell’autonomia e sulla portata dell’impatto sull’ambiente che attraversiamo. O almeno, questo è quello che è successo a me e ciò che mi ha portata a scoprire la cultura del trail-food e della filosofia zero-waste.
Era una delle mie prime traversate in totale autosufficienza, 80 chilometri in uno degli angoli più selvaggi del Trentino. Sulle spalle tutto quello che serviva a sopravvivere, oltre alle solite cianfrusaglie a cui l’escursionista alle prime armi non riesce a rinunciare. Appesantita da scatolame, pasta, vasetti, bustoni di cibo precotto e varie confezioni monodose di colazioni, pranzi e cene, capivo che una scelta non accurata dei viveri non influiva solo sulla resistenza degli spallacci: in quattro giorni avevo prodotto più spazzatura di quanta ne buttassi a casa in settimane. Nelle escursioni di più giorni ti rendi conto di quanti rifiuti produci perché sei obbligato a far posto nello zaino per portarli tutti con te: ne senti letteralmente il peso. A casa, al contrario, hai l’impressione che, una volta differenziato, un imballaggio o una bottiglia vuota smetta di esistere e che non sia più un tuo problema. Ero partita per stare a contatto con la natura in un ambiente selvaggio, ma stavo mantenendo ritmi di consumo peggiori di quelli cittadini; mi sembrava una contraddizione.
Cercando una soluzione più sostenibile, economica e comoda da trasportare ho scoperto il mondo del trail-food fai da te: come autoprodurre e conservare, per lo più con il metodo dell’essiccazione, tutti i tipi di snack e pasti che vengono usati nelle attività outdoor in modo da evitare l’acquisto di prodotti preconfezionati e di conseguenza sfruttare materie prime locali, ridurre lo spreco di imballaggi e risparmiare parecchio peso. Una pratica che nasce tra backpacker e thru-hiker d’oltreoceano dove, a differenza di quanto accade normalmente nei territori alpini, i punti per rifornirsi lungo i più famosi cammini di lunga percorrenza distano normalmente parecchi giorni l’uno dall’altro. Più che di scienza culinaria si tratta di una vera e propria cultura dell’arrangiarsi nella wilderness: un espediente pratico collegato al desiderio di muoversi in totale autonomia e senza lasciare traccia nella vastità incontaminata dei parchi statunitensi.
La sfida dell’autoproduzione mi ha subito appassionata, il tema infatti non riguarda solo l’alimentazione ma rispecchia, in generale, un approccio a basso impatto tanto nella frequentazione dell’ambiente naturale quanto nella quotidianità; se ci si vuole muovere in natura senza lasciare traccia, tenendo con sé tutta (tutta per davvero) la spazzatura prodotta, allora è comodo ridurla al minimo fin dall’inizio, cominciando a seguire abitudini di basso consumo già a casa.

COME FUNZIONA
Alla base delle varie tecniche per autoprodurre alternative casalinghe ai più comuni alimenti preconfezionati troviamo quasi sempre l’essiccazione, uno dei più antichi metodi di conservazione naturale del cibo. Con un buon forno, un essiccatore o un semplice telaio in ambiente caldo e ventilato è possibile disidratare qualsiasi alimento e ad- dirittura un intero piatto già pronto. Tolta la componente umida, il pasto perde la maggior parte del suo peso, mantenendo intatte tutte le proprietà nutritive; e può essere conservato in contenitori ermetici per mesi. Che siano snack, gel energetici fai da te, guarnizioni per panini o pasti completi, gli alimenti essiccati occupano pochissimo spazio e possono essere trasportati in normali sacchetti da freezer riutilizzabili all’uscita successiva. Si consumano così come sono (frutta secca, barrette, chips di verdure) oppure reidratandoli con un procedimento del tutto simile alla preparazione delle più comuni buste di cibo precotto. Il gusto sarà quello di un piatto fatto in casa e ci si ritroverà con parecchi rifiuti in meno da gettare lungo il percorso. Se poi si sceglie di partire da materie prime sfuse acquistate localmente, l’impatto complessivo della preparazione si avvicinerà ancora di più allo zero.
COSA SERVE
Ottenere un pasto pronto fai da te in pochi minuti con attrezzatura e tempi ridotti al minimo è semplicissimo: la prossima volta che preparate un piatto completo a casa, che si tratti di zuppe, cereali, pasta o legumi, aggiungete qualche porzione in più. Quello che avanza può essere essiccato così com’è, conservato in vasetti ermetici e trasferito poi in sacchetti da freezer monodose al momento della partenza (con l’accortezza di sceglierne in plastica resistente alle alte temperature: dura di più e si può utilizzare diverse volte).
Il processo di essiccazione consiste nell’eliminare dal prodotto parte del contenuto di acqua iniziale per mezzo del calore senza però cuocerlo, limitando così i processi di fermentazione e riducendone il volume. La soluzione ottimale per ottenere questo risultato è l’utilizzo di un essiccatore, i cestelli ravvicinati permettono di essiccare grandi quantità di cibo ottimizzando tempi e consumi. Gli stessi effetti, a livello di qualità, si possono ottenere con un forno che funzioni a temperature sotto ai 70 gradi, con l’accortezza di impostare la modalità ventilato oppure lasciando lo sportello socchiuso per favorire la dispersione dell’umidità.
Per consumare un pasto essiccato basta un fornelletto a gas e una gavetta nella quale reidratare il composto a fuoco lento per qualche minuto. Volendo ridurre davvero al minimo tempi di cottura, pentolame e scorte di gas, si può versare l’acqua bollente direttamente nel sacchetto e aspettare una decina di minuti mentre il pasto si reidrata da sé: quest’ultimo metodo prende il nome di freezer bag cooking, funziona meglio con ricette semplici a base di alimenti di veloce cot- tura (come zuppe di cereali, piccoli legumi, verdure e accompagnamento per cous cous) ma permette di avere una cena calda istantanea, completa e gustosa senza accumulare piatti da lavare.
QUALCHE RICETTA
Quadretti energetici al cioccolato
Il freddo aumenta esponenzialmente il fabbisogno energetico e queste barrette ultra caloriche e super golose sono lo snack perfetto da consumare durante una giornata sulla neve.
Ingredienti
/ 125 gr di datteri
/ 2 cucchiai di cacao amaro in polvere
/ 125 gr di mandorle tritate
/ 1 banana
/ fiocchi d’avena sbriciolati per guarnire
Procedimento Frullate i datteri con mezzo bicchiere d’acqua e una banana fino a ottenere una crema densa. Aggiungete il cacao e le mandorle tritate mescolando fino a che l’impasto non sarà uniforme. Stendete l’impasto su un tagliere, formando una sfoglia dello spessore di un centimetro, poi tagliate in quadretti. Ricoprite di fiocchi d’avena sbriciolati facendoli aderire alla superficie dei quadretti. Versione raw: se avete in programma di consumarli a breve, sarà sufficiente lasciarli addensare qualche ora in frigo. Si conservano fino a una settimana. Versione scorta: personalmente preferisco prepararne in gran quantità una sola volta, in modo da avere snack pronti sempre disponibili con poco impegno. In questo caso disponete i quadretti sui cestelli dell’essiccatore per 3 ore a 50 gradi e trasferite poi in contenitori ermetici: dureranno per mesi. Si possono mangiare così come sono, ma risultano meno morbidi; potete togliere dal contenitore la quantità da consumare a breve lasciandola qualche ora in frigo per far riprendere al composto un po’ di umidità in modo che torni alla consistenza iniziale.
Mix di verdure e legumi con cous cous
La soluzione in assoluto più gustosa e più veloce per una cena pronta da bivacco: il cous cous, oltre a garantire energia e pancia piena con poco ingombro, è velocissimo da preparare. Accompagnarlo a un goloso mix di verdure e legumi reidratati sul posto darà tutto un altro sapore alla cena. Solitamente ne preparo in grandi quantità nella stagione estiva, quando le materie prime abbondano ed essiccarle diventa anche un modo per non sprecare le eccedenze dell’orto.
Ingredienti per 4 persone
/ 2 carote
/ 1 melanzana
/ 1 zucchina
/ pomodorini
/ 300 gr di ceci
/ 300 gr di cous cous
Procedimento Dopo aver tagliato le verdure a cubetti, saltatele in padella condendo a piacere per preparare una comune dadolata. Aggiungete i ceci lessati a parte e triturati grossolanamente a fine cottura (se lasciati interi impiegherebbero troppo tempo a reidratarsi). Disponete sui piani dell’essiccatore e lasciatelo in funzione tutta la notte a 60/70 gradi, estraendo il composto solo quando non saranno più presenti tracce di umidità. Si conserva in vasetti chiusi ermeticamente per parecchi mesi. Consumazione e preparazione in viaggio: prima di partire, trasferite la quantità di verdure desiderata in una busta di plastica da freezer resistente alle alte temperature insieme al cous cous e a un pizzico di sale. Una volta giunti a destinazione, sarà sufficiente versare dell’acqua bollente nella busta fino a coprire il composto e lasciar riposare una decina di minuti. Il pasto può essere consumato direttamente dalla busta, e questa si può riutilizzare all’uscita successiva.
Infuso di zenzero e limone
Il gesto ormai automatico quando la sveglia suona per andare a sciare è far bollire l’acqua per il thermos, immaginando già il piacere di una bevanda calda sulla cima. Il grande classico invernale che preferisco è l’infuso di zenzero e limone, energetico e riscaldante, oltre che semplicissimo da preparare.
Ingredienti
/ zenzero essiccato
/ limone essiccato (a buccia edibile)
/ scorze di limone essiccate
/ miele o zucchero
Procedimento Affettate limone e zenzero a fettine sottili e disponeteli sui cestelli dell’essiccatore (3 o 4 mm di spessore) per almeno 3 ore a 50 gradi. Una volta essiccati, sbriciolate il tutto e chiudetelo in vasetti ermetici: la scorta di infuso è pronta e durerà tutto l’inverno. Preparate la bevanda seguendo il normale procedimento di infusione, lasciando uno o due cucchiai del composto in acqua bollente per qualche minuto e aggiungendo un dolcificante a piacere.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 134

Arthur Conan Doyle, un passo alpino sugli ski
È incredibile come certe persone possano essere visionarie, ahead of their time, in anticipo sui tempi, come direbbero oltre oceano. Lo è stato sicuramente Arthur Conan Doyle. In un articolo pubblicato su The Strand Magazine (VIII, July-December 1894, pp. 657-661), che pubblichiamo a seguire, con divertente humour british, 126 anni fa, l’autore del più famoso detective di tutti i tempi, Sherlock Holmes, aveva già intuito le formidabili potenzialità di due assi di legno, ma soprattutto il potere che hanno sull’anima e sul nostro benessere. Arthur Conan Doyle aveva scoperto lo sci durante una lunga e forzata vacanza in Svizzera dove la moglie Louise era in cura per la tubercolosi.
Non v’è nulla di particolarmente insidioso nell’aspetto di un paio di ski. Si tratta di due lingue di legno d’olmo lunghe otto piedi e larghe quattro pollici, munite di coda quadrata, punta all’insù e legacci al centro per assicurare i piedi. A guardarli, nessuno immaginerebbe le possibilità che nascondono. Ma vi basterà calzarli, rivolgere un sorriso agli amici per controllare che vi guardino, e subito dopo cadrete di testa in un cumulo di neve e scalcerete come dannati fino a rimettervi in posizione più o meno stabile, per poi ricadere rovinosamente su quello stesso cumulo, con il risultato di offrire agli amici un divertimento di cui non vi sareste mai creduti capaci.
Questo succede agli inizi. È normale in quella fase mettere in conto guai, i quali non tardano ad arrivare. Man mano che si va avanti, però, la faccenda si fa più irritante. Gli ski sono gli oggetti più capricciosi della terra. Un giorno fila tutto liscio. Un altro, pur essendo immutate le condizioni di clima e neve, va tutto storto. Ed è quando meno ve lo aspettate che gli imprevisti sono in agguato. Ve ne state in cima a un pendio e disponete il corpo a una rapida discesa, ma gli ski s’incollano al terreno facendovi capitombolare di testa. Oppure vi trovate lungo un plateau che sembra piatto come una tavola da biliardo, quando all’improvviso, senza né cause né segnali, essi schizzano in avanti lasciandovi a terra a guardare il cielo. Su un uomo che dia segni di eccessivo amor proprio, un assaggio di scarpe da neve norvegesi potrebbe avere un ottimo effetto morale.
Quando vi preparate a cadere, state pur certi che non accadrà mai. Ritenetevi spacciati quando vi sentite affatto sicuri. Arrivate a un pendio di ghiaccio vivo, con un’inclinazione di settantacinque gradi, e lo salite a zigzag conficcando le lamine degli ski, sapendo che se una zanzara vi si posasse addosso sareste finiti. Ma non succede nulla e arrivate in cima sani e salvi. Vi fermate in piano a congratularvi con il vostro compagno e avete solo il tempo di dire «Che veduta meravigliosa!» prima di ruzzolare di schiena e ritrovarvi con gli ski incrociati attorno al collo. O ancora, vi capiterà di compiere una lunga escursione senza infortuni, dopodiché, tornando lungo la pista, vi fermerete ad annunciare il vostro successo a un gruppo di persone sulla terrazza di un albergo. Basterà un nonnulla, e d’un tratto quelle persone si troveranno a rivolgere i complimenti alla spatole dei vostri ski. Se non avete la bocca piena di neve, per trovare un qualche conforto non vi resterà che snocciolare i nomi di un po’ di paesini svizzeri. Ragatz potrebbe fare al caso vostro ed evitare uno scandalo.
Ma tutto ciò appartiene alle prime fasi dell’uso degli ski. Dovrete pattinare in piano, muovervi su per i pendii a zigzag o alla maniera di un granchio, scivolare senza perdere l’equilibrio e soprattutto curvare con agilità. Al primo tentativo di curvare, gli amici penseranno che fate i buffoni. Il grande volteggio in aria sugli ski ha un aspetto fra i più insoliti, come una sfrenata danza tribale. Eppure quel repentino scodinzolo è veramente la più necessaria delle manovre, perché solo così è possibile curvare sul fianco della montagna senza scivolare. Mai porgere i talloni al pendio: è questa la sola maniera per farlo.
Fatto sta che, disponendo di perseveranza e di un mese libero nel quale superare tutte le prime difficoltà, si giungerà a credere che gli ski aprono un orizzonte di sport che è, a mio avviso, unico. Non riscuote ancora apprezzamento, ma sono convinto che un giorno centinaia di inglesi verranno in Svizzera per la stagione dello ski, in marzo e aprile. Credo di potermi dichiarare il primo, a eccezione dei due svizzeri di cui vi parlerò, ad aver compiuto traversate in montagna sulle scarpe da neve (seppure su distanza piuttosto modesta), ma senz’altro non sarò l’ultimo, anzi mi seguiranno migliaia di persone.
Il fatto è che in inverno scalare una normale vetta e compiere la traversata di valichi alpini è più facile che in estate, a patto che il tempo resti sul bello. In estate dovrete sia salire che scendere, e le due fasi sono egualmente faticose. In inverno la fatica è ridotta a metà, poiché buona parte della discesa è una semplice pattinata. È molto più semplice salire zigzagando con gli ski sopra una neve passabilmente compatta, anziché scarpinare su per i massi sotto un cocente sole estivo. Inoltre la temperatura invernale è più propizia all’esercizio, poiché nulla è tanto delizioso quanto l’aria tonificante e pura delle montagne, purché, naturalmente, s’indossino gli occhiali per proteggersi dal brillio della neve.
Il nostro programma era di andare da Davos ad Arosa attraversando il Passo della Furka, a oltre novemila piedi di altezza. In linea d’aria il tragitto non supera le dodici-quattordici miglia, ma in inverno è stato compiuto soltanto una volta, quando, lo scorso anno, i due fratelli Branger lo percorsero sugli ski. Erano loro i miei compagni nella spedizione che descriverò di seguito, i più fidati cui un novizio potesse sperare di accompagnarsi. Sono entrambi uomini di notevole resistenza, capaci di non soccombere neanche a una lunga esposizione al mio tedesco.
Svegli già prima delle quattro, alle quattro e mezzo eravamo in cammino per il paesino di Frauenkirch, dove avremmo attaccato l’ascensione. Una grande luna pallida splendeva nel cielo violetto, punteggiato di quelle stelle che è possibile ammirare soltanto ai Tropici o sulle cime più alte delle Alpi. Alle cinque e un quarto deviammo dalla strada per scarpinare sulla salita, dove si alternavano distese ancora coperte d’erba e chiazze di neve. Gli ski li portavamo in spalla, gli scarponi da ski attorno al collo, poiché si progrediva spediti sulla neve dura, là dove il sole aveva picchiato durante il giorno. Qui e là, in corrispondenza di una conca, affondavamo fino alla cintola in un manto soffice, ma nel complesso la marcia procedeva facilmente, e finché la pista attraversò un’abetaia fu impossibile calzare gli ski. Attorno alle sei e mezzo, dopo una lunga e continua sfacchinata, uscimmo dai boschi e poco dopo passammo davanti a una malga di legno, l’ultimo segno di presenza umana che avremmo visto fino ad Arosa.
Poiché sui pendii la neve era ancora abbastanza dura da offrire un buon appiglio ai nostri piedi, proseguimmo veloci sopra ondulati campi di neve che tendevano generalmente a salire. Più o meno alle sette e mezzo il sole rischiarò i picchi alle nostre spalle e il bagliore su quella grande distesa immacolata si fece accecante. Scendemmo per un lungo tratto e poi, giunti al corrispondente versante esposto a settentrione, trovammo la neve soffice come polvere e così alta che il bastone non toccava il fondo. Fu lì che calzammo le scarpe da neve e zigzagammo su per il lungo e candido fianco della montagna, per poi fermarci in cima a riposare. Sono oggetti utili gli ski, poiché, vedendo che la neve era ancora abbastanza dura da reggerci, li convertimmo in un comodissimo sedile, dal quale ammiravamo la vista di un completo circo di montagne, i cui nomi il lettore sarà contento di sapere che ho completamente dimenticato.
La neve si ammorbidiva rapidamente sotto i raggi solari, così che senza le scarpe la progressione sarebbe stata impossibile. Ci inerpicavamo sul ripido fianco di una valle e la bocca del Passo della Furka ci stava grossomodo di fronte. La neve lassù si posava a un’angolazione di cinquanta-sessanta gradi e poiché quello scosceso pendio lungo il quale scarpinavamo precipitava in un baratro, scivolare poteva essere rischioso. I miei compagni più esperti mi lasciarono camminare più a monte per quel mezzo miglio circa che durò il pericolo, ma presto sbucammo su una salita più leggera, dov’era possibile cadere senza gravi conseguenze. E allora sì che cominciammo veramente a usare le nostre scarpe da neve. Fino a quel punto avevamo camminato alla stessa velocità di un paio di scarponi, però su un terreno dove gli scarponi non sarebbero passati. Ma adesso assaporavamo un piacere che gli scarponi non potranno mai regalare. Per un terzo di miglio pennellammo curve che solcavano delicatamente la neve, schizzando fino a valle senza muovere i piedi. In quel grande deserto inviolato, dove campi di neve facevano da cornice alla nostra vista su tutti i lati e dove non si scorgevano tracce di vita che non fossero le impronte di camoscio o di volpe, fu glorioso sfrecciare in quel modo agevole. Un breve zigzag ai piedi della china ci condusse, alle nove e mezzo, alla bocca del passo, e vedemmo i piccoli alberghi giocattolo di Arosa, laggiù in fondo tra le abetaie, migliaia di piedi sotto di noi.
Avevamo ancora grossomodo mezzo miglio, che percorremmo trascinandoci dietro i bastoni. Mi pareva che la parte difficile del viaggio fosse finita e che dovessimo soltanto stare in equilibrio sugli ski e farci portare a destinazione. Eppure fu lì che arrivarono i guai. La discesa si fece sempre più ripida, fino a precipitare in quello che per un soffio non era un burrone bell’e buono. Ma è appunto in ragione di quel soffio, là dove sia coperto di neve soffice, che è possibile sfruttare in un altro modo le meravigliose lingue di legno. I fratelli Branger concordavano sul fatto che il tratto era troppo difficile perché tentassimo di attraversarlo con gli ski. Quanto a me, mi pareva che la sola opzione possibile fosse un paracadute, ma mi limitai a fare quello che facevano i miei compagni. Si tolsero gli ski, li allacciarono l’uno all’altro con i legacci e li capovolsero per ottenere una slitta alquanto rudimentale. Ci sedemmo sopra, conficcando i talloni nella neve e premendo forte i bastoni dietro di noi, e cominciammo a scendere lungo lo scosceso versante del passo. Penso che i miei compagni giunsero a pentirsene, visto che arrivati al fondo erano bianchi come la moglie di Lot. Ma ero alle prese con guai così impellenti da non avere tempo per curarmi di loro. Cercai di moderare la velocità dei miei balzi premendo il bastone, il che ebbe l’effetto di far ruotare di lato la slitta, facendomi sbandare giù per la discesa. Fu così che ficcai i talloni nella neve e venni catapultato all’indietro, dopodiché in un lampo i miei ski, legati assieme, schizzarono come una freccia da un arco, oltrepassarono i Branger con un sibilo e svanirono sulla china dirimpetto, lasciando il proprietario carponi nella neve fonda. Sui campi più alti, dove i cumuli di neve vanno dai venti ai trenta piedi, poteva essere un incidente sgradevole, ma nel mio caso la ripidità era un vantaggio, perché lì la neve non si accumulava in grandi quantità. Scesi il tratto che mi restava alla mia maniera.
A detta del mio sarto, l’Harris Tweed non si logora mai. È una pura teoria, che non reggerebbe a un esperimento scientifico dotato di tutti i crismi. Brandelli della sua merce si trovano esposti, infatti, dal Passo della Furka ad Arosa, e per il resto di quel giorno fui particolarmente felice di camminare rasente ai muri.
Tuttavia, se non si conta che uno dei Branger si era slogato la caviglia nel corso della discesa, andò tutto bene e arrivammo ad Arosa alle undici e mezzo, dopo un viaggio di sette ore spaccate. Gli abitanti di Arosa, sapendo del nostro arrivo, avevano messo in conto che prima dell’una non ci saremmo fatti vivi, e così uscirono per assistere alla discesa del ripido passo più o meno quando noi finivamo un lauto pranzo al Seehof. Non starò qui a rimproverarli per un divertimento innocente, ma vi dirò che fui felice di sapere che il mio piccolo spettacolo fosse finito prima che loro si riunissero muniti di binocolo. Senza un pubblico, ce la si cava ottimamente durante un nuovo esperimento sugli ski.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 133
Godere delle stesse cose
La pandemia ha stravolto tutto. Anche il mio modo di vivere lo sci. Nella primavera scorsa, di ritorno dalle Antille dopo una traversata atlantica con la mia vecchia barca a vela, non vedevo l’ora di sciare. Dopo mesi di assoluta libertà sull’acqua sono piombato, impreparato, in pieno lockdown duro. Le montagne intorno a casa sembravano di panna montata e io non potevo che stare a guardarle. Non capivo bene perché potessi solo andare al supermercato, poi mi hanno spiegato che se mi fossi fatto male sciando, gli ospedali erano pieni. Ho pensato che con 74 anni di sci alle spalle, senza mai usare il casco, non mi ero mai rotto un osso e che forse era più facile che mi facessi male cadendo dalle scale. Ho anche pensato che sarebbe stato meglio che fossi rimasto a navigare oltreoceano, anziché rientrare in una Italia infetta. Confesso che, non avendo capito bene la gravità della situazione, la voglia di trasgredire si è fatta sentire, forte. Ho programmato fughe notturne con gli sci sulle spalle, un po’ come ai vecchi tempi, quando si partiva dalla città ancora addormentata, dopo una notte brava, per qualche gita demenziale.
Un po’ come i miei amici di Livigno (non posso fare nomi) che sono riusciti in quei giorni a eludere i controlli, effettuando un perfetto raid in sci. Soffrendo non poco, ho aspettato la fine di aprile per iniziare la stagione scialpinistica. Le necessità di distanziamento, unita all’età e allo scarso allenamento, mi hanno portato a ripetere più volte in solitaria itinerari collaudati come la classica salita a Punta Rocca in Marmolada. Proprio io che non ho mai amato vivere lo scialpinismo da solo e ripetere gli stessi itinerari. Speravo di chiudere bene allo Stelvio a fine giugno con il Tuckett ma ho trovato una coda chilometrica di giovani atleti alla funivia e così ho dovuto accontentarmi dei bei pendii ripidi di Cima Nagler, dove un tempo ci si allenava a fare lo speciale con i pali rigidi. Bilancio di fine stagione tutto sommato positivo, come pretendere di più in questi mala tempora! Però niente raid di rifugio in rifugio, che sono la forma di sci che prediligo in primavera. Tutto rimandato a chissà quando. Lo sci, ai tempi della pandemia, perde purtroppo la dimensione di continua scoperta propria dei raid e il piacere del viaggio vissuto con gli amici, il che non è certo poco. O forse sono io che non sono capace di vivere altrimenti questa dimensione di plenitudine dello sci? La pandemia solleva in me questi dubbi profondi.
Poi arrivò l’estate, e sembrò che il peggio fosse passato. Ho ordinato gli sci nuovi,
sci da ragazzetto, sognando il prossimo inverno. Ma, con l’autunno, apriti cielo! I contagi sono ripresi alla grande e finalmente ho capito la gravità della situazione ed i rischi che, soprattutto alla mia età, stavo correndo. La paura del contagio è diventata una costante e la pratica dello sci nulla di più che un modo per evadere, almeno per qualche ora, dall’incubo. La fortuna ha voluto che la neve arrivasse copiosa già ad inizio dicembre a soli 950 metri di altitudine, dove abito. Nel timore, anzi nella certezza, che durasse poco ad una quota così bassa, ho sciato fino a notte fonda sul prato illuminato davanti a casa, risalendo il pendio con una manovia di una cinquantina di metri. Poche curve ma di alta qualità su di una bella polvere mi hanno proiettato nel mondo bianco della mia infanzia sciatoria. Quando instancabile andavo su e giù su di un prato simile a questo, a Sauze d’Oulx, allora perfetto paese di montagna, risalendo decine di volte il pendio a scaletta, senza l’aiuto di manovie, di skilift o degli orribili e diseducativi tapis roulant che infestano oggi i campi scuola. Quando prendevo orgoglioso, bardato da sciatore, il tram 22 con il mio papà e, attraversata tutta Torino, si arrivava al capolinea di Sassi.
Di qui si proseguiva con la cremagliera di Superga. Che discesa il vallone di Cartman dove adesso corre la strada del traforo del Pino! Un freeride per palati fini fra le vigne ed i muretti a secco. Su e giù più volte come dei matti, intervallate dalle code di sciatori alla biglietteria.
Poi, come previsto, il caldo è ritornato e la neve davanti a casa si è sciolta quasi tutta. Per superare il senso di smarrimento dato dal rivedere l’erba verde del prato sono salito più in alto, sfidando il pericolo dei cani lasciati liberi nei masi sopra il mio, fino a raggiungere i bellissimi boschi esposti a nord della Panarotta, la piccola stazione in crisi non tanto per il lockdown quanto per una cronica mancanza di idee. Ho risalito con le pelli più volte le piste deserte, ho respirato a pieni polmoni l’aria pulita, ho ritrovato il profumo della neve e del lariceto. In fondo mi basta questo, ho pensato che la pandemia è servita a qualcosa, a farmi rivivere i piaceri delle brevi e semplici gite d’altri tempi, nell’incanto bianco di boschi vivi e silenziosi.
Ho trovato assurdo che la seggiovia fosse ferma a causa dei divieti. Ma lo sci non è uno sport individuale all’aria libera? Capisco chiudere le cabinovie, i chiassosi ritrovi lungo le piste, le discoteche. Ma perché anche le seggiovie e gli skilift? Che male fanno? Ho provato addirittura un’istintiva solidarietà con i pistaioli chiusi in casa e con i gestori di questa vecchia seggiovia, ora ferma fino a chissà quando. Anche se a me tutto sommato va bene così, perché posso risalire quando voglio con le pelli la pista deserta. Arriva dunque, con il Natale, il regalo della nuova raffica di decreti governativi che vietano anche i più innocui spostamenti in auto. Ecco riaffacciarsi imperiosa la voglia di trasgredire. Una voglia che mi riporta ai miei anni migliori, quando godevo a salire e scendere alte montagne senza permessi. Con gli sci nuovi appesi alla prodigiosa e-bike e gli scarponi da telemark nello zaino risalgo da casa le forestali che raggiungono la neve. Ancora gli stessi pendii, gli stessi boschi, gli stessi dislivelli con le pelli, le stesse curve. Ormai mi è chiaro che la pandemia impone di godere delle stesse cose, dei microcosmi che la montagna sempre sa offrire. È come essere in un supercarcere dotato di un grande parco giochi. È come vivere in un mondo chiuso, in una bolla surreale che ha assunto le dimensioni di una artificiosa normalità.
Potrò ancora partire, viaggiare, rivivere i grandi spazi, le grandi traversate con gli sci? Mi rimane poco tempo per farlo, alla mia età. I grandi spazi a cui continuo, imperterrito, ad anelare, oggi mi sembrano così distanti, così difficilmente raggiungibili, che non so rispondere. Nell’attesa che qualcosa cambi e di sentirmi nuovamente libero, ecco una bella notizia: la neve ha ripreso a cadere copiosa sul prato davanti a casa. Polvere sopraffina, un vero regalo. Posso riprendere senza indugio la ricerca di quella curva lenta che prolunga al massimo il piacere del fruscio dei fiocchi di neve sotto le solette degli sci. Una curva ideale che descrive tutto il bello dello sci, alla faccia della pandemia. È la ricerca della curva perfetta.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 134
Saper apprezzare il silenzio
«Stavamo attraversando, a 800 metri di quota, il tratto periferico di un ghiacciaio dal nome impronunciabile - sulla carta c’è scritto Øksfjordjøkelen - e la temperatura nell’arco di poche centinaia di metri era crollata di parecchi gradi rispetto ai pendii più vicini alla costa. Davanti a noi, e anche dietro, e di fianco, montagne senza nome rese ancora più cupe dalla luce bassa del sole. A febbraio, oltre il Circolo Polare Artico, il sole si alza ben poco sopra l’orizzonte: anche a mezzogiorno le ombre sono lunghe come al tramonto. Ci stavamo spostando con gli occhi ben aperti e la consapevolezza di essere gli unici esseri umani in giro, a parte la cinquantina di abitanti che occupano il piccolo insediamento portuale e altri quattro sciatori, ospitati come noi da Morten. Per raggiungere la civiltà, da qui, occorrono due ore di traghetto e altrettante di pullman, sempre che il mare non sia agitato o la strada non venga chiusa per le valanghe: e per civiltà sto parlando di Alta, ventimila anime distribuite con una media di cinque abitanti per chilometro quadrato. Ci sentivamo soli, anzi, di fatto lo eravamo: quella solitudine che uno sciatore cerca e, quando la trova, lo posiziona a metà strada tra l’esserne affascinato o intimorito».

Su Skialper 135 di aprile-maggio pubblichiamo lo straordinario reportage di Federico Ravassard da Bergsfjord, un minuscolo villaggio nella wilderness norvegese dove si va a sciare usando anche la barca. «La sera stessa in cui arriviamo capiamo di essere finiti in un lunapark per bambini troppo cresciuti: i canali più vicini sono letteralmente sopra il paese e le pelli si mettono direttamente sull’uscio di casa. Per arrivare a quelli più lontani, invece, ci pensa Nicky, la piccola barca bianca e arancione che usiamo il giorno successivo per muoverci fino al punto di partenza. Il briefing prima di salpare è essenziale ma efficace: se si dovesse cadere in acqua durante la navigazione avremmo non più di una decina di minuti di autonomia prima di passare all’altro mondo per l’ipotermia, sempre nel caso in cui non fossimo già affogati».

Federico è stato ospite nel lodge di Morten Christensen, sciatore e skipper norvegese che ha percorso tutta la costa del Paese in barca a vela, alla ricerca dei migliori sport per unire le sue due passioni. E del silenzio. «A posteriori si capisce che una delle qualità necessarie per vivere qui sei mesi all’anno è la stessa che viene richiesta agli sciatori o ai velisti: sapere apprezzare il silenzio, nella sua accezione più ampia possibile, quella di assenza delle cose. Dei suoni, delle trasmissioni, a volte anche delle altre persone o di attività a esse collegate. Quel tipo di silenzio ti permette di concentrarti di più e di entrare a contatto con l’essenza di quello che stai facendo. La pagina di un libro, uno sci che scorre sulla neve in salita, un’onda che si infrange sullo scafo. Sarebbe superfluo dirvi di venire in un posto come Bergsfjord per le sue montagne incontaminate: il senso di un luogo così sta nel suo essere silenzioso».

Sciatori del secondo tipo
«In fondo tutti sappiamo che esistono due tipi di sciatori. Quelli che smettono e quelli che in realtà non smettono mai. O se smettono è solo per un attimo, per quel periodo che si fa sempre più lungo tra l’ultima lingua di neve e la prima nevicata. Una parentesi, diciamo. Un cartello Torno subito fuori dal locale».
Ecco, visto che ci avviciniamo alla fine della stagione, l’articolo Sciatori del secondo tipo di Saverio d’Eredità, che pubblichiamo su Skialper 135 di aprile-maggio, è proprio d’attualità. Perché è proprio nelle prossime settimane che si vede la vera passione. «Perché di sciatori ce ne sono di due tipi. Ovvero quelli che sciano diciamo fino all’ora legale, la chiusura impianti o finché gli alberi non mettono fuori le foglie, che quando vedono lampeggiare 20 °C sul cruscotto o hanno l’appuntamento del cambio gomme, dicono beh la stagione è finita. E quegli altri.
Quelli che la stagione per certi versi a quel punto inizia, che si svegliano alle 3:33 e scendono dal letto lacerando i propri sogni per seguirne altri. Che - ça va sans dire - gli sci iniziano la gita sempre sullo zaino». Un racconto leggero su un tipo di sciatore nel quale molti di noi si immedesimeranno. Una riflessione tra il serio e l’ironico, senza la pretesa di dare un giudizio.
«Non è questione di chi sia meglio o peggio, chi ha ragione o chi torto. Anzi, i primi mi sa che se la vivono sicuramente meglio. Sono inseriti nella società, godono di un certo consenso, sono spesso molto bravi perché sciano al posto giusto nel momento giusto e non soffrono il cambio di stagione. Spesso hanno auto ben in ordine, interno ed esterno, e di solito l’arbre magique.
Quegli altri, quelli del secondo tipo invece, l’auto è facile che la puliscano due volte l’anno e tengano i finestrini abbassati a primavera per non svenire dalla puzza di scarpone bagnato. Quegli altri devono sempre trovare una buona scusa e spesso per giustificarsi fanno gli arroganti, ma in realtà soffrono dentro. Avvertono disagio nel caldo che monta, nell’aria opalescente dei pomeriggi di pianura, disorientati dal non poter più seguire linee bianche sui primi rilievi all’orizzonte».
Robert Antonioli: «I soldi spesi meglio sono quelli dei viaggi»
«Mi piacerebbe provare a diventare Guida alpina, sicuramente. Mi mancano dei pezzi, come il ghiaccio, per esempio, perché da novembre, quando scatta davvero la stagione agonistica dello scialpinismo, rispetto abbastanza rigorosamente le tabelle di Davide Canclini e metto un po’ da parte l’alpinismo, ma d’estate cerco di imparare sempre qualcosa in più, di rubare qualche accorgimento dai miei compagni d’uscita. Anche l’idea dell’allenatore mi affascina: Luca (Dei Cas, scomparso nel 2015 in un incidente in montagna, ndr) ha tolto ore alla sua famiglia per noi quando eravamo adolescenti e a me ha fatto solo del bene. Fare altrettanto io per altri giovani sarebbe una sorta di passaggio di testimone».

Ipse dixit, parola di Robert Antonioli. Siamo stati a trovare il fresco vincitore della Coppa del Mondo di scialpinismo nella sua Valfurva, ci ha anche portato nella baita della nonna che d’estate serve per la fienagione, ma anche buen retiro per qualche festa con gli amici della Forba. Con Luca Giaccone Robert ha parlato del suo futuro, ma anche del presente agonistico e della formula di allenamento del Centro Sportivo Esercito, del passato e dell’infanzia. Robert è un professionista rigoroso, ma non fissato. Se nella chat dello sci ripido o in quella del freeride arriva una chiamata, lui è pronto a rispondere presente se c’è da fare un canalino o per una giornata tutta pow-pow con gli sci larghi. Perché in fondo le gambe vanno ancora più forte se non sei concentrato solo sui numeri di una scheda d’allenamento. E i risultati lo dimostrano. «Questa è fatica che mi piace. La montagna è la mia vita e voglio che continui a essere così anche in futuro. In che modo devo ancora capirlo bene, adesso sono concentrato sulle gare di skialp, ma sarà sicuramente così». Ma dove vuole arrivare il Robert alpinista? «Nel futuro mi ispirano Himalaya e Patagonia, e sarà un discorso da affrontare a fine carriera con l’Esercito e con i membri della Sezione Militare di Alta Montagna che si occupa proprio di quello. Dico sempre che i soldi spesi meglio sono quelli dei viaggi».
L’articolo completo, con le le originali foto di Achille Mauri, è su Skialper 135 di aprile-maggio.

Focaccia & lamine
«Sono gli ultimi giorni dell’anno e quattro millimetri di neoprene ci separano dal contatto diretto con l’acqua. È l’ennesima giornata con il cielo color acciaio, ma non c’è vento e le onde sono buone. L’affollamento in acqua, tra disposizioni di legge e temperature rigide, non è, almeno quello, un problema di questo periodo. Tra un set di onde e l’altro, in acqua si parla delle solite cose: di come l’ultimo mese sia stato un continuo susseguirsi di perturbazioni, di quanto sia fastidioso rimettersi la muta quando è ancora fredda e bagnata ma di quanto sia fondamentale riuscire a concedersi di tanto in tanto una valvola di sfogo, soprattutto adesso che per noi genovesi la montagna, intesa come freeride e neve fresca, è un irraggiungibile miraggio».
Nasce così, in acqua ad aspettare l’onda giusta per cavalcarla con il surf, l’idea di andare con la tavola nella prima località raggiungibile da Genova, in un inverno di lockdown, a Santo Stefano d’Aveto. Pochi chilometri e Alberto Carmagnani & crew si ritrovano lontani migliaia di chilometri da quel mare, in un paesaggio che ricorda mete lontane dove la powder è di casa per lunghi mesi. Il viaggio-vicino, con compagni con i quali non avresti mai pensato di andare a disegnare curve nella neve fresca. «Non ero mai andato in montagna con Alessandro, Andrea e Filippo e probabilmente senza le restrizioni del Covid non ci sarei andato mai. Alessandro, surfista e snowboarder con una forte propensione verso la fluidità delle linee, quando eravamo più giovani aveva aperto un negozio di attrezzatura da snowboard sulla spiaggia di Priaruggia che in breve tempo era diventato un riferimento. Andrea è un istruttore di surf torinese, da qualche anno trapiantato in Liguria spinto dalla passione per il mare».
Così, per un giorno, le onde da cavalcare sono quelle disegnate a bordo pista dai gatti delle nevi. «Le nuvole passano veloci e l’arrivo della vecchia funivia è un androne riparato dal vento che ci permette un confortevole cambio di assetto e di finire la meritata, ma decisamente decontestualizzata, focaccia. La discesa è come sempre troppo breve, ma le poche curve della parte alta sono per tutti qualcosa di cui avevamo bisogno e che pensavamo non avremmo vissuto ancora per chissà quanto tempo».
Su Skialper 135 di aprile-maggio il racconto con testo e immagini di una giornata incredibile a due passi da casa.

Appesi a un filo
«Se hai la gamba allenata, Campo Imperatore è la chiave per tornare liberi. Soprattutto se hai la fortuna di vivere in una città come L’Aquila, altrimenti te la rischi. In barba a DPCM, zone gialle, arancioni o rosse, basta andare nella frazione di Assergi e prendere la funivia del Gran Sasso che in questo inverno di località sciistiche chiuse è sempre rimasta aperta. Il segreto è semplice da spiegare: è un trasporto pubblico, come una metropolitana o un tram. Così, rispettate le regole della capienza ridotta, non c’è nessuno che sta a sindacare se sali vestito da sci o con le scarpe da ginnastica e i sacchetti della spesa». Inizia così l’articolo di Luca Parisse sul Gran Sasso e le opportunità che ha offerto a scialpinisti e freerider nell’inverno della pandemia. Diciotto pagine da leggere e soprattutto da guardare che pubblichiamo su Skialper 135 di aprile-maggio.

«Non avrei mai pensato di dovere fare un’ode alla funivia, io che, con la mia compagnia, gli impianti li uso al massimo per cercare qualche linea nella polvere o ridurre il dislivello della pellata - scrive ancora Parisse - Però quella fottuta funivia per noi è stata la lampada d’Aladino per salvare una stagione innevata come poche volte negli ultimi anni. Salire sulle cabine con i vetri graffiati dalle punte degli sci, appannati dentro e gelati fuori, è stato un po’ come prendere l’aereo e volare lontano, in un’altra dimensione. Anche se il viaggio è di poco più di tre chilometri».
La funivia di Campo Imperatore immette nella dimensione uno, quella dei fuoripista dei Valloni o della Valle Fredda, adatti ai freerider e a chi vuole fare pellate molto corte. Poi… poi c’è la dimensione due, quella del Pizzo Cefalone, della Sella del Brecciaio o del Corno Grande, con dislivelli e canali che non hanno molto da invidiare a quelli alpini.

Lost in Hokkaidō
«Una settimana dopo il nostro arrivo nelle cuore dell'isola ci siamo trovati immersi in una valle stretta e carica di neve e abbiamo sciato su entrambi i lati della strada che la taglia in due. È una valle lontano da tutto, in una delle zone più selvagge e nevose dell’Hokkaido. Era quello che cercavamo: abbiamo pellato e sciato pendii ripidi ricoperti dalla quintessenza delle betulle bianche giapponesi dall’alba alle tenebre. Eravamo solo noi, non una traccia, non uno schiamazzo».

Inizia così l’ampio reportage sull’Hokkaido di Mattias Fredriksson che pubblichiamo su Skialper 135 di aprile-maggio. Frediksson, profondo conoscitore della zona da 15 anni, nel febbraio del 2020 è partito proprio alla ricerca dei luoghi più autentici, lontano dal resort frequentati dagli occidentali dove dopo le nevicate c’è la lotta per tracciare nella neve fresca. Così ha fatto base ad Asahikawa, la seconda città più grande dell’Hokkaido ed è partito alla scoperta di valli lontano da tutto e da tutti e della favolosa cucina giapponese. Quella autentica… Diciotto pagine da leggere ma soprattutto da guardare.

Il comprensorio sciistico senza impianti
Tra le poco più di mille anime di Kremmling, a 125 miglia da Denver, i cappelli con scritto Trump 2020 sono più popolari dei caschi da sci. Eppure a mezz’ora da questo sonnolento villaggio del West, lungo la strada per Steambot Springs, nel bel mezzo di una steppa fangosa, lo scorso dicembre ha aperto quella che potrebbe diventare una pietra miliare nell’evoluzione di un’industria multi-milionaria, come ha scritto Simon Usborne sul Financial Times. L’idea è semplice da immaginare quanto complicata da mettere in pratica: la prima località sciistica human powered o, come preferisce definirla Erik Lambert, co-fondatore di Bluebird Backountry con Jeff Woodward, a backcountry light ski area, un comprensorio sciistico per avvicinarsi allo scialpinismo. Bluebird Backountry ha aperto i battenti per due settimane di test nella scorsa primavera, a febbraio e marzo, al Whiteley Peak, nel Peak Ranch, e dopo un migliaio di skipass venduti, per il 40 per cento a persone che non avevano mai messo le pelli sotto i piedi, ha affrontato la sua prima, vera, stagione sciistica. Sempre su una proprietà privata, all’interno dello stesso enorme ranch, ma in un’area leggermente diversa da quella del marzo scorso, sulla Bear Mountain.
Poco meno di 400 metri di dislivello, cinque chilometri quadrati, il 15 per cento di discese verdi, il 35 per cento di blu, il 40 per cento di nere e il 10 percento di double black diamond (che nelle località sciistiche americane sono paragonabili alle nostre nere, visto che nella classificazione manca il colore rosso). L’unica differenza rispetto a un tradizionale ski resort è che non ci sono seggiovie o telecabine, ma sette tracce di salita con le pelli. E che il terreno è completamente naturale, nessun albero è stato abbattuto per fare spazio alle discese. Per il resto è tutto molto simile: un parcheggio, dove dal giovedì alla domenica è consentito dormire sul proprio van, un base lodge ospitato in una calda tensostruttura, il noleggio dell’attrezzatura, il posto di primo soccorso, i bagni (chimici), un food truck e dei barbecue all’aperto. Non manca una mid mountain warming hut, una specie di baita con bagni chimici, barbecue, posto di primo soccorso e ski patrol lungo le discese. Oltre all’area inbound, messa in sicurezza, ci sono altri 12 chilometri quadrati ai quali si può accedere solo accompagnati da una Guida. Bluebird sta per chiudere la sua stagione e in pochi giorni, prima dell’apertura, sono stati venduti 500 skipass stagionali. Lo stagionale, in pre-vendita a 299 dollari (successivamente 350) garantisce l’accesso sempre, mentre il giornaliero, che costa 50 dollari, richiede la prenotazione.

Bluebird sembra l’asso nella manica nell’inverno del distanziamento perché prevede la presenza massima di 200 persone e si passa la maggior parte del tempo all’aperto, ma l’idea è nata molto prima della pandemia. Erik e Jeff, rispettivamente 37 e 38 anni, si sono conosciuti al Darthmouth College. Nel 2018 lanciano un’indagine online, alla quale rispondono 3.000 sciatori, poi degli eventi per testare il concetto, per un totale di 6 giornate, anche all’interno di alcuni comprensori sciistici, come Winter Park. A gennaio 2020 Erik e Jeff raccolgono più di 100.000 dollari con una campagna su Kickstarter, il 330 per cento dell’obiettivo che si erano prefissati, e la scorsa primavera ecco l’esperimento delle due settimane al Whiteley Peak. «Impariamo dall’esperienza, da un giorno all’altro abbiamo cambiato anche 15-20 protocolli, per esempio ora le tracce di salita sono doppie, perché la gente vuole parlare mentre sale, ma la prima sfida se vuoi creare una località sciistica, anche quelle con gli impianti, è trovare un bel posto con il terreno giusto e tanta neve, vicino al tuo pubblico potenziale, ed è un lavoro enorme - dice Erik – Così l’anno scorso eravamo al Peak Ranch per capire se i pendii e la neve fossero quelli giusti per la nostra clientela».
Oltre al distanziamento naturale c’è un altro motivo per il quale il concept di Bluebird Backountry è tremendamente attuale in un inverno nel quale non pochi sono passati dalle piste al mondo del fuori. «Vediamo che c'è molta differenza ad avvicinarsi allo scialpinismo in modo soft, come permettiamo qui, oppure in maniera più tradizionale. Nel secondo caso, se le persone non hanno un mentore, un amico esperto con il quale iniziare, si trovano a dover scegliere tra un corso costoso che dura quattro giorni e che li spaventa o evitarlo e andare direttamente in montagna e non è un bene. Quello che abbiamo cercato di creare è uno spazio dove le persone si sentano benvenute e possano avvicinarsi allo scialpinismo sviluppando abilità e abitudini, dai materiali, alla progressione, alle inversioni, sostanzialmente imparare ad affrontare la montagna aperta». Così, accanto al comprensorio inbound, Bluebird offre due tipi di corsi, le lezioni di backcountry, suddivise in tre livelli, che durano mezza giornata o una giornata e costano 69 o 79 dollari, e i corsi di sicurezza e autosoccorso certificati AIARE (The American Institute for Avalanche Research and Education), suddivisi in tre livelli, con moduli di uno o tre giorni. Nel corso base di backcountry si imparano a conoscere i materiali, le pelli e la tecnica ed è rivolto a chi non ha mai fatto skialp, mentre il livello due è per chi ha già praticato e si concentra sul miglioramento della tecnica di salita e discesa e i rimedi per i problemi ai materiali. Infine il livello tre riguarda la programmazione della gita e l’osservazione della montagna ed è la porta d’entrata ai corsi sulla sicurezza. Rivolgendosi prevalentemente a chi si vuole avvicinare allo scialpinismo, Bluebird Backountry propone anche il noleggio di sci, scarponi, splitboard e dell’attrezzatura di sicurezza ed esiste uno skipass giornaliero comprensivo di noleggio e corso base che costa 199 dollari, mentre per esperienze nella natura che circonda il compren- sorio si può acquistare il pacchetto che prevede la presenza di una Guida per tutta la giornata, al costo di 950 dollari e da dividere fino a sei persone.
Bluebird è un’idea che viene da lontano ed è solo all’inizio della sua parabola. Nella testa di Erik ci sono già tante idee, non solo a misura di beginner. «Il nostro progetto a lungo termine è di creare un comprensorio interessante come quello delle migliori stazioni sciistiche, ma interamente human powered, e questo significa terreno ampio e vario, tanta neve, insomma un resort dove le persone possano migliorare la loro tecnica e la loro educazione allo scialpinismo, ma anche per gli scialpinisti con più esperienza che cercano una montagna meno selvaggia dove divertirsi». Forse non sarà il futuro su larga scala dell’industria multi-milionaria dello sci di massa, ma, come ha scritto Usborne, potrebbe effettivamente essere una pietra miliare, che indica la strada. Però, come ogni curva nella neve fresca è diversa e ogni otto non perfettamente sovrapponibile, anche Bluebird Backcountry non è un concetto così facilmente replicabile. Erik ne è convinto. «È un progetto che nasce dalla passione, sappiamo quanto è difficile trovare il giusto terreno; c’è ancora tanto lavoro, ma andiamo avanti perché abbiamo avuto segnali incoraggianti. C’è il rischio che una società più grande di noi copi il concetto che stiamo sviluppando anno dopo anno, magari una località sciistica? Ovviamente sì, ma i resort si concentrano su quello che sanno fare meglio, cioè gestire impianti per portare tanta gente sulle montagne, invece noi cerchiamo di creare un’esperienza unica, esclusiva. Immagina di non essere mai andato a sciare e di arrivare da solo in un comprensorio sciistico, senza amici, in un enorme parcheggio. Gli scarponi devi metterli prima di salire sul minibus che porta agli impianti o dopo? Poi arrivi al lodge e cosa devi fare? Come funziona l’attrezzatura? E gli impianti? Non c’è nessuno che ti aiuti a meno di spendere tanti soldi per prendere una lezione. Noi cerchiamo di creare un’esperienza amichevole perché ci mettiamo tanta attenzione e passione. Fondamentalmente vogliamo creare un ambiente completamente diverso». Stay hungry, stay foolish… stay backcountry.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 133

Il Villaggio degli Alpinisti a due passi dal Sellaronda
Sono fortunato, molto fortunato. Vivere in Alta Badia, per chi ama lo sci, l’arrampicata e le Dolomiti, è il massimo. Certo, sono tante le valli e i paesi che mi piacciono e dove ho trascorso molto tempo, dalla Val di Zoldo alla Conca Ampezzana, dalla Val di Fassa alla Val Gardena e ogni posto ha qualcosa di speciale e delle montagne uniche. Ma qui si è proprio al centro di tutto. Il centro di un territorio incredibile dove è facile muoversi attraverso i passi e raggiungere le valli vicine. In inverno l’esteso sistema di impianti e collegamenti consente di spostarsi facilmente alla ricerca della neve migliore, raggiungendo in breve la Marmolada, il Sella, la zona del Lagazuoi e tante altre aree limitrofe con una scelta di itinerari senza paragoni. Avete presente la comodità di partire da casa a piedi, utilizzare gli impianti e poi le pelli per sciare lungo qualche canale sul Sella e a fine giornata rientrare percorrendo una Val Mezdì o Val Setus al tra- monto? E con rientrare intendo proprio fare l’ultima curva sulla soglia del garage!
Ok, qualcuno potrebbe dire: certo, ma c’è tanta gente, confusione, non vorresti più pace e tranquillità? In effetti in alta stagione il Sellaronda attira tanti sciatori da tutto il mondo e, se si vogliono utilizzare gli impianti, si deve sempre fare i conti con la popolarità del comprensorio. Per fortuna però la Val Badia si trova tra due grandi parchi naturali, il parco di Fanes - Sennes - Braies ad Est e il Parco Puez - Odle a Nord-Ovest. Queste due grandi aree naturali e sistemi Unesco sono un vero paradiso per lo scialpinismo e per allontanarsi dalla confusione. La zona di Fanes è molto apprezzata e conosciuta anche a livello internazionale, offre tanti itinerari prevalentemente di stampo classico e, grazie ai suoi comodi rifugi in quo- ta, è ideale per le traversate di più giorni. Per esempio quella di Fanes - Sennes - Braies che dalla Val Badia arriva al famoso lago di Braies e che è diventata ormai una grande classica dello scialpinismo in Dolomiti. Ma è del Puez che vorrei parlarvi e in particolare della valle di Longiarù, in ladino Val da Lungiarù. Questo è un posto speciale ed è qui che mi piace andare per trovare la tranquillità vicino a casa. Il parco Puez - Odle non ha rifugi aperti in quota come Fanes e le gite si effettuano in giornata dalle valli. Se gli accessi dal versante della Val Gardena e dall’Alta Badia sono facilitati dagli impianti, che permettono di alzarsi in quota verso i confini del parco, sugli altri versanti le gite iniziano dal fondovalle o al più da qualche strada che sale alle numerose e caratteristiche frazioni. La valle di Longiarù, in particolare, è quella che offre il maggior numero di itinerari e si presta molto bene a un soggiorno scialpinistico di qualità. Qualità nel soggiorno, perché i ritmi e l’atmosfera sono quelli di un turismo più lento e rilassato, ma soprattutto qualità nella varietà dello sci, perché qui, oltre alle gite facili nel bosco e su terreno aperto, sono tanti i canali dolomitici e gli itinerari di stampo più moderno. Non per niente Longiarù è stato riconosciuto come Villaggio dell’alpinismo.

Ma cosa significa? I Villaggi dell’alpinismo sono un’iniziativa dei Club Alpini e nascono da un progetto del Club Alpino austriaco. Più precisamente «le località riunite nell’iniziativa Villaggi dell’alpinismo sono pioniere dell’alpinismo nelle loro regioni. Per questo motivo le montagne e l’alpinismo hanno un grande valore nell’immaginario culturale dei nativi del posto e dei loro ospiti. Qui la consapevolezza dell’armonia necessaria tra la natura e l’uomo è ancora viva e si manifesta nel rispetto dei confini naturali». Per essere inseriti nella lista, i comuni devono rispettare criteri rigorosi, impegnandosi nell’attuazione del protocollo della Convenzione delle Alpi (un documento stipulato tra gli otto Stati alpini e l’Unione Europea, che ha come fine lo sviluppo sostenibile e la tutela delle Alpi). Una filosofia che va oltre il semplice marketing turistico, ma spazia a 360 gradi dall’edilizia alla mobilità, ai trasporti, all’agricoltura, alla tutela del paesaggio e della cultura locale. E al centro di tutto c’è l’attività outdoor, estiva e invernale, nel rispetto della natura. Vi invito a leggere e approfondire, perché credo che sia veramente la filosofia a cui bisognerebbe puntare in tante località, soprattutto in funzione dei cambiamenti climatici. Non che io sia contrario agli impianti di risalita, anzi, li uso per piacere e per lavoro e sono sicuramente la miglior risorsa del turismo invernale per gran parte delle Alpi. Ma ha senso costruirne ancora in zone dove non ce ne sono? Capisco l’aggiornamento e miglioramento di quelli esistenti, nei comprensori che funzionano, ma non è meglio in tante valli puntare su un turismo diverso, più sostenibile, visto che gli esempi di successo non mancano? Siamo solo scialpinisti, alpinisti, escursionisti, non sta a noi decidere, ma alla fine è la domanda che crea l’offerta. Se privilegiamo luoghi come Longiarù o la Valle Maira o una delle altre località che puntano a sviluppare un turismo diverso, contribuiamo a segnare la strada verso il futuro. Vi sembra qualcosa di irrealizzabile? Forse, ma vi sareste mai aspettati un mondo così diverso, e in così poco tempo, a causa di una pandemia?
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 133

Alpi selvagge
Ventitré anni fa usciva per la BLV Verlag di Monaco un libretto polemico intitolato Berg Heil. Heile Berge? Rettet die Alpen di Reinhold Messner. Venne pubblicato in Italia quattro anni dopo, per la Bollati Boringhieri di Torino, col titolo Salvate le Alpi. Erano anni intellettualmente vivaci in cui si iniziava a raccogliere le idee per delle Alpi nuove: ci si avvicinava alla Convenzione europea del Paesaggio, e si iniziava finalmente a capire che forse era il caso di lasciarsi alle spalle i vecchi modelli turistici novecenteschi, insieme al secolo che stava per finire. Insomma, stava nascendo quel gruppo di dieci, forse quindici intellettuali che dicevano le cose che ripetiamo ancora noi oggi. Erano storici, antropologi, climatologi e così via, per lo più torinesi, che da lì a dieci anni si sarebbero ritrovati uno a fianco all’altro tra le pagine del periodico Dislivelli.
Tutto questo però avveniva lontano dalle pareti, dalle falesie, dai canali ghiacciati, dai sentieri. Sì, in mezzo a loro c’erano anche alpinisti, ma restava un mondo per qualche ragione troppo alto e inaccessibile, soprattutto per quei nuovi frequentatori che iniziavano a gironzolare tra le montagne: dei ragazzi che vestivano largo, che portavano il cappellino da baseball al contrario, che parlavano una lingua di strada, e soprattutto che non ascoltavano il Coro della SAT. Poi anche i ragazzini sono cresciuti, le informazioni sono diventate più accessibili e, soprattutto, il mondo ha iniziato ad andare sempre più convinta- mente in una direzione diversa. Il risultato è che le cose che dicevano vent’anni fa quei dieci o quindici illuminati, oggi sono nella bocca di un sacco di persone, di qualsiasi target. Talvolta per sentito dire, talvolta consapevolmente, talvolta fintamente. Fatto sta che ormai c’è tanta gente che ne parla e, per quanta potesse essercene al tempo, oggi ce n’è dieci volte di più: basta impianti, basta infrastrutture, basta sfruttamento del paesaggio, basta commercializzazione dell’outdoor, ma cura per le zone abbandonate, per un’economia lenta, per un turismo di prossimità, colto, consapevole e così via.
Però nessuno aveva ancora fatto il grande salto. Perché il problema di tutta questa roba qua è che è tutto fuori che semplice, e ci sembra un grande salto nel vuoto. Come tutti i cambiamenti. E sembra un salto nel vuoto soprattutto per quelli che di questa roba ci devono campare. E sebbene esista un turismo nuovo, ed esista un outdoor nuovo, sebbene ci sia in realtà già tutto un sistema capace di rendere le Alpi un luogo più inclusivo, sebbene tutta questa roba qua esista, e abbia dimostrato di funzionare, non viene ancora vista come un’alternativa con la A maiuscola. Poi però quest’anno è successo qualcosa. Ed è successo che tutto quel sistema, vecchio, superato, supportato artificialmente con fondi pubblici, è stato spazzato via da una cosa che nessuno si era immaginato. E che non solo ha spazzato via tutta quella roba là, ma è come se ci avesse puntato il dito sopra per dirci: vedete? Di tutte queste cose fareste bene a dimenticarvene.
Come tutte le crisi, questa ha colpito soprattutto i settori che stavano in piedi non si sa bene come, i castelli di sabbia. Però ha accelerato dei cambiamenti che erano comunque già in atto. E così facendo, quasi senza volerlo, ci ha creato su misura quell’inverno che fino ad ora avevamo soltanto letto nei libri, e che sognavamo da tempo; vale a dire senza quel turismo mangia e bevi, fatto di trenini rossi, di impianti, di piste, e di après-ski, che portano soldi, ma ne portano via di più. Il problema è che rimarranno indietro anche un mucchio di persone, ma questo succede con tutte le crisi. Per questa ragione non basta starcene a guardare quel mondo crollare, ma dovremmo anche iniziare a dare fiducia alle alternative di cui si parlava prima. E questo lo dovremmo fare prima di tutto noi come frequentatori. Insomma, abbiamo l’opportunità di rivedere le nostre priorità, di lasciarci alle spalle tutte le inutili sovrastrutture di cui ci eravamo circondati e soprattutto di avere delle Alpi spoglie e selvagge come non lo erano più da un secolo.
Abbiamo avuto un’estate senza gare, che ci ha ricordato la ragione per cui corriamo e per cui andiamo in montagna. E che ci ha riportato a una dimensione originaria della corsa, senza gonfiabili e premi finisher. Le Alpi di questa stagione invernale sono Alpi selvagge, siamolo noi altrettanto.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 133