Lettera da Sauris
«Sono arrivata quassù forse per destino. Avevo un paio di ore di buco per un’intervista saltata durante una trasferta a Sauris e la voglia di scoprire quella frazione che non avevo mai visto. Era un’occasione da sfruttare anche perché nella valle del Lumiei, dove la Carnia si spinge verso il Cadore, bisogna venirci apposta. Era inizio marzo, c’erano il sole e la neve. Sono salita a Lateis senza davvero sapere cosa aspettarmi. Ho trovato un silenzio tangibile, una cinquantina di case con in mezzo una chiesetta e, intorno, una natura potente. I prati, chiusi da boschi di faggio e di abeti, e poi le montagne, più rocciose e potenti a Sud, più morbide verso Nord. Arrivata in cima, alla borgata Ameikelan, ho notato uno stavolo, una vecchia stalla con il suo fienile, in posizione strategica: non solo davanti al Tinisa, la montagna che protegge Lateis, ma affacciato sul Bivera. Il Bivera si distingue dalle altre Alpi Carniche per la forma svettante, per il tratto di cengia orientale rossa di ammoniti. In sintesi, per la sua bellezza. Da quello stavolo, la vista sul Bivera era indubbiamente perfetta. Sono passati quattro anni e il Bivera ora lo ammiro praticamente da ogni finestra di casa, dallo stavolo scoperto in quella luminosa giornata di marzo».

A Sauris il distanziamento è da sempre uno dei leit-motiv, lo sa bene Anna Pugliese, che ha scritto per Skialper una delle lettere da che pubblichiamo da Skialper 132 di ottobre-novembre . Di sciate, qui, se ne fanno parecchie. Anche perché si parte dai paesi già a una buona quota: 1.240 metri per Lateis, 1.212 per Sauris di Sotto, 1.398 per Sauris di Sopra. Il distanziamento fisico è garantito: gli abitanti sono meno di 400, c’è turismo, sì, ma non è certo opprimente. Puoi salire e scendere senza incontrare nessuno. «Il problema, spesso, è che ti tocca batter traccia». Quello che fanno Francesca Domini e Marco Stefanuto, che gestiscono un’azienda agricola che crea formaggi di capra e si sono sposati nel maggio del 2011 quasi in sella al Bivera, dove erano saliti con don Piller, il parroco sciatore di Sauris, e il suo cane, Fox. Anche loro sono alcuni dei (pochi) fortunati local. Ne parliamo su Skialper 132 di ottobre-novembre.

Lettera dal Gennargentu
«Mentre sulle Alpi si cerca di combinare una salita nei giorni seguenti la nevicata, a queste latitudini, forse per paura che la neve si sciolga prima di averla toccata, si parte durante la nevicata stessa. Questo costringe già a tragicomici avvicinamenti in auto, su strade ovviamente non spazzate (in Sardegna si mormora di un fantomatico maialetto delle nevi che ripulisce le strade dopo la nevicata, ma noi non lo abbiamo mai visto!)».

Si può fare scialpinismo sul Gennargentu? Sì, almeno ci si può provare. Ed è un’esperienza che ha a che fare con lo scialpinismo di scoperta e molto con il ravanage. Ne sa qualcosa Maurizio Oviglia, che ha scritto per Skialper 132 di ottobre-novembre una lettera dal Gennargentu, ricordando le tante avventure tra filo spinato, fango e neve che sparisce a vista d’occhio. Oviglia parla del versante settentrionale del Bruncu Spina. «Ricordo una salita al Bruncu Spina da Nord dove, prima di raggiungere un pendio degno di questo nome, dovetti combattere per un’ora su un sentiero a ostacoli costituiti da filo spinato e muretti a secco. Alla base del pendio mi misi la cuffia, attaccai l’ipod con un pezzo di potente jazz rock, e mi sparai i 500 metri per cui ero venuto, tutti d’un fiato. Mi ero finalmente sfogato, ma sulla discesa meglio calare un pietoso velo». Poi sono arrivati i tentativi da Desulo e da Correboi. «Ci saranno stati 5 centimetri di neve e avevo oltrepassato 45 muretti di pietre con filo spinato; non ci crederete ma li avevo contati. In discesa mi si ruppe il vecchio scarpone come fosse un uovo di cioccolato (del resto l’attrezzatura buona l’avevo lasciata a Torino) e cercai di scendere alla meglio nella macchia mediterranea, mirando alla macchina. A un certo punto un cinghiale mi si parò davanti agli sci. Rimasi un attimo interdetto, ero sempre armato di bastoncini, avrei reso cara la pelle. Per fortuna con uno scatto si infilò nel bosco: provai a inseguirlo, a quel punto speravo in un ingresso in paese da eroe. Ma sapeva sciare meglio di me e lo persi…». Ora Maurizio ha smesso di partire con gli sci e le pelli alla scoperta del Gennargentu, ma in fondo quel sue peregrinare tra cinghiali, filo spinato e Mufloni usando gli sci come mezzo di trasporto è uno degli ingredienti che rendono lo skialp così bello, anche quando la neve non è proprio come nelle foto di copertina di Skialper.

Waffle, powder e wilderness
«È come muoversi in una tazza di latte. Il vento soffia, nevica di traverso e ho freddo. Non vedo molto, le croci rosse che segnano il percorso sono l'unico indizio che mi indica dove andare e a volte scompaiono del tutto nella desolazione bianca e infinita. Forse non è stata una buona idea fare un giro con gli sci oggi, ma dopo il lungo viaggio fino a Björkliden, nella Lapponia svedese, 195 chilometri a Nord del Circolo Polare Artico, volevamo sgranchirci le gambe e prendere un po' d'aria fresca».
A scrivere è Mattias Fredriksson, autore anche delle stupende fotografie. Nell’articolo Waffle, powder e wilderness, su Skialper 132 di ottobre-novembre, parliamo del Låktatjåkka Mountain Lodge, una casa di legno nero circondata da enormi muraglie di neve a 1.228 metri sul livello del mare. È il rifugio più alto della Svezia e, per la cronaca, bisogna sapere che la montagna più alta del Paese, il Kebnekaise, è di soli 2.097 metri. Il Låktatjåkka è una base perfetta per spettacolari escursioni in uno degli ultimi angoli selvaggi d’Europa. Oltre che una baita gourmet dove provare dei deliziosi waffle. Dormire al rifugio comporta un’esperienza un po’ diversa per lo scialpinista, perché si è a poche centinaia di metri di dislivello dalle vette, così la maggior parte del dislivello bisogna farla il pomeriggio per rientrare alla base.
«Stare al rifugio trasmette un senso di intimità. Gli ospiti e il personale la sera si incontrano nel soggiorno e nel bar per leggere e parlare. Si arriva a conoscersi tutti, soprattutto perché non c'è internet e gli smartphone non hanno praticamente campo. Invece ci sono un sacco di buoni libri e una selezione sorprendentemente di birra, vino e whisky di qualità. La cucina è di livello e si possono provare i piatti svedesi, a partire dalla carne di renna e alce». Appuntamento in edicola con Skialper di ottobre-novembre.

Dentro il van
«Un van è come un figlio. Quando lo scegli, lo vivi fino in fondo. Non è il tuo mezzo di trasporto, non è il tuo status symbol. Non è solo il viaggio alternativo. È ciò che ti rappresenta. E contiene te stesso».
Scrive così Veronica Balocco nell’articolo Dentro il Van, su Skialper 132 di ottobre-novembre. Veronica è un vanlifer da sempre e ha cambiato diversi mezzi. Chi meglio di lei per raccontare la vita in van e in camper d’inverno? Oltre gli stereotipi e la moda social, non c’è dubbio che il camper è il mezzo dell’anno, perché in sintonia con il momento che stiamo vivendo. Sono in molti quelli che affrontano la montagna in inverno dormendo su quattro ruote. E molti quelli che vorrebbero farlo… «Viaggiare, e passare del tempo, su un van d’inverno richiede una certa attitudine allo sgamo». Dalla scelta del carburante, che spesso alimenta anche il sistema di riscaldamento, agli pneumatici e alle batterie di servizio.

«Oltre a questo mare magnum di insegnamenti in continua evoluzione, il van mi ha regalato anche qualcosa di diverso. Ed è forse la cosa più importante. Obbligandomi a guardare la vita da uno spazio minimale poggiato su quattro ruote, mi ha costretta a rivedere gesti normali. E a dare una nuova visione a tutto quello che sembra banale» scrive ancora Veronica. Per esempio parcheggiare evitando che lo spazzaneve depositi muri di cemento sulle ruote, farsi la doccia centellinando l’acqua e cercando di non bagnare troppo attorno, asciugarsi i capelli tenendo conto del voltaggio… Insomma la vita in camper va oltre le foto di mezzi da sogno e l’appeal glamour degli oltre otto milioni di hashtag #vanlife. Veronica racconta le sue esperienze, dispensa consigli, affronta la scelta del mezzo, le disposizioni per il parcheggio nelle località sciistiche e nella natura. Insomma 14 pagine di vademecum con la leggerezza di un racconto e le belle fotografie di Federico Ravassard che ha immortalato outdoor addicted del calibro di Cala Cimenti, Enrico Mosetti e Paolo Marazzi con i loro mezzi. Skialper 132 è acquistabile anche nella nostra edicola digitale.


Chiude Powder Magazine
Anche per uscire di scena hanno scelto lo stile leggero e inconfondibile che ha attraversato come un filo rosso tutti i 49 anni della loro storia, con la foto in bianco e nero di una ragazza che sorride e guarda la neve che cade dal cielo. Un po' come Radiofreccia che chiude un minuto prima di compiere 18 anni. La notizia, prima diffusa dal passaparola di Instagram e anticipata in un interessante articolo di Steve Casimiro, a lungo anima della rivista e ora editore di Adventure Journal, è ufficiale: Powder Magazine cesserà le pubblicazioni (e di conseguenza anche l’aggiornamento del sito internet e dei canali social) a partire dal prossimo 20 novembre. La comunicazione è arrivata venerdì scorso con una email ai dipendenti da A360 Media LLC, il gruppo editoriale (editore anche di tabloid e testate generaliste ad alta tiratura) di cui fanno parte Bike, Surfer e Snowboarder, altre testate che verranno chiuse.
«Non sappiamo se e quando questo iato finirà - scrivono sul sito della rivista statunitense - Sappiamo, però, che abbiamo ancora da lavorare e due numeri della rivista da fare». Il 16 novembre uscirà l’ultimo Photo Annual, il marchio di fabbrica di Powder, dal quale sono passati tutti i grandi nomi della fotografia di sci fuoripista e che ha creato mode e stili.
Powder ha attraversato epoche, mode, crisi, mantenendo sempre uno stile originale e producendo contenuti di qualità, nonostante il passaggio di diverse proprietà. «Sì, abbiamo giocato molto. Ma abbiamo anche lavorato molto, e credo di poter parlare a nome di tanti di noi quando dico che quelle serate passate a lavorare fino a tardi sono state magiche. Stressanti, sì, ma allo stesso tempo eravamo nella nostra piccola bolla, una manciata di persone unite nel tentativo di creare qualcosa di speciale e a suo modo importante» ha scritto Steve Casimiro. La parabola della rivista si è incrociata più volte con quella delle grandi case editrici nordamericane con numeri, obiettivi e costi sempre più inconciliabili con il mondo della neve e degli sport outdoor dove sopravvivono - negli States come in Europa - gli editori indipendenti. La crisi portata dalla pandemia ha fatto da detonatore. Proprio negli stessi giorni sul sito di Backcountry Magazine, altra rivista di riferimento nordamericana e principale competitor di Powder, è bene in evidenza un editoriale nel quale la redazione al completo sottolinea come la buyer’s guide uscirà con i consueti standard di qualità ma 16 pagine in meno, tutte di pubblicità, e chiede di sostenere i piccoli editori indipendenti. Il direttore editoriale della casa editrice di Backcountry, Tyler Cohen, ha scritto un interessante articolo sulla chiusura di Powder. «Il monitoraggio regolare di Powder ha portato in parte al nuovo logo e allo stile di copertina di Backcountry, ridisegnato l'anno scorso; ci ha spinto a includere più storie in ogni numero; (...) Powder ha contribuito a plasmare Backcountry, ben oltre la direzione di Adam Howard, CEO di Height of Land (editore di Backcountry, ndr), con la consulenza di Steve Casimiro». «Per 43 anni, Powder ha fatto tutte queste cose e le ha fatte molto, molto bene. Ora il mondo dello sci sarà più povero» conclude Cohen.
«Non sappiamo cosa ne sarà di Powder, solo che la sua assenza per un certo periodo di tempo sarà pesante per chi di noi è rimasto affascinato dalle sue parole e dalle sue immagini lungo il viaggio di 49 anni - scrive Sierra Sfaher, editor in chief della rivista - Ci auguriamo che vi abbia offerto una casa; un luogo dove gli sciatori possano venire per l'umorismo, la riflessione, l'ispirazione, l'onestà, e un piccolo assaggio della gioia che sappiamo si può trovare solo, come hanno scritto i redattori che fondarono la rivista, nell'allontanarsi dalla folla verso un luogo dove non ci sono linee, non ci sono impianti, non ci sono recinti e altri sciatori. Solo neve».
Auguriamo alla redazione di Powder di riuscire a trovare una forma per riaffermare il suo spirito libero, perché, come hanno scritto Dave Moe, Jake Moe e Bruce Bailey sul primo editoriale della rivista, per noi powder significa libertà, con un'enfasi non su come esserlo, ma solo su come esserlo sempre di più.
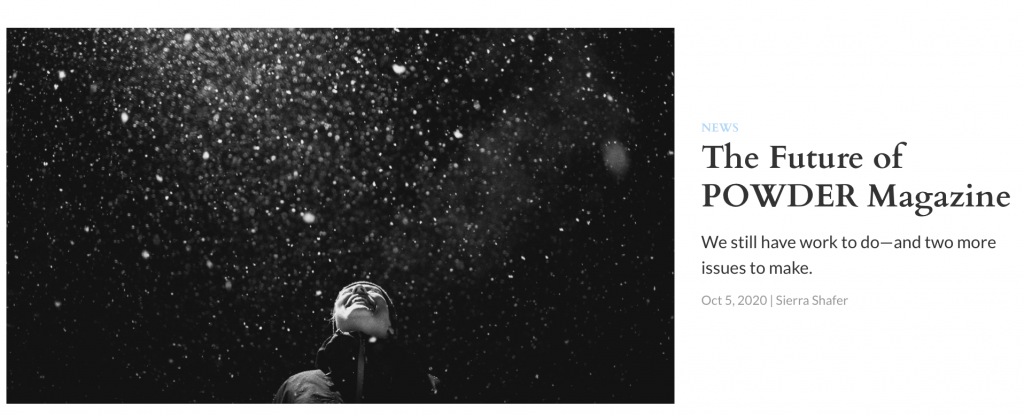
Al via la nona edizione del Blogger Contest di Altitudini
«Il metodo è la cronaca, il fine è la letteratura: la cronaca viene utilizzata per i fini letterari e per offrire ai lettori un contesto reale, multiforme e dalle molteplici declinazioni e manifestazioni». È questa la base dell’edizione numero nove del blogger contest di Altitudini, il principale incubatore di talenti letterari legati alla montagna. Un’edizione che stravolge i canoni adottati fino a oggi perché dopo contest nei quali «vi abbiamo chiesto di partecipare con un racconto di finzione − i fatti descritti potevano anche non essere realmente accaduti − in questa edizione vogliamo confrontarci con un genere, il reportage narrativo, in cui l’autore ha fatto esperienza diretta dei fatti e li descrive attraverso gli strumenti narrativi».
Un reportage come piace a noi di Skialper, con tre comandamenti: camminare, osservare, raccontare. Perché camminando si ha una visione delle realtà completamente diversa. «Potete raccontare qualsiasi cosa abbiate visto e di cui siete stati testimoni, oppure che vi è stata raccontata perché eravate a caccia di quella storia. Storie di quotidianità che ci portano dentro la vita delle persone, che contengono un potere speciale perché sappiamo essere reali. Una sola regola, le storie del vostro reportage narrativo devono incontrare le montagne» dicono gli organizzatori.
Il contest è diviso in tre categorie: racconto breve, audio storie e web comics. Skialper, insieme a Suunto, premierà il primo classificato nel racconto breve con 500 euro e la pubblicazione del racconto sulla rivista nel corso del 2021. Simona Righetti, che dirige la nostra casa editrice con il compagno Davide Marta, fa parte della giuria insieme a Luisa Mandrino, Matteo Melchiorre, Ornella Bellucci, Gianluca Costantini e Alice Martinelli. Si può partecipare al blogger contest fino al 31 dicembre e il regolamento è qui.
Il blogger contest ha anche fatto da incubatore per il nuovo progetto editoriale della nostra casa editrice, AA Arcipelago Altitudini / Storie di Montagna. Ha le fattezze di un libro, ma nell’idea di periodicità è inteso come una rivista, contenuti curati con i tempi di un libro e impaginati con gli elementi di grafica, le illustrazioni e le immagini fotografiche di una rivista. AA è un contenitore di racconti, ma anche di saggi narrativi, di poesie, di foto reportage e di graphic novel con tema la montagna nei suoi diversi aspetti e significati. Un insieme di tante storie eterogenee e voci diverse, in cui scrittori affermati si affiancano a esordienti, componendo un vero e proprio affresco, un racconto sfaccettato e originale sulla montagna, per scoprirla, approfondirla e per lasciarsi ispirare.

Lontano dalle tracce
«Il raid degli amici ha iniziato a fare capolino nella mente di François qualche inverno fa, così un gruppo di persone si riunisce ogni anno per qualche giorno per sciare e scoprire un massiccio. È un’esperienza per uomini, non ci sono ragazze e Layla è l'unica donna a essere accettata perché sa sciare, bere vino e raccontare stronzate o fare battute pesanti come i ragazzi. Ma il raid degli amici non è solo scherzi e vino, si scia molto anche se il biglietto d'ingresso è un magnum di rosso o champagne nello zaino. Qui niente barrette energetiche e bevande vitaminiche, è come una versione hard core della Sentinelle. I protagonisti sono per lo più Guide alpine, cercatori di cristalli, alpinisti, medici del Soccorso alpino. Insomma, il livello atletico e sciistico è alto. Basti pensare che a volte del gruppo ha fatto parte anche Hélias Millerioux…».

Introduce così Bruno Compagnet il raid degli amici in Val Maira e Val Varaita. Qualche giorno lontano dalle code per firmare la powder di Chamonix, lontano dalle responsabilità, tra amici, per riscoprire i valori più autentici dello scialpinismo, quelli che non verranno mai meno. Discese, silenzio, bufere, villaggi popolati da cani e gatti. Nelle 14 pagine con le coinvolgenti foto in bianco e nero di Layla Kerley c’è l’anima dello skialp. E nelle sei pagine a seguire una mini-inchiesta di Federico Ravassard sulla Val Maira, icona di un turismo slow e human powered che si candida a paradigma del turismo alpino del futuro. Appuntamento su Skialper 132 di ottobre-novembre.


Transamericana
Probabilmente per la prima volta Salomon TV abbandona il format del cortometraggio per un film di 75 minuti. Lo fa con uno straordinario tempismo perché il viaggio di corsa e a piedi di Rickey Gates dalla South Carolina alla California, Transamericana, è un pellegrinaggio alla scoperta di un Paese che Rickey si rende conto di non conoscere, soprattutto quel cuore degli States dove è radicato il successo di Donald Trump. E Rickey parte da Folly Beach il primo marzo del 2017, poco dopo quell’elezione, per scoprire non solo i luoghi, ma soprattutto le persone, per capire, per conoscere meglio se stesso.
Il primo tempismo, voluto, è quello di andare alla scoperta degli States più profondi con il più antico mezzo di locomozione dell’uomo, i piedi, nel momento in cui ci si interroga sull’esito delle prossime elezioni. Il secondo, ancora più potente e non voluto, è che Transamericana è tutto quello che ci manca ora: abbracci, dialoghi con sconosciuti o amici, senza timore, senza mascherina, senza diffidenza e distanza. «Sono partito pensando di essere più diverso che simile e sono tornato pensando di essere più simile che diverso» dice Gates. Ecco, in fondo il segreto di Transamericana è proprio questa sfilata di persone, parole, stili di vita che si parano davanti ai passi leggeri di Rickey. Dopo un’ora abbondante quello che ti rimane dentro è proprio il senso del viaggio, della corsa come mezzo, per scoprire, per cambiare, per spurgarci da tutte le schiavitù quotidiane, per essere pienamente presenti in quel momento e in quel luogo. Certo poi ci sono gli straordinari panorami del deserto dello Utah o delle Montagne Rocciose, ma passano quasi inosservati, perché c’è anche tanta pianura tutta uguale o foreste di robinie degli Appalacchi, ma soprattutto perché c’è l’America delle persone prima ancora che dei luoghi.
Le soggettive di Rickey inquadrano volti, case, auto, negozi. Un diario on the road fatto di up & down, di momenti belli e difficili, quando senti di avere dato tutto e il tuo fisico non risponde più, quando per attraversare il deserto ti ingegni prima con un caddie da golf e poi con un passeggino e un ombrellino per trasportare un po’ d’acqua. Quando capisci che non puoi correre di notte e dormire di giorno semplicemente perché fa troppo caldo anche per dormire e trovi la soluzione più equilibrata (no spoiler). Quando devi dormire fuori, hai solo un poncho che serve anche da tenda e nevica. I appreciate è la parola più utilizzata da Rickey, apprezzo. Apprezzo il vostro interesse per me, il vostro aiuto, anche solo spirituale. «Sono le persone più povere quello che sono pronte a darti di più» osserva Gates. Cinque mesi e 3.700 miglia in 75 minuti, da Folly Beach a Ocean Beach a San Francisco, con la delicata curiosità di Gates e la collaudata regia di Wandering Fever. Per trovare la risposta al perché andiamo raminghi con le scarpe da trail. Da vedere.
Effetto Albedo, il cuore oltre la linea
Una volta - che poi sarebbe solo qualche anno fa - gli sciatori frequentavano forum e siti su cui postare le proprie uscite e confrontarsi su temi più o meno seri nascosti sotto nickname improbabili tipo Powder_Boy o Marietto82. Poi il mostro di Zuckerberg ha fagocitato anche loro e tutti, o quasi, hanno cominciato a utilizzare Facebook anche per sapere chi avesse sciato cosa, quando, su che neve. Ai ragazzi di Effetto Albedo ci sono arrivato così, vedendo amici o amici di amici che venivano taggati nelle loro uscite. Non nascondo di averli guardati all’inizio con un certo scetticismo, sembravano l’ennesimo gruppo di amatori presi bene, tutti powder e GoPro. Poi le cose si sono fatte più chiare: questa è gente che scia un sacco e scia pure bene. Per sciare bene intendo dire la capacità di sapere scegliere le linee, andando a posare i propri sci e le proprie split in montagne poco o per nulla frequentate e su neve spesso più bella di quella che trovano gli altri. Insomma, ho dovuto ammettere a me stesso che la mia disistima altro non era che una malcelata forma di invidia e ammirazione. Probabilmente perché in montagna viene più facile storcere il naso che battere le mani. Nel frattempo loro continuavano a martellare una linea dopo l’altra, spesso su cime dai nomi sconosciuti e tuttavia dietro l’angolo, situate tra l’alto Piemonte e la Val d’Aosta: postacci in cui solo chi aveva voglia di fare fatica andava a infilarsi. E già questo spezzava una lancia a loro favore, perché se nel variopinto mondo dei social network ci sono quelli che parlano e quelli che camminano, con le loro uscite esplorative stavano dimostrando di appartenere alla seconda categoria.
L’occasione per conoscerci di persona è arrivata quest’anno, durante un ciclo snervante di alta pressione che ha colpito pressoché tutto l’arco alpino. Quei periodi in cui chi può si dedica ad altro, va ad arrampicare o a pedalare. O, come nel caso di Effetto Albedo, si continua imperterriti a cercare linee, magari spostandosi sui versanti sud alla ricerca di neve primaverile nonostante il calendario indichi che siamo a metà gennaio. L’appuntamento è anche lui disallineato con la stagione: ore 4.30 al parcheggio di Ivrea. Mi incontro con Flavio e Paolo, più tardi ci raggiungeranno Francesco e Stefano, rinvigoriti da ben mezz’ora di sonno in più. La direzione è la Valpelline, la meta è stata scelta con lo stesso criterio delle precedenti, che grossomodo può essere riassunto con un abbiamo visto un bel canale di cui non si sa nulla sul versante Sud del Monte Berrio. Mi fanno vedere le foto, bello sembra bello. È quello che lo precede che mi preoccupa un po’. Due numeri: quota di partenza, 1.342 metri; vetta, 3.077 metri; quota neve, 1.900 metri circa sui pendii a Sud, chiaramente quelli su cui dobbiamo salire oggi. Cercando di non farmi notare al parcheggio tiro fuori dal bagagliaio sci e scarponi leggeri mentre faccio qualche battutina sulla splitboard di Flavio. Iniziamo a camminare nel bosco, la luna piena ci illumina nelle poche radure che incontriamo. È ripido, il sentiero è poco più che una traccia e ne avremo per ancora un bel po’. Portage asburgico, lo chiamano. Dopo un’ora sento prudere la schiena: la maglia termica è piena di aghi di larice. Chiacchieriamo, iniziamo a conoscerci. Il gruppo si è formato perché qualcuno cercava soci con cui assistere al Mezzalama e ha pensato di utilizzare la chat di Gulliver. Probabilmente è una prima anche questa, non pensavo che qualcuno utilizzasse davvero quella sezione del sito. Qualcuno lavora, qualcun altro studia ancora. Flavio quest’anno è il più attivo, complice anche il fatto che in questo momento ha l’occupazione più ambita dagli scialpinisti: ha cambiato lavoro e deve stare a casa per qualche mese.

Mi spiegano l’origine del nome: l’albedo è, in soldoni, il potere riflettente di una superficie nei confronti della luce. E, guarda caso, nella neve l’albedo massima è quella che caratterizza la polvere, la stessa che tutti gli sciatori - specialmente loro - vanno bramando. Ad accomunarli è anche altro. La provenienza, ad esempio: fatte un paio di eccezioni, il grosso del gruppo vive nel Canavese, sparsi intorno a Ivrea e a montagne che se a qualcuno non dicono un granché, ad altri fanno scintillare gli occhi, come il Mombarone e la catena della Bella Dormiente, con le punte Quinzeina e Verzel. Quest’ultima è impossibile non notarla, parandosi di fronte a chiunque entri in Val d’Aosta dalla Pianura Padana.
Sbuchiamo dal bosco mentre il sole fa capolino dalle cime di fronte a noi. Abbiamo messo gli sci da un po’ ma tra rami e crosta non stiamo mantenendo una media particolarmente veloce. Le uniche tracce presenti oltre a quelle dei camosci sono quelle che hanno lasciato loro stessi tre settimane prima: fa sorridere pensare che nessuno sia passato di qua, eppure non siamo così in fondo al mondo. Lo si potrebbe chiamare scialpinismo esplorativo della porta accanto, e in Valpelline, così come nelle Prealpi, è un giochino che riesce bene. L’idea che smuove questi ragazzi non ha a che fare con l’ansia da primati e gradi impossibili: piuttosto, amano andare a infilarsi in posti di cui si sa poco o nulla, su discese che attraggono prima di tutto per la loro estetica. Se poi ci scappa una prima discesa - che loro ci tengono sempre a specificare come probabile - tanto meglio. In ogni caso una birra la si stappa comunque. Con le dovute proporzioni, sulle Alpi si può fare un paragone con i 6.000 dell’Himalaya: mentre a quote inferiori si affollano i turisti e sulle cime più alte le poche linee non ancora salite rimangono appannaggio di pochissimi e fortissimi, nel mezzo esiste un mare di possibilità per continuare a sognare.
Tra una chiacchiera e l’altra ci alziamo di quota mentre qualche centinaio di metri sotto di noi spuntano due puntini, anche loro in splitboard: Francesco e Stefano. Aspettandoli ne approfittiamo per una pausa; fa insolitamente caldo per il periodo e crogiolarsi al sole, per quanto strano, è piacevole. Siamo nella conca che separa il Berrio dalla Punta Gorret, dove poco fa hanno firmato una probabile prima. Le tracce sono ancora visibili a distanza di settimane, sono le curve larghe e regolari di chi si è divertito su bella neve.

Parecchie - cinque, forse sei, forse di più - ore dopo essere partiti arriviamo al colle che ci separa di pochi metri dalla cima del Berrio. Probabilmente siamo i primi a passare di qua da parecchio tempo, la Valpelline è ben lontana dall’iperfrequentazione di altre valli. Qualcuno (pochi, a dire il vero) si avventura nelle altre stagioni nella traversata della Catena del Morion, la vetta di fianco alla nostra: un itinerario alpinistico selvaggio, di cui si sa poco o nulla, e che dall’anno scorso si può tentare appoggiandosi al nuovo, spettacolare, bivacco Pasqualetti, appollaiato su una cengia nel mezzo del nulla. La vista dalla cima del Berrio, a dispetto della sua quota modesta, è incredibile, grazie al fatto di affacciarsi quasi direttamente sopra la Val d’Aosta. I più vicini sono il Mont Vélan e il Grand Combin, conosciuti da qualsiasi amante del ripido degno di questo nome. Di fronte a noi ci sono le vette del Gran Paradiso e gli impianti di Pila, in lontananza svetta il Monte Bianco, alla sua destra la mole della parete Est delle Grandes Jorasses fa ancora più impressione che da sotto. Sotto un palo che fa le veci della croce di vetta si snoda il nostro canale.
Non è estremo, ma non siamo qui per quello. Probabilmente nessuno però ci ha ancora sciato dentro, e questo ci rende entusiasti e curiosi, anche perché non l’abbiamo risalito. Panino, abbracci, Flavio fa partire un drone mentre Stefano si allaccia la tavola ed entra per primo, seguito a ruota dagli altri. Io aspetto Flavio, vedo gli altri giù in fondo divertirsi parecchio. La discesa è bella, la neve pure, e lo sarà per più di 600 metri, dopodiché iniziamo a traversare per riportarci verso i boschi dai quali siamo spuntati questa mattina. Beh, se aveste tempo e voglia di leggere potrei scrivere pagine sulla battaglia che abbiamo poi condotto in mezzo ai larici. Di sicuro è stata una delle peggiori sciate boschive che io abbia mai fatto, prevalentemente su crosta non portante tendente a sfondare su una base di sassi e radici. Ma anche questo, in fondo, fa parte del gioco: effettivamente se nessuno passa mai di qua un motivo ci sarà. Quando mancano 400 metri di dislivello ci arrendiamo definitivamente: è ora di togliere gli sci e finire il giro come era iniziato, camminando. Alle auto ci arriviamo un po’ più di dieci ore dopo averle lasciate, mentre sopra di noi le montagne si tingono con i colori del tramonto. Per tutta l’ultima ora Paolo e Francesco hanno sbavato osservando un altro canale sul versante opposto, cercando di capire come e quando andare a curiosarci. Gli riconosco un entusiasmo e una voglia di mettersi in gioco che spesso alla maggior parte degli altri sciatori manca, sostituite dalla confortante sicurezza di seguire la massa in base a relazioni online e resoconti del weekend sui social network. Non che sia tutto rose e fiori, anzi: già più di una volta si è dovuti tornare a casa a bocca asciutta o con le mutande piene per aver sbagliato nel valutare un itinerario o le condizioni del manto nevoso, ma anche quello, fino a un certo punto, fa parte del gioco.
Qualche sera dopo ci rivediamo a Torino, al Monte dei Cappuccini, dove sono ospiti per una serata nella sede del CAI. Stanno per presentare The Backyard, un video autoprodotto nelle passate stagioni e in cui raccontano la propria visione dell’andare in montagna tra amici. Il pubblico è variopinto, ci sono i vecchietti caiani e giovani splitboarder, ammassati dentro una sala che trasuda l’austerità e la storia di certi ambienti. Il fatto stesso di essere tutti qui, a parlare di ripido e di polvere (sacrilegio!) però è la dimostrazione che in fondo tutte queste chiusure mentali di cui si parla forse esistono solo nella nostra mente. The Backyard è un piccolo inno all’essere degli amatori, in tutte le sfaccettature del termine: chi ama e prova trasposto verso una determinata azione; chi pratica uno sport non per professione, ma per piacere proprio. Alla platea raccontano - un po’ imbarazzati e cercando di stare defilati rispetto al palco - di come passino le serate tra webcam, dati delle centraline meteo e scrollate infinite su Google Earth e in parecchi ci si ritrova a sorridere, perché si capisce che alla fine siamo tutti parte di qualcosa. La differenza fra loro e noi è che a loro, appunto, viene voglia di raccontare delle loro uscite, della loro passione, senza fare i preziosi o le prime donne. Tornando a casa penso che forse al nostro mondo più momenti così non potrebbero che fare del gran bene, e per momenti così intendo dare il proprio contributo a sviluppare una cultura di massa che nel mondo dello scialpinismo ancora latitata; spesso perché si è troppo gelosi della propria attività (o semplicemente spocchiosi) per essere interessati a condividerla con altri, come se fosse una cosa importante, ma che in fondo conta solo per coccolare il nostro ego e sentirci in qualche modo speciali senza esserlo veramente. I ragazzi di Effetto Albedo invece hanno capito che di speciale non c’è tanto quello che si fa, ma soprattutto il cuore che ci si mette, e in quello sono amatori da dieci e lode. Uè, grazie, e alla prossima, che nelle nostre montagne sfigate c’è ancora un sacco di roba da fare.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 128

Nasce la Kilian Jornet Foundation
Ha scelto un motto in tema con l’attualità, rifacendosi A Black Lives Matter. Per lanciare la sua fondazione per la protezione delle montagne Kilian Jornet si è affidato a un coinvolgente Mountains Matter. L’atleta simbolo degli sport endurance in montagna ha scelto di scendere in campo in prima persona per la difesa delle montagne e del loro delicato equilibrio ambientale. Lo ha fatto annunciando sul suo account Linkedin la nascita della Kilian Jornet Foundation.
«Sono felice di affrontare quella che sarà sicuramente la cima più difficile da scalare: la Fondazione Kilian Jornet - ha scritto - Amo la montagna, profondamente, e ho sempre avuto una grande consapevolezza dell'importanza della sua conservazione. Nonostante la mia coscienza ambientale, sono uno dei più grandi distruttori dell'ambiente. Il mio stile di vita nell'ultimo decennio come atleta professionista è stato strettamente legato ai viaggi frenetici in giro per il mondo e con ciò contribuendo su larga scala al riscaldamento globale. Le montagne sono essenziali per la vita sulla terra. Ci forniscono l'acqua immagazzinata nei loro ghiacciai, fiumi e laghi. Ci forniscono risorse come alimenti ed energie rinnovabili. È spaventoso pensare a come il riscaldamento globale potrà plasmare il pianeta nei prossimi decenni o come l'inquinamento potrà cambiare la biodiversità del mondo e il modo in cui mangiamo o troviamo acqua da bere. Questa paura mi ha fatto capire che devo cambiare il mio modo di vivere per essere più coerente con i valori e l'amore per le montagne che ho. La Kilian Jornet Foundation lavora per la conservazione delle montagne e del loro ambiente, comprendendo gli effetti del cambiamento climatico negli ambienti montani e stabilendo i migliori strumenti possibili per affrontarli.»
La mission della nuova fondazione è semplice: azioni dirette per la protezione delle montagne, iniziative di sensibilizzazione ed educazione e ricerca. Il primo progetto sostiene il World Glacier Monitoring Service dell’Università di Zurigo. L’obiettivo è di acquistare almeno 20 stazioni di monitoraggio dei ghiacciai tra il 2020 e il 2021. Si tratta di strumenti sviluppati in Francia che permettono di misurare lo scioglimento dei ghiacciai e gli effetti del global warming a distanza. Il costo di ogni stazione è di 10.000 euro. Tramite il sito della fondazione è possibile fare donazioni a partire da poche decine di euro.
Il grido d'allarme di Bruno Compagnet per salvare i boschi dei suoi Pirenei
È arrivato l’autunno e il bosco cambia colore. L’estate indiana è uno dei momenti più belli nelle valli, quando gli alberi si colorano delle tonalità più calde, giusto prima che il bianco gelo ricopra tutto (e tanta neve, almeno così speriamo noi amanti della glisse). Un’occasione unica per riflettere su quanto siano importanti gli alberi per il nostro ecosistema e per le nostre montagne.
Proprio sull’argomento arriva un grido d’allarme da Bruno Compagnet, freeskier pirenaico, tra i fondatori del marchio Black Crows (beh, se leggete Skialper sapete bene chi è…). Nel comune di Lannemezan, sui Pirenei, è in progetto la costruzione di una grande segheria e Bruno sta cercando di risvegliare le coscienze perché ritiene che si tratti di un piano faraonico e non sostenibile per quei boschi dove tante volte ha posato le sue lamine. «Sono cresciuto in un piccolo villaggio a mille metri e i boschi hanno sempre fatto parte del mio ambiente e di quello degli abitanti della valle, hanno scandito le stagioni e oggi sappiamo quanto siano importanti per combattere l’emergenza climatica. Non sono contrario allo sfruttamento del bosco, ma è un progetto che va contro la realtà ambientale e umana di queste valli» ci ha detto Bruno che invita a firmare la petizione di SOS Forêt Pyrénées.
L’associazione segnala alcuni dati chiave dell’operazione: per fornire i faggi necessari alla segheria dovrebbero essere tagliati l’equivalente di 1.200 campi di calcio sul territorio di 400 comuni pirenaici ogni anno con 5.000 camion in più sulle strade. In pratica si tratta di una quantità da due a tre volte superiore a quella fornita oggi dai Pirenei Atlantici e dal Massiccio Centrale d’Acquitania. SOS Forêt Pyrénées ritiene che il volume di legno richiesto permetta di sostenere la segheria solo per qualche anno, mettendo in pericolo l’ecosistema della foresta pirenaica e la biodiversità. Il progetto sarebbe inoltre finanziato per almeno la metà con fondi pubblici.
Secondo Europe Écologie les Verts Midi-Pyrénées la quantità di legno da tagliare si aggirerebbe tra i 200.000 e 360.000 metri cubi all’anno: «la foresta copre più della metà del territorio dei Pirenei e questo ecosistema dai fragili equilibri ha un ruolo essenziale come serbatoio di biodiversità che preserva il futuro degli esseri viventi, cattura e immagazzina l’anidride carbonica, limitando i cambiamenti climatici e drena l’acqua, limitando le inondazioni e l'erosione del suolo».
La segheria potrebbe dare lavoro a 25 persone e gli studi di fattibilità valutano in 90 i posti di lavoro che si creerebbero nell’indotto negli anni a seguire, ma gli attivisti locali temono che la filiera chiuda prima ancora che possa esserci un indotto, rovinando irrimediabilmente quella natura che è il vero tesoro dei Pirenei.
Afghan Ski Challenge, lo sci è una cosa semplice
A febbraio del 2014 io, Arnaud Cottet e Loïs Rabotel ci siamo ritrovati con gli sci ai piedi per partecipare a una gara di scialpinismo in Afghanistan, la quarta edizione dell’Afghan Ski Challenge, a Bamyan. Tutto è nato leggendo un articolo sul Neue Zürcher Zeitung scritto dal giornalista e ideatore della gara Christoph Zürcher. Cercavo idee per sciate fuori dall’ordinario. Così nel 2013 ho partecipato a una charity night al Frau Gerolds Garten di Zurigo e ho iniziato a essere attratto dall’idea di seguire una gara di skialp in Afghanistan, anche se ero combattuto tra la voglia di andarci e l’idea che forse era solo un evento costruito per pubblicare reportage giornalistici. Però ha prevalso la prima e ho convinto due amici che erano abbastanza coraggiosi e curiosi ad accompagnarmi. L’anno successivo Arnaud mi ha invitato a seguire il suo progetto We Ride in Iran, per promuovere il freestyle nell’antica Persia. A febbraio eravamo a Dizin per alcune gare e così ci siamo incontrati a Dubai con Loïs, che arrivava da Ginevra, per proseguire insieme verso Kabul. Sembra una storia semplice, ma la notte prima di lasciare Dizin
il nostro oste Amir ci ha detto che i biglietti aerei non erano ancora stati prenotati, ma che ce l’avremmo fatta lo stesso. Dovevamo solo fare arrivare i nostri passaporti all’aeroporto, con il taxi. Dopo una notte insonne abbiamo scoperto che era tutto a posto. La fortuna ci ha seguiti fino a Kabul, dove Arnaud aveva contattato Ferdinando Rollando, un ligure trapiantato in Valle d’Aosta che per primo ha fatto rinascere lo sci in Afghanistan. Si era traferito a Kabul per provare a sviluppare una cultura della sicurezza dalle valanghe, istruire le persone e costruire paravalanghe nei villaggi afghani con l’aiuto dell’Unione Europea. Poco prima di imbarcarci sul volo per l’Afghanistan, via Facebook, ci ha detto che sarebbe venuto a prenderci all’aeroporto e ci avrebbe ospitati a casa sua a Kabul prima e dopo il viaggio a Bamyan. Lo abbiamo incontrato dopo i meticolosi controlli di sicurezza.
La sua ONG, Alpistan, faceva davvero un lavoro encomiabile in quel Far West del ventunesimo secolo. Un ex militare dei servizi segreti francesi, insieme a quattro altre persone, si occupava della sicurezza. Una sera siamo usciti in uno dei ristoranti frequentati dagli stranieri. Ferdinando ci ha chiesto se immaginassimo perché fosse quasi vuoto e noi pensavamo che fosse a causa dei prezzi alti. Ma non era così: solo dieci giorni prima in quella stessa strada c’era stato un attentato dei Talebani con diversi morti, così per il dolce abbiamo preferito trasferirci a casa.
Il giorno seguente abbiamo preso un volo per uno dei posti più sicuri dell’Afghanistan. Dopo la demolizione delle gigantesche statue dei Buddha nel 2001 in quella deliziosa valle non ci sono stati altri episodi di cronaca. I grossi buchi nella pietra sono impressionanti ed è difficile immaginare che lì ci fosse stato un fiorente monastero. Mentre camminavo tra le rovine un afghano mi ha chiesto se quei resti fossero importanti per me e io, senza pensarci un attimo, ho fatto cenno di sì con la testa. Lui ha detto di no, che per lui non erano interessanti. Così mi sono ritrovato a pensare al valore che diamo agli edifici storici e alla linea tra conservare e ricostruire, anche se sui Buddha non ci sono dubbi: è stata una demolizione criminale. Abbiamo passato un paio di giorni a esplorare le montagne dei dintorni con una Guida locale con la quale dovevamo sempre insistere per fare gite un po’ più lunghe e che ci ha consentito di entrare direttamente nella cultura locale. Siamo stati anche a Jawkar, villaggio isolato, soprattutto nei mesi invernali, a Sud-Est di Bamyan. Quando c’è la neve e la strada è chiusa i bambini vanno a scuola nella moschea. L’imam ci ha invitato a partecipare a una lezione e siamo rimasti sorpresi per quanto la scuola fosse ben organizzata; alcuni bambini parlavano inglese e ci hanno chiesto di portare libri di matematica e fisica alla nostra prossima visita. L’imam ha insistito perché scattassimo fotografie, per mostrarle in Europa e trasmettere il messaggio che, indipendentemente dalla religione e dalla cultura, siamo tutti esseri umani e lavoriamo per migliorare la nostra società. Il giorno dopo abbiamo traversato le montagne superando un passo innevato, raggiungendo un altro villaggio dove le persone si nascondevano al nostro passaggio. L’opposto di quello che era successo il giorno precedente, quando tutti volevano provare sci e scarponi appena ce li toglievamo. Era un momento collettivo di divertimento per gli abitanti di Jawkar, mentre a due chilometri di distanza sembrava di essere in un altro mondo.

Quell’anno Sajjad Housaini e Alishah Farhang hanno fatto compagnia ad Arnaud sul podio dell’Afghan Ski Challenge e non sapevano ancora che quel risultato avrebbe cambiato la loro vita. Christoph Zürcher e il Bamyan Ski Club hanno creato un programma di supporto per aiutarli a realizzare il loro sogno di partecipare ai Giochi Olimpici di Pyeongchang del 2018. Per tre inverni si sono allenati a St. Moritz con un allenatore professionista e hanno partecipato alle loro prime gare FIS di sci alpino per provare a raccogliere i punti necessari a essere ammessi ai Giochi. Però non ce l’hanno fatta ed è comprensibile. Immaginate di imparare a sciare a 26 anni e gareggiare con chi è sugli sci da quando aveva sei anni. Alla fine il loro penultimo e terzultimo posto è stata l’occasione per essere presi in giro dagli amici: «Ma quelli che hanno vinto erano tutti stranieri?». Per chi ha sempre vissuto in Svizzera è difficile capire le difficoltà che hanno dovuto affrontare per entrare nel mondo dello sci agonistico. Il contrasto tra una delle località più famose del mondo come St. Moritz e l’Afghanistan rurale è drammatico. «Rimanete in Europa!» hanno detto loro i parenti e gli amici, ma Sajjad e Alishah non hanno mai cercato asilo politico, volevano solo mostrare un volto diverso dell’Afghanistan e dare un segnale di pace e ci sono riusciti grazie all’eco mediatica della loro storia.
L’Afghan Ski Challenge è un evento che attira l’attenzione dei media da tutto il mondo. Ed ecco che quel sentimento controverso che avevo provato alla charity night, un anno prima di partire per l’Afghanistan, quando ci penso, riaffiora. È un progetto sostenibile o solo un’occasione per realizzare reportage? La gara delle donne rappresenta un vero sforzo per cambiare qualcosa o sciano solo per le telecamere? Però il giorno della gara a Bamyan è pieno di afghani con gli sci e in tanti vengono a vederli. A fare il tifo sono venuti anche alcuni dei bambini che avevamo visto a Jawkar, camminando per tre ore sulle montagne dove noi abbiamo sciato, con ai piedi scarpe da città e indossando dei normali jeans. Lo hanno fatto solo per vedere lo Ski Challenge ed è per questo che i miei dubbi, quando ripenso a quei momenti e guardo le foto che ho scattato, vengono spazzati via in un attimo. Credo che sia davvero un bel progetto e la speranza è che possa continuare ancora per tanti anni. La storia di Sajjad e Alishah mostra quanto la nostra cultura sportiva sia permeata dal professionismo e sia difficile entrare in questo mondo, soprattutto quello degli sport invernali. L’altro lato della medaglia è che siamo attratti da ciò che è esotico e portati a dare un’allure romantica a posti come le montagne dell’Afghanistan, che per noi sono luoghi per un viaggio sugli sci dal sapore diverso. Noi abbiamo detto a quei ragazzini che invidiavamo quel loro approccio così semplice e genuino alla vita e allo sci. Tutto quello che avrebbero voluto loro invece era la nostra di vita, il benessere e soprattutto la possibilità di scegliere. In poche parole, la nostra libertà.
Oggi a Bamyan non è cambiato quasi nulla, la gente si veste allo stesso modo, però c’è una manovia e per questo si potrebbe dire che è la prima località sciistica dell’Afghanistan. Il motore è quello di una motocicletta e muove una semplice fune. Ci sono anche progetti per installare un vero ski-lift (se conoscete qualcuno che vuole smantellare un impianto in Italia, fatecelo sapere!). Sajjad e Alishah continuano a promuovere lo sci nel loro Paese e cercano di alimentare una cultura degli sport invernali facendo tesoro dei mesi passati ad allenarsi in Svizzera. Questo è lo scambio culturale che è nato grazie all’apertura dei cuori e delle menti delle persone coinvolte nel progetto, da entrambe le parti. Ritornati a Kabul abbiamo passato due giorni a visitare la città devastata dalla guerra. Il costo del biglietto d’ingresso alle rovine del Darul Aman Palace, corrompendo il soldato di guardia, è lo stesso del museo di storia nazionale. Una sera Ferdinando ci ha chiesto di dargli una mano. E come avremmo potuto dirgli di no dopo che ci aveva ospitati? Abbiamo camminato per una trentina di minuti e siamo arrivati in un parcheggio buio dove aveva parcheggiato i suoi due pick-up. Uno era senza targa e mi ha chiesto se potevo guidare anche io e seguirlo. Ha scelto strade minori per evitare i checkpoint e siamo arrivati al garage di un amico dove abbiamo parcheggiato al coperto. Più tardi ci avrebbe spiegato che quei pick-up li aveva comprati al mercato nero e solo dopo aveva saputo che erano stati rubati al governo, così doveva nasconderli, cercando di sbarazzarsene prima possibile. Purtroppo Ferdinando non è più tornato a casa dal Monte Bianco nel luglio di quello stesso anno. Il suo progetto Alpistan si è fermato ma è ripartito nel 2018 grazie al figlio Ernesto. L’Afghan Ski Challenge continua e ha spento le dieci candeline quest’anno. «C’erano 100 concorrenti, anche dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, dalla Finlandia e dall’Italia» mi ha detto Sajjad che sta già pensando all’undicesima edizione. Alisah è felicemente sposato e ha un figlio.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 129













