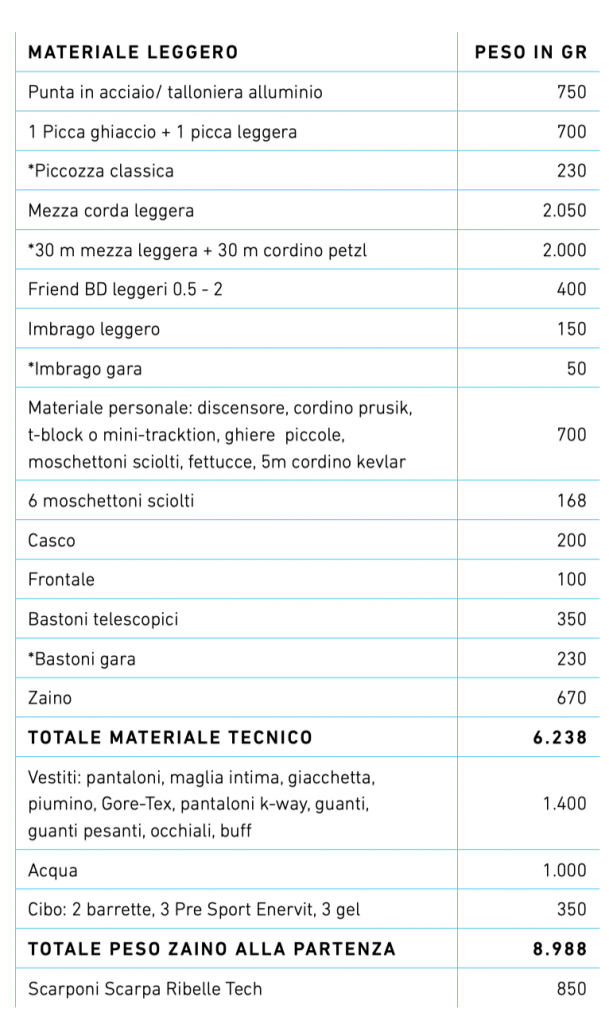L'incredibile storia dell’attacchino che fa impazzire il mondo
«È un quadrilatero che ha come estremi Bad Haring, in Tirolo, Graz, in Stiria, il Monte Bianco e la Valtellina. Non c’è dubbio però che il caso abbia voluto che il Monte Bianco, il luogo che apparentemente centra meno con questa storia, sia stato determinante. Siamo agli inizi degli anni Ottanta. Uno studente di ingegneria di ritorno da una vacanza con un amico per arrampicare nelle Calanques passa da Chamonix. Guarda il Monte Bianco e, con quell’incoscienza tipica dei ventenni, non ci pensa due volte: perché non proviamo ad arrivare in vetta? I due scelgono di traversare dall’Aiguille du Midi, poi Tacul e Mont Maudit. Alla fine in vetta ci arrivano, ma devono battere traccia e quell’attrezzatura pesante – sci da due metri e attacchi da skialp con telaio – li distrugge più dell’intera vacanza nelle Calanques».
Inizia così l’articolo di Skialper 129 di aprile-maggio, in distribuzione a partire da questi giorni, che ripercorre la storia dell’attacchino. Un incredibile incrocio di coincidenze e incontri che ha portato un visionario come Fritz Barthel a creare un oggetto rivoluzionario ma poco compreso agli inizi. L’attacco che è diventato lo standard e ha in parte spinto lo skialp verso il boom è nato dall’intuizione e dalla testardaggine di uno studente di ingegneria, ma si è sviluppato grazie all’incontro con il mondo dello skialp race italiano, Fabio Meraldi e Adriano Greco in primis, e al rapporto, fin dagli inizi, prima che il marchio del leopardo delle nevi acquisisse i diritti esclusivi, con Dynafit. Parlando con i protagonisti di questa piccola rivoluzione abbiamo ricostruito tutti i passaggi, gli aneddoti, le variabili.
«Credo che i pin resisteranno ancora, ma la storia dice che i sistemi vengono sostituiti da altri sistemi migliori e dubito che sarò io a fare il prossimo passo, non è giusto che lo faccia un vecchio testardo: giovani, fatevi avanti!». Se c’è qualcuno pronto a raccoglierla, è bene che si legga prima di tutta la storia.

WESC 1991
«Iniziò entrando nel canale con curve saltate decise e pulite, con la neve che si sollevava accanto a lui. Gestiva gli sci con una precisione estrema, in coordinazione perfetta con il movimento delle braccia e dei bastoncini. Dove la maggior parte degli sciatori faceva una curva soltanto, derapando, Coombs ne faceva tre. Non attendeva, non aveva dubbi o esitazioni. Era come un torero nell’arena che invece di un animale teneva a bada un’intera montagna. Si spostò poi a sinistra, uscendo dal canale principale e superando la parte più esposta, costellata di rocce. Una caduta qui sarebbe stata fatale. Se cadi, muori. Il tempo rallentò nella sua mente. Ogni roccia gli si avvicinava al rallentatore, permettendogli di girargli attorno con precisione, senza mai fermarsi».
Questo brano è tratto dal libro Sulle tracce di Coomba di Robert Cocuzzo. Siamo al WESC, il primo Mondiale di sci estremo, in Alaska, nel 1991. Uno sconosciuto di nome Doug Coombs arriva a sfidare tutti i più forti sciatori di ripido dell'epoca. E sbaraglia la concorrenza su pendii dove ci sono stati anche ruzzoloni epici come quello di Garrett Bartelt con 17 capovolte.
https://youtu.be/2o8_61pHLzQ
Su Skialper 129 di aprile-maggio pubblichiamo un ampio articolo sulle performance di Coomba al primo WESC, con le fotografie dell'epoca del fotografo Wade McKoy. Se vuoi riceverlo direttamente a casa tua puoi sempre abbonarti.
Se vuoi conoscere l'incredibile storia di Doug Coombs, puoi comprare il libro pubblicato dalla nostra casa editrice.
In arrivo Skialper 129 di aprile-maggio
È una frase di Martin Luther King a contraddistinguere la copertina del numero 129 di Skialper di aprile-maggio, una frase che ben si adatta ai tempi che stiamo vivendo: «Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non farete nulla per cambiarla». Un numero che avrebbe dovuto essere interamente dedicato all’agonismo e allo spirito agonistico, e lo è in gran parte, ma che l’emergenza ha costretto a cambiare leggermente, inserendo anche articoli di viaggio. Per non smettere di sognare. 176 pagine tutte da leggere e da guardare, in distribuzione a partire dal 21 aprile.
COSA RESTERÀ DI QUEI FORMIDABILI ANNI ’90 - Nel giro di poco più di un decennio, con la nascita dello skyrunning, si è imposto il concetto di fast & light che è alla base del nostro andare in montagna e di sport meno estremi come il trail. Ripercorriamo gli anni d’oro di quell’intuizione, con le prime gare sul Monte Bianco e quelle in Himalaya, gli studi scientifici e le foto dell’epoca.
AVEVAMO TUTTO E NON LO SAPEVAMO - Poco conosciuta, la Valle Gesso è stato il luogo dove, inconsapevolmente, abbiamo vissuto l'entrata dell'Italia nel lockdown del Covid-19. E dove ci piacerebbe tornare per la prima sciata. Un reportage esclusivo e autoprodotto, firmato da Federico Ravassard, da uno dei luoghi più selvaggi d’Italia, ideale per lo scialpinismo esplorativo.
SOUL SILK - 9.700 chilometri, 90.000 metri di dislivello positivo, 12 Stati attraversati. Per pedalare dall’Italia alla Cina, raggiungere (spesso sciandole) le montagne più belle e vivere quel soffio di avventura che tanto ci è mancato negli ultimi mesi. Il diario di un viaggio indimenticabile, con testi e foto di Giacomo Meneghello.
AFGHAN SKI CHALLENGE - Quando si porta il fucile con la disinvoltura di una borsa e le priorità della vita sono molto diverse da quelle a cui siamo abituati, anche una gara di scialpinismo diventa l’occasione per divertirsi senza troppe pretese. Ieri come oggi. Un reportage dall’Afghanistan firmato da Ruedi Fluck.
MONSIEUR MEZZALAMA - Adriano Favre è il signorsì della gara di scialpinismo più famosa del mondo. Ma è anche rifugista, soccorritore, himalaysta, Guida alpina, gestore di rifugio, sviluppatore di prodotti per Ferrino. A tu per tu con un personaggio davvero poliedrico.
SKIALPER AMARCORD - Enrico Marta, fondatore di Skialper, ha seguito la parabola dello skialp race dagli esordi e ricorda alcuni degli episodi più curiosi, dai primi exploit di Kilian e Roux, alle funamboliche prestazioni di Giacomelli. Con le foto dell’archivio della nostra rivista.
L’ANNO ZERO - 1989: Fabio Meraldi e Adriano Greco, insieme a Valeria Colturi, partono dall’abbigliamento per lo sci di fondo per creare la tutina che ha fatto la storia dello skialp agonistico.
L’INCREDIBILE STORIA DELL’ATTACCHINO CHE FA IMPAZZIRE IL MONDO - Una serie di coincidenze ha permesso di sviluppare un’idea rivoluzionaria che dalle gare si è velocemente imposta come lo standard dello scialpinismo. Ecco come è nato e si è sviluppato l’attacco a pin, con le testimonianze dei protagonisti e le foto dei primi prototipi.
QUELLI DELLA NOTTE - 240 atleti, 80 volontari, 30 chilometri di percorsi da preparare in meno di un’ora e da disallestire entro l’alba: dietro alla Monterosa Skialp c’è una macchina organizzativa complessa, che lavora tutto l’anno per un evento di qualche ora. Curiosità e le spettacolari foto di Stefano Jeantet dell’ultimo evento agonistico top che si è disputato.
WESC 1991 - Per anni in Alaska è stato organizzato il Mondiale di sci ripido. Alla prima edizione uno sconosciuto sciatore di Jackson Hole ha sbaragliato la concorrenza. Si chiamava Doug Coombs. Il racconto di Robert Cocuzzo, che ha scritto un bellissimo libro su Coombs, illustrato dalle foto di quell’edizione del WESC del fotografo Wade McKoy
GO WITH THE FLOW - Dopo il terzo Freeride World Tour Arianna Tricomi è sempre più la freeskier del momento, ma il suo successo è frutto di un background che va dallo sci alpino alla prima scena freestyle, quella di chi il kicker lo costruiva con le proprie mani. Perché la passione per lo sci viene prima di tutto. Alberto Casaro l’ha incontrata poco prima del lockdown
NADIR MAGUET, IL MAGO TRASFORMISTA - Prima fondista, poi biathleta, scialpinista. E ora dobbiamo chiamarlo skyrunner? Per capirlo siamo andati a trovarlo a casa sua.
DOLOMITI HALF MARATHON EXPERIENCE - La mezza maratona dell’Alpe di Siusi e del Sassolungo non sono solo due delle gare più belle tra i Monti Pallidi, ma percorsi unici da provare tutta l’estate. Ognuno al proprio ritmo, magari fermandosi per una pausa in una delle tante baite gourmet lungo il percorso.
MUST HAVE - Le chicche per chi ha lo spirito agonistico dentro, che sia con una tutina, un pettorale in una gara di trail o dei padelloni ai piedi in un contest di freeski. Pagine da sfogliare tenendo ben lontana la carta di credito…
E NON FIISCE QUI - Il consueto appuntamento con il portfolio fotografico, un approfondimento sulla Workstation di ATK Bindings e sulle anteprime Dynafit per il prossimo inverno in chiave skialp race, opinioni e tanto altro.
Contrabbandieri di emozioni
Ha ragione Giorgio Daidola, il vero scialpinista è un viaggiatore errante. Usa gli sci non solo come mezzo di trasporto, ma pure come strumento di conoscenza del mondo e di se stesso. Li utilizza per raggiungere luoghi inaccessibili attraversando deserti bianchi, come bene ci ha insegnato Michel Parmentier; per salire montagne che sono solo tappe di un percorso fuori e dentro di sé. Un percorso che, a volte, ha come obiettivo l’orizzonte, per vedere ciò che c’è dopo e ciò che c’è dentro. Non per niente sciare è un po’ come vivere: consente di lasciare una traccia che non è indelebile, ma che identifica in modo univoco chi l’ha disegnata, così vincolata come è alla sua sensibilità, alla sua capacità tecnica, all’attrezzatura utilizzata, persino allo stato d’animo e alle emozioni del momento. E le traversate - meglio di ogni altra attività scialpinistica - permettono di rendersi conto di tutto questo, seguendo le tracce di chi le ha percorse per primo ed entrando in sintonia con la sua sensibilità, pur vivendo ogni volta un’esperienza nuova; assecondando le proprie emozioni, entrando fra le pieghe delle montagne, penetrando in punta di piedi in un mondo che, seppure già percorso, come la neve, cambia a ogni ora, a ogni folata di vento.
Per vivere queste emozioni non è sempre necessario partire per più giorni da casa e andare in capo al mondo. A volte è possibile trovare ciò che si cerca anche dietro l’angolo. Io ho avuto la fortuna di condividere un breve viaggio alla portata di qualsiasi scialpinista allenato a pochi passi da casa, sulle nostre Alpi, in giornata, da Isolaccia di Valdidentro a Livigno, lungo le tracce dei contrabbandieri e dietro alle code di Giacomo Meneghello. Lui è un fotografo che vive a Sondalo e che, collaborando con la Ski Trab, ha avuto l’idea di creare un’alta via scialpinistica tra Bormio e Livigno, tracciando due percorsi. Uno, più logico e diretto, parte da Isolaccia e uno, più difficile e tortuoso, prende il via da Oga, quest’ultimo in verità già in parte sperimentato da alcuni scialpinisti locali che fanno capo sempre alla Ski Trab. Noi, a causa del rischio valanghe, abbiamo affrontato il tracciato meno pericoloso, ma anche più lineare. Ventuno chilometri per circa 1.900 metri di dislivello positivo. Un tracciato senza particolari difficoltà tecniche che, partendo dalla Valdidentro, concatena in modo logico diverse convalli esistenti tra Bormio e Livigno. Convalli in un recente passato utilizzate dai contrabbandieri per far transitare le merci dal porto franco di Livigno all’Italia. Lo abbiamo fatto il lunedì di Pasquetta in una giornata splendidamente serena dopo il maltempo della settimanaprecedente che aveva portato quasi un metro di neve fresca, ma anche numerosi accumuli da vento suipendii maggiormente esposti.
Partenza alle 6,30 da Sant’Antonio di Scianno, pochi chilometri sopra Isolaccia, nel comune di Valdidentro, a quota 1.650 metri. Lasciata l’auto in un piccolo spiazzo, abbiamo iniziato a risalire verso il Monte Resaccio dapprima facendo traccia in un rado bosco di abeti e poi su distese innevate in cui s’intuivano alpeggi semisepolti dalla neve in un universo fiabesco al risveglio. Giacomo Meneghello davanti, noi dietro. Una decina di scialpinisti in tutto per l’occasione: alcuni ragazzi di Cantù guidati da Marco Colombo di Ski Trab, il forte altoatesino Alex Kheim con la moglie parmigiana Anna e io. Si sono poi aggiunti in Val Vezzola alcuni appassionati livignaschi e di Semogo tra cui la nota atleta polacca di scialpinismo Anna Tybor. Ci aspettavano già in quota, essendo partiti più avanti, da Li Arnoga. Un ripido pendio, la larga cresta ed eccoci in vetta al Monte Resaccio. Siamo a quota 2.717 metri. Il panorama a 360 gradi toglie il fiato; Cima Piazzi ci ammalia controllando ogni nostro passo dall’alto della sua bellezza e severità. In fondo, a sinistra, riconosco il Pizzo Palù, dietro l’Ortles con la sua corona di cime del bacino dei Forni.
Anna Tybor, reduce da una brillante prestazione al Tour du Rutor, mi fa da Cicerone illustrandomi il nome di valli e convalli. Livignasca d’adozione, mi dice di non poter più fare a meno di queste montagne. Il tempo di spellare e giù, verso il bianco più bianco. Versante nord: farina intonsa, sciatona. Gli Ski Trab Maestro che l’azienda bormina mi ha dato da testare per l’occasione non mi fanno rimpiangere sci più larghi. Ricamiamo un lenzuolo intonso consapevoli di essere dei privilegiati. Consapevoli di poter ancora una volta sperimentare che è vero che gli sci sono sciancrati per meglio adattarsi alla forma rotonda del mondo; per meglio consentirci d’accarezzarlo con le nostre curve. Si attraversa un universo incantato senza alcuna traccia, se non quella di qualche camoscio. Dalla Val Vezzola transitiamo in Val Trela. Procediamo ora in leggera salita sotto un sole abbacinante. È metà mattina. Le montagne si scrollano di dosso ciò che non riescono più a trattenere. Sentiamo rombo di scariche. La tigre bianca oggi è sveglia, in agguato su molti pendii, nascosta sotto il nuovo strato di neve. Ma il nostro percorso è mansueto. Giacomo lo ha scelto apposta preferendolo a quello più rischioso che transita in Val Viola e che potrebbe essere affrontato al ritorno in un ipotetico viaggio ad anello di due giorni. Saliamo pendii non impegnativi al Monte Rocca (2.814 m), classica scialpinistica della zona. Lo rimontiamo da est, non - come di consueto - da nord-ovest.
Dalla vetta si apre sotto di noi la Valle di Tre Palle. Firn e neve trasformata per una sciata da ricordare, con Giacomo che si sdoppia nel ruolo di guida e fotografo. Malghe che emergono qua e là, stalle, cavalli. Un presepe che lascia segni indelebili nell’anima dell’escursionista-viaggiatore. Attraversiamo una strada asfaltata in località Trepalle (quota 1.918) e di nuovo rimettiamo le pelli. Ora si sale verso il Monte Crapene (2.430 m). Ancora pendii dolci, neve trasformata. Qualche escursionista con le ciaspole. L’ambiente si fa meno isolato, gli impianti e le piste del carosello sciistico compaiono dall'altra parte della valle. Dalla cima del Crapene appare Livigno, giù in fondo. Dall’alto sembra davvero esteso e con il suo vestito migliore, quello tutto bianco, sembra una perla tra una conchiglia di cime.
Inanellando curve sul firn, scendiamo così fino al capolinea del nostro viaggio, firmando altri magnifici pendii con le lamine. Le nostre tracce saranno già scomparse, cancellate dal sole o dal vento. Non sarà invece cancellata l’idea di Giacomo d’ideare questo percorso che consente di collegare al ritmo delle pelli questi due paesi, Bormio e Livigno, divisi dalla cresta delle Alpi, ma uniti in una splendida cavalcata. Percorrendola noi, contrabbandieri d’emozioni, siamo andati alla ricerca del senso del viaggio con gli sci, solcando valli e salendo montagne dolci come la panna montata. Come sempre alla ricerca della curva perfetta. Come sempre trovando alla fine noi stessi.
Questo articolo è stato pubblicato sul numero 118 di Skialper di giugno 2018. Se vuoi acquistare l'arretrato clicca qui, se vuoi abbonarti a Skialper qui.

Pik Lenin, sogno di vento e ghiaccio
Arranco lentamente, ogni venti passi mi fermo e, appoggiato sui bastoni, con un paio di respiri più lunghi, cerco di rimettere il fiato a posto con i tempi. Poi riparto spingendo gli sci in un mare di bianco accecante. Il pendio non è ripido e la neve non è brutta, ma la quota trasforma ogni singolo movimento in una fatica immonda. Mi fermo più e più volte, e ogni volta lo sguardo si fissa sulle mie due lame nere che trascino con i piedi e che fendono, anche cromaticamente, il manto candido della montagna che mi ospita. Non sono uno scialpinista e gli sci accoppiati sotto il mio respiro affannato mi ricordano solo anni passati, dove gli stessi, di altre forme e uso, giacevano inermi in attesa di affrontare le discese libere per le quali ero portato. Discese libere intese come attività sportiva di scorrimento veloce, tra salti e curve affrontate a oltre 100 chilometri orari, su nevi tendenzialmente dure o ghiacciate, un altro sci insomma, lo sci di un ragazzino che sognava i cinque cerchi olimpici, lo sci di un giovane esuberante che amava l’ebbrezza della velocità e un altro tipo di montagna. Poi i tempi passano, i cinque cerchi sfumano e l’amore per la neve cambia, più e più volte.
SEI AMICI AL BAR Alla fine, pochi mesi fa, un incontro fortuito al bar, un’idea che sembrava buttata lì tanto per parlare, un progetto che silenziosamente prende piede, che diventa realtà e che ora mi fa contare una ventina di passi tra una sosta e l’altra. Il bar era uno qualunque, con un arredo qualunque, in un pomeriggio qualunque, l’incontro quello con Cala Cimenti, l’unico Snow Leopard italiano. Cala è un ragazzone torinese di 41 anni che con la conquista del Peak Communism (7.496 m), nell’estate del 2015, è stato insignito dell’onorificenza del leopardo, che viene riconosciuta dalla Federazione di Alpinismo Russa solo a chi ha scalato tutte le cinque montagne di 7.000 metri delle ex repubbliche sovietiche dell’Asia Centrale. Cala mi propone di salire il Peak Lenin (7.134 m), nel sud del Kirghizistan, senza dubbio tecnicamente la più facile delle cinque vette sorelle, ma innegabilmente anche quella con più vento, parametro questo che ne abbassa drasticamente la percentuale di riuscita (raggiungono la cima solo il 20-25% dei pretendenti). Spingo e conto, mi fermo e respiro, ogni tanto mi guardo intorno e ammiro la maestosità della parete nord che, sulla mia sinistra, scende omogenea e apparentemente liscia verso una valle grigia. Sotto i colori slavati e secchi dell’alta quota estiva si allungano a perdita d’occhio fino a spegnersi nell’infinito. Sto risalendo la via principale, quella della cresta ovest, sono a metà strada tra il campo due, a quota 5.300, e il campo tre, che andremo a montare ai 6.100 metri. Sono sotto il peso stremante di uno zaino enorme, imposto dalla scelta dell’autosufficienza nei campi avanzati. Con me, chi davanti e chi dietro, oggi ragionevolmente slegati, i miei compagni d’avventura, tutti amici ‘da bar’ che, al momento di decidere la trasferta, si sono trovati nel posto giusto al momento giusto e hanno deciso di unirsi alla spedizione. Un gruppo di amici normali con la passione per la montagna e per lo sport endurance, un sestetto che si conosce e si frequenta specie nelle gare di trail running e che ha deciso di condividere un’emozione forte chiusa da tempo nei relativi cassetti dei sogni. Maurizio Basso, 27 anni, è un serramentista che lavora in proprio, pratica scialpinismo agonistico e corsa in montagna di buon livello. Joseph Sassano, 45 anni, un cuoco con un infinito amore per la montagna. Flavio Ferrero, 52 anni, un dirigente d’azienda che impegna ogni minuto libero della sua vita in attività fisiche legate ai monti. E poi lei, la cucciola del gruppo, Natalia Mastrota, 21 anni, figlia del televenditore Giorgio Mastrota e della bella attrice Natalia Estrada, che al cemento di Milano ha preferito la vita più sobria e montana di Chamonix dove lavora come cameriera/barista. Un sestetto, tutto affiliato al CAI di Bra, in cui l’unico a non aver mai spinto gli sci con le pelli sono io, ma in un paio di prove tecniche mi tolgo le formalità di risalita mentre per la discesa non vedo problemi. Il pendio s’inasprisce e quella che fino a ora era una linea di percorrenza retta, si trasforma nel classico zig zag da escursione scialpinistica. Virata su virata approdo al piattone adibito a campo tre dove una quarantina di tende, per lo più momentaneamente disabitate, colorano e ravvivano un ambiente quasi troppo bianco. Il sole è alto e caldo, il vento sembra avere concesso una pausa, le speranze sono buone, domani si tenta la vetta.

GIORNO X 25 luglio 2016, ore 3,30: fuori da una delle due tende arancioni Ferrino preparo le ultime cose, tra le quali gli sci appesi allo zaino, monto i ramponi sugli scarponi e parto seguendo un tracciato illuminato dall’esile fascio di luce che esce della mia frontale. Abbiamo deciso partenze scaglionate per provare a essere in cima tutti insieme, scelta difficile per chi come me non è avvezzo a certe situazioni che quindi deve affrontare da solo, ma decisione unanime che avrà nei fatti la sua ragione. Ben distanziate nella notte si intravvedono una trentina di luci ciondolanti, il freddo è di quelli importanti (percepito -35°) ma l’adrenalina riscalda gli animi, spingendo le gambe in un’andatura decisa. I soliti 20-30 passi, poi un piccolo recupero e poi ancora movimento. Verso le 5,30, anticipati da sfumature viola e arancioni, i primi raggi di sole colorano il cielo. Uno spettacolo mozzafiato che mi godo in compagnia di Natalia. The Knife, il coltello, una cresta particolarmente esposta alla furia dei venti, è la parte più tecnica dell’intero percorso, l’unica dove è richiesto l’uso della piccozza, almeno per sicurezza. Appena prima violente folate di aria gelida ci hanno fatto abbandonare lo zaino con gli sci, lasciandoci quindi spogli e leggeri, con meno vela da offrire alla violenza delle raffiche e più possibilità di continuare. Poi lunghi traversi e mammelloni nevosi che sembrano non finire mai e alla fine lui, che sotto forma di piccola testa bronzea rappresenta il vertice del monte che gli hanno dedicato: Lenin. Il sole oramai alto illumina il mondo e il mondo, visto da qui sopra, sembra essere ancora più infinito. Mi vengono in mente le parole con cui Richard Parks, in Oltre l’orizzonte, descrive una situazione simile e le faccio mie: «Quassù l’orizzonte è più lontano che in qualsiasi altro luogo, e trovarsi a contemplarlo significa contemplare quanta più terra possibile senza staccarsi dalla sua superficie. Per questo motivo penso che ti faccia sentire più vicino al pianeta e, in qualche modo, a qualsiasi cosa ci possa essere di superiore a noi esseri umani». Cala e Mauri, mostrando esperienza e forza fisica fuori dal comune, a differenza di noi, arrivano in cima con zaino e sci al seguito e, come da programma, ridiscendono sciando l’immenso versante nord. Un’enorme parete di 2.700 metri di dislivello tagliuzzata da un’infinità di crepacci e lucidata nelle sue parti più esposte. Natalia purtroppo, causa geloni ai piedi, non ce l’ha fatta a salire e appena prima del coltello ha dovuto rinunciare, come peraltro ha fatto anche almeno un terzo della trentina di alpinisti provenienti da tutto il mondo che ci ha provato in questa gelida notte di fine luglio. Io, Flavio e Joseph, fatte le consuete foto di rito, ritorniamo ripercorrendo l’infinita cresta ovest che, dopo alcune ore, ci riporta al campo 3.
IL SOGNO NEL CASSETTO Ho camminato e sciato piano, pianissimo, ho fatto soste su soste, ho allestito e smontato campi, ho mangiato e fatto i bisogni in situazioni per me assolutamente nuove e decisamente estreme; sono stato aiutato, più psicologicamente che fisicamente, specie dall’amico Joseph, con cui ho condiviso l’ultima parte dell’ascesa finale, ho avuto un principio di congelamento ai piedi e annebbiamento della vista, probabilmente, a causa dell’aria rarefatta e della disidratazione. Sono anche stato momentaneamente incosciente perdendomi sfumature che non troverò più, ma alla fine ce l‘ho fatta. Con tanto sacrificio, un po’ di sana sofferenza e un pizzico di fortuna, fondamentale come sempre, ce l’ho fatta. Ce l’ho fatta io, un non alpinista e ce l’hanno fatta i miei amici scialpinisti. Ce l’abbiamo fatta e abbiamo portato a casa il nostro sogno nel cassetto. E la sera dell’ultimo giorno, nelle verdi e respirabili quote del campo base (3.500 m), guardando il grosso massiccio granitico ricoperto di neve e arrossato dagli ultimi raggi di sole che precedono la notte, seduto nella mia tenda, stanco e sorridente, rubando nuovamente una citazione a me cara (di Tiziano Terzani) ho semplicemente pensato: «Buonanotte signor Lenin».

Andata e ritorno in 13 ore e mezza
Dopo la salita dalla Normale, Cala Cimenti ha salito e disceso in velocità e in solitaria la via Arkin sulla difficile parete nord del Peak Lenin, per oltre 2.700 metri di dislivello. Ecco il racconto dell’impresa.
Sono le cinque del pomeriggio del primo agosto, neanche a farlo apposta guardo l’orologio che segna le 17.00 spaccate. Attraverso fasci di polvere di neve sollevati dal vento osservo il profilo del busto di Lenin. Reciprocamente ci guardiamo sornioni. Sono in cima al Peak Lenin (7.134 m) per la seconda volta in una settimana e quattro anni dopo la prima salita, quando questa cima ha dato il via al mio Snow Leopard Ski Project che è poi durato tre anni. Mi tornano alla mente immagini, emozioni, amicizie che mi hanno arricchito in questo arco di tempo sovietico e inevitabilmente vado con la mente anche a sette giorni prima, quando cinque amici festeggiavano in questo stesso luogo con grandi pacche sulle spalle e mille foto. È stato bello mettere a disposizione la mia esperienza a queste quote e la conoscenza della montagna per aiutare un gruppo di amici ad arrivare in cima alla loro prima montagna di settemila metri. In più, con Maurizio, siamo scesi da questa immensa parete nord con gli sci calzati direttamente dalla cima. Questa volta però è diversa, sono inginocchiato a 7.134 metri di quota e sono felice, sereno, volevo congedarmi da questa montagna con qualcosa di speciale, mi sarebbe piaciuto salire la sua parete nord attraverso la via Arkin in velocità, senza l’ausilio di campi intermedi e senza bivacchi, in giornata e da solo. Ovviamente volevo salire la nord in giornata per poterla poi ridiscendere con gli sci. Volevo regalare tutto a questo luogo un po’ speciale per me e mi sarebbe piaciuto che questa impresa rappresentasse la degna conclusione del mio periodo da leopardo delle nevi. Mi sarebbe piaciuto e speravo che la montagna me lo concedesse. Così la notte tra il 31 luglio e il primo agosto, alle 4.40 del mattino, sono partito dal campo a 4.400 m alla volta della cima, 2.700 m più in alto. È stata una salita dura, resa ancora più difficoltosa dall’abbondante neve caduta nei giorni precedenti, ma alla fine, dopo 12 ore e 20 minuti, ho raggiunto la cima in un ambiente surreale.
La discesa è stata meravigliosa: nonostante la fatica, che inevitabilmente non ti permette di avere quella continuità nella sciata che hai a quote meno elevate, sono riuscito a godermi una neve a tratti farinosa, sorprendentemente molto meglio di quella che mi aspettavo. La degna conclusione di tutto. Un’ora e dieci minuti dopo ero di nuovo giù, ai piedi del ghiacciaio. 13 ore e mezza dopo la mia partenza. Non mi restava che attraversare per l’ultima volta la grossa morena che mi divideva dal campo da cui sono partito e tornare all’agglomerato di tende gialle con gli sci in spalla. A metà strada mi è venuta incontro la piccola Natalia ed è stato un piacere incontrare, prima di tutti, i suoi occhi sorridenti nonostante proprio quel giorno avesse fallito il secondo tentativo di arrivare in cima. Insieme siamo andati al campo base e dopo è stato tutto un susseguirsi di strette di mano, sorrisi, complimenti e vodka.
Cala Cimenti
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 108
Prove di collaborazione tra La Grande Course e ISMF
Dopo un matrimonio difficile e interrotto prematuramente, La Grande Course e International Ski Mountaineering Federation tornano a collaborare, come ha anticipato anche a Skialper Adriano Favre, presidente LGC, in un’intervista pubblicata sul numero di aprile, in uscita a breve. Favre si è incontrato con il suo omologo ISMF, Thomas Kähr, ad Arvier, in Valle d’Aosta, alla presenza delle delegazioni dei comitati esecutivi delle due organizzazioni. Uno dei primi passi concreti in questa direzione sarà l'organizzazione di un Campionato del Mondo long-distance all'interno di una delle gare LGC già esistente. Un team di progetto congiunto si occuperà di intraprendere gli interventi necessari per la realizzazione di questo obiettivo nel più breve tempo possibile. LGC ha, inoltre, manifestato la propria intenzione a collaborare attivamente all'interno di ISMF, in una modalità che dovrà ancora essere definita. Il desiderio di LGC è, quindi, quello di contribuire attivamente al rafforzamento di ISMF quale piattaforma globale per lo scialpinismo.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, ISMF dovrà avviare un progetto specifico di collaborazione e i vari settori di competenza all'interno di ISMF dovranno deliberare su questo progetto integrativo. Inoltre, i settori di collaborazione più importanti includeranno il potenziamento dei giovani talenti ma anche gli ambiti relativi all'anti-doping e all'attività dei giudici. Si pensa inoltre a un coordinamento nella comunicazione tra le due organizzazioni.
Transilvania, la polvere di Dracula
L’inverno 2015-2016 verrà ricordato come ‘l’inverno che non c’è’. Il tempo è passato a vedere i siti meteo inesorabilmente forieri di cattive notizie: anche questa settimana di neve non se ne parla e allora non resta che prendere le scarpette e andare a scalare. Così passano le vacanze di Natale, il Capodanno e anche oltre finché… Squilla il telefono e dall’altra parte il Cis mi dice: «Ho sentito un amico che lavora in Romania, lì c’è neve, potremmo andare a vedere». Fino a quel momento della Romania avevo solo un vago ricordo di un tema scritto a scuola, qualche film del conte Dracula, ma nulla che avesse a che fare con la neve o con lo sci. Dopo qualche ricerca su internet, mi trovo ad acquistare un biglietto con destinazione Bucarest ed eccoci davanti al check-in con in mano uno zaino e una sacca da sci. La ragazza addetta alle operazioni di imbarco guarda la sacca e con sorriso sornione ci domanda: «Sci? Non sapevo che in Romania si sciasse». Meno male che aveva tante doti, ma nessuna di queste legata alla neve o allo sci…

NEBBIA E POWDER Siamo un gruppo ristretto: io, il Cis (Andrea Cismondi) e Albi (Alberto Torassa). Dopo qualche ora di volo, sognando e fantasticando, ci ritroviamo ad atterrare a Bucarest. Sulla pista c’è un mucchio di neve. Bene, quella sarà l’unica che vedremo nella giornata in quanto la passeremo tra la nebbia e la pioggia. Mentre l'umidità ci entra nelle ossa, ritiriamo la macchina a nolo, una Ford Fiesta che scopriamo essere più capiente del previsto o noi più piccoli di quanto immaginavamo. Sta di fatto che riusciamo a infilarci tutto dentro. Durante il viaggio abbiamo cambiato programma svariate volte - il meteo non è stato decisamente dalla nostra parte - e in serata ci siamo ritrovati sulle montagne del Fagaras, in un albergo alla partenza della cabinovia che porta a Balea Lake. Qui conosciamo un addetto degli impianti di risalita che parla un cattivo italiano e ha lavorato per alcuni anni in Italia. Ci descrive la stagione come la peggiore degli ultimi 30 anni: «Poca neve». Perfetto, ecco il resoconto del primo giorno: tanti chilometri, tanta pioggia, niente neve. La tristezza e lo sconforto vengono placate solo dalla birretta serale. Però la mattina del secondo giorno ha un nuovo gusto, quello della polvere. La pioggia del giorno prima in quota ha lasciato una spanna di powder e dopo la colazione si decide il programma: andiamo su Balea Lake e rimaniamo in quota. Prendiamo la prima funivia, un impianto a fune vetusto che mi ricorda tantissimo la vecchia cabinovia per salire al Bianco. Il quadro reca la scritta Fitre Milano e mi sento quasi a casa.

BALEA LAKE, FINALMENTE NEVE La vista fuori cambia. Il verde e marrone lasciano spazio al bianco candido e… sbam! Siamo in inverno! Scendiamo a Balea Lake, un lago ghiacciato contornato da colate di ghiaccio e da canali di neve, il paese dei balocchi per noi. Prendiamo una stanza in un albergo sul lago e poi via, si montano le pelli agli sci: è il momento di dare spazio alla fantasia. Tutto da scoprire e da fare, in giro solo noi. La giornata ci regala tre discese su una spanna di polvere su fondo duro, concludendola alla grande mangiando omelette e bevendo birra. Ora il tutto inizia ad avere senso. La mattina seguente ripartiamo alla scoperta del territorio e, indossati i ramponi, con gli sci in spalla risaliamo il canale dietro all’albergo, che ci porta sulla cresta. Qui gli spazi si aprono e lo sguardo corre sul bianco delle montagne e i colori scuri della pianura. Una serie di discese ci regalano quel sound sognato per mesi: la libertà di sciare e di essere liberi di lasciare la nostra firma su un manto perfetto.

BENEDETTO SALVAMONT La vacanza continua: riscendiamo a valle, ricarichiamo la macchina e ripercorriamo al contrario la strada di qualche giorno prima con destinazione Busteni. Il terzo giorno ha inizio prendendo la cabinovia che ci porta sull’altipiano dei Monti Bucegi. Le previsioni meteo sono tornate brutte, un forte vento spazza l’altipiano e le nuvole viaggiano veloci. A peggiorare la situazione, Cabana Babele, il rifugio dove pensavamo di rimanere a dormire, ci delude: niente dormire, niente mangiare. In quota con brutto tempo, neve ventata, senza mangiare e senza bere… La giornata non poteva iniziare peggio e nello sconforto proviamo a raggiungere la capanna della Salvamont (quello che in Italia sarebbe il soccorso alpino) nella speranza di qualche buona notizia. Ed ecco come un inizio pessimo può trasformarsi in una gran giornata. È una stupenda baita di montagna e il tipo che vive dentro non solo ci offre un posto dove dormire ma ci darà da mangiare, indicazioni per le gite e per concludere in bellezza una sberla colossale di vino rosso. Rimaniamo due giorni sull’altopiano scorrazzando tra una vetta e un'altra, tutte con dislivelli molto contenuti, ma con gran neve e con il parco giochi a nostra disposizione. Qui ci facciamo anche una cultura sul soccorso alpino di zona e arriviamo a una sola conclusione: vietato farci male! L’ultima gita sull’altipiano, con destinazione Monte Omu e discesa nei canali fino a valle, viene stoppata a metà. Troppi accumuli da vento: vediamo di non andarcela a cercare! Cambiamo discesa e rientriamo a valle con la cabinovia per trasferirci in un albergo di Sinaia dove ci viene regalato l’ingresso in piscina, bagno turco e sauna: perché non approfittarne? Abbiamo sognato i pendii di Sinaia ma la nostra vacanza è terminata al Cota 2000, un bar sulle piste: tempo troppo brutto. Non ci resta che… fare tappa su Bucarest per dare uno sguardo alla capitale prima di caricare gli sci sul volo di rientro per l’Italia.
Questo articolo è stato pubblicato su Skialper 108

Ripresa agonistica? Troppo alto il rischio giuridico
L'elenco delle gare annullate, o rinviate, si allunga di giorno in giorno. Ma quando si potrà realisticamente tornare a correre in un trail o una sky marathon? Difficile a dirsi, di sicuro fino alla fine dello stato di emergenza, cioè il 31 luglio, appare improbabile che possa svolgersi una gara, alla luce anche dei rischi giuridici ai quali andrebbero incontro gli organizzatori. A questo proposito la FISKY, una delle federazioni coinvolte nell'organizzazione di eventi, ha preso una posizione chiara comunicando che «fino al 31 luglio 2020 non sono autorizzate manifestazioni che fanno riferimento alla nostra Federazione, salvo eventuali nuove disposizioni delle competenti autorità». Sull'argomento abbiamo chiesto un parere all'avvocato Flavio Saltarelli.
La ripresa agonistica per l’oudoor running non è dietro l’angolo. Sino a che il Covid 19 rappresenterà un probabile pericolo, anche giuridicamente sarà assai sconsigliabile gareggiare, se non a condizione di enormi rischi ed improponibili sforzi, anche economici, delle organizzazioni. Questo è ciò che ho in estrema sintesi risposto in questi giorni ai numerosi organizzatori di competizioni di trail e skyrunning i quali mi hanno interpellato domandandomi: Quando potremo riprendere a correre in gara? Che cosa eventualmente si rischia?.
La responsabilità degli organizzatori (come costruita dalla giurisprudenza) a tutela degli atleti si configura allorquando in gara gli atleti medesimi incorrano in pregiudizi non imprevedibili e riconducibili, secondo la miglior scienza ed esperienza, al comportamento colposo degli organizzatori. Ad oggi l’unica certezza per garantire la salute dal Covid 19 pare essere il mantenimento di un’adeguata distanza di sicurezza; distanza di sicurezza che non sarebbe ipotizzabile tenere ed assicurare in tutti i momenti delle competizioni di trail e skyrunning. Infatti, anche eventuali partenze a cronometro, non impedirebbero frazioni di gara caratterizzate da estrema vicinanza tra gli atleti (pensiamo ad esempio ai sorpassi); senza poi voler considerare le difficoltà di poter fruire della necessaria e tempestiva assistenza medica in loco.
Solo, dunque, attraverso un quasi impossibile monitoraggio temporalmente aggiornato con relativa certificazione della salute degli ammessi alla partenza gli organizzatori potrebbero tutelarsi, dimostrando di non essere in colpa in ipotesi di successivi sintomi da virus accusati dagli atleti partecipanti, sintomi la cui eziologia potesse essere riconducibile all’ambito della gara.
In via preliminare va ricordato che la colpa (intesa come imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline) è l’elemento costitutivo della responsabilità civile e penale; colpa che viene meno - di fatto - solo quando gli organizzatori sono in grado di dimostrare di aver assunto ogni precauzione a garanzia della salute degli atleti.
Sotto il profilo normativo, ai fini della responsabilità civile rileva l’art. 2043 del Codice civ. laddove obbliga il risarcimento di ogni danno conseguente a fatti lesivi ingiusti patiti; per quanto attiene la responsabilità penale le fattispecie di reato ipotizzabili sono, invece, quelle di lesioni ed omicidio colposo.
Più difficile - ma non impossibile - , inoltre, configurare a carico degli organizzatori, in ipotesi di scoppio di focolaio in seguito alla gara organizzata, il gravissimo reato di epidemia di cui all’art. 438 Codice Penale, il quale prevede: Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Trattasi di delitto che ha come elemento costitutivo il dolo (la volontarietà e la consapevolezza di cagionare l’epidemia) ma non impossibile da configurarsi anche nel caso di evento non voluto, ma frutto di comportamento gravemente imprudente, in quanto nel nostro ordinamento esiste anche il cosiddetto dolo eventuale che ricorre ove un soggetto - pur non volendo cagionare specificatamente un evento - essendo consapevole del pericolo, o dovendo esserlo, corre il rischio di cagionarlo e l’evento si verifica.
Da ultimo, non è remota la possibilità di finire alla sbarra per delitto colposo contro la salute pubblica, fattispecie prevista e punita dall’art. 452 del Codice penale che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque commette, per colpa, appunto, uno dei fatti preveduti dall’articolo 438 Cp., cioè contribuisce anche per imperizia o imprudenza al diffondersi di un’epidemia.
Ski Trans Alt Tirol
Novembre 2017. Attenzione, quella che avete sotto gli occhi non è la solita proposta. È la sintesi di un percorso durato diversi anni... qui dentro c'è tutta l'essenza della mia personale chiave di lettura dello scialpinismo. C'è la mia formazione di geografo, la passione per la storia, il piacere di perdersi tra le montagne, il valore della condivisione e il vizio di documentare l'esperienza per non perdere un giorno i ricordi e le emozioni vissute…
Avrei potuto tenere questo viaggio per me, invitare solo qualche amico intimo, invece ho deciso di provare a realizzarlo in quella che sento essere la mia veste più naturale, e cioè quella della Guida alpina. Se qualcuno raccoglierà il mio invito e vorrà unirsi anche solo per un tratto di questo lungo viaggio, ne sarei onorato!
Dopo diverse stagioni di incubazione, nell’autunno scorso finalmente il progetto sembrava delinearsi in maniera chiara nella mia mente ed era pronto a essere partorito. Così mi sono deciso a prendere la tastiera stendendo le specifiche minime per spiegarlo alle persone che intendevo coinvolgere e ho inviato il file, accompagnato dal messaggio di cui sopra. È questo il gioco che mi attira dell’alpinismo: prendere un’idea, un sogno, una visione, per quanto balzana o assurda, valutarla da ogni angolazione, magari scartarla, oppure digerirla, metabolizzarla, pianificarla, attendere il momento opportuno, agire e infine trasformarla in qualche cosa di concreto, tangibile, vero. Un po’ come rubare piccoli lembi da una dimensione fantastica e immaginaria e portarli nel mondo reale. Una chiave di lettura che può essere applicata alle vie nuove, o alle discese con gli sci, e che in questi anni ho spesso provato a portare anche all’interno del mio lavoro di Guida, con proposte o progetti un po’ particolari e insoliti. Per quanto riguarda questa traversata del Tirolo Storico, credo che l’idea sia nata davanti a una carta, anzi una piccola mappa in rilievo delle Alpi che tengo appesa alla parete di casa. Un giorno ho posato l’attenzione sulla zona di massima estensione dell’arco alpino sull’asse Nord-Sud, segnalata in basso giusto dall’inconfondibile goccia del Lago di Garda, e da lì sono partito alla ricerca di un percorso dove il rilievo subisse meno interruzioni possibili e permettesse di rimanere in quota. Ho sempre avuto il desiderio di perdermi dentro alle montagne, di starci il più tempo possibile, per godere quelle sfumature che le gite mordi e fuggi spesso non lasciano il tempo di cogliere e niente meglio dello scialpinismo di traversata si adatta a questo proposito! Quel che è successo dopo è pura fortuna. Mano a mano che seguivo con gli occhi questo ipotetico percorso, mi sono reso conto che la linea più logica dal Garda correva attraverso la Catena del Lagorai, dove sono cresciuto, e poi sulle Dolomiti, per proseguire sulle montagne dell’Alta Pusteria e quindi fino in Austria. Ho provato a figurarmi il percorso in inverno ed ho capito di aver trovato la vena d’oro: un vero e proprio regalo della natura che sembrava concedere un viaggio con gli sci in un contesto scenografico unico per varietà e spettacolarità. Dagli uliveti di un piccolo angolo di Mediterraneo incastonato tra le montagne ai mastodontici ghiacciai degli Alti Tauri, attraversando zone non certo molto frequentate, ma sempre provvidenzialmente provviste di strutture in grado di fornire il necessario supporto logistico.

In seconda battuta ho realizzato che la linea ideale correva giusto lungo il confine di quello che fino al secolo scorso era il Tirolo Asburgico, ovvero la regione più meridionale dell’immenso impero Austro-Ungarico. I primi ordinamenti che sanciscono l’estensione del territorio tirolese dal Lago di Garda fino alla zona montuosa del Kaisergebirge risalgono agli inizi del 1500: da quel tempo lontano, i confini del Tirolo storico rimasero pressoché invariati fino al termine della Prima Guerra Mondiale, quando le province di Trento e Bolzano vennero annesse al Regno d’Italia. Le genti che abitano questa regione transfrontaliera risultano pertanto accomunate da secoli di storia, con tratti distintivi comuni che ancora oggi sopravvivono nonostante l’appartenenza a nazioni diverse, e la suggestione di poterle idealmente riunire con questa traversata mi sembrava un ulteriore valore aggiunto. Certamente non volevo dare alcuna connotazione politica dell’iniziativa, ma questo collegamento dettato al contempo dalla geomorfologia e dalla storia mi è sembrato avere quasi un valore di messaggio universale, ovvero quello delle montagne come spazio d’unione, piuttosto che elemento di separazione come spesso si vorrebbe far credere. Il caso ha voluto che durante la traversata il Tirolo Storico fosse sempre presente, da un vecchio calendario di stampo asburgico trovato in un bivacco sul Lagorai alle stampe storiche dei bed & breakfast dove abbiamo dormito. In ogni modo, l’entusiasmo e l’apprezzamento che ho raccolto ancora prima di partire mi ha sorpreso e gratificato ed è stato lo stimolo decisivo per buttarsi a capofitto in quest’avventura. La traversata è stata pianificata a tappe di tre giorni ciascuna, da svolgersi ogni due settimane in maniera da poter sfruttare i periodi con le condizioni presumibilmente ottimali. Le tappe in programma erano sette, per un totale di 21 giornate sugli sci su uno sviluppo di poco inferiore ai 400 chilometri. Giovanna e Alberto sono stati i temerari che si sono offerti di seguirmi in tutti gli appuntamenti, dall’inizio alla fine, mentre tanti altri amici si sono aggregati a una o più tappe, ognuno compatibilmente con i propri impegni. Viste le ambiziose premesse, ci voleva una partenza in grande stile e dai connotati simbolici: così siamo partiti direttamente con gli sci in spalla dal centro storico di Riva del Garda, un tempo estremo avamposto sud-occidentale della Mitteleuropa, e abbiamo preso una barca a vela per navigare sul ‘fiordo’ del Garda fino a Malcesine, dove la funivia del Monte Baldo ci ha portati in quota, permettendoci di calzare gli sci in direzione Monte Altissimo di Nago.
La prima giornata si è conclusa a Festa di Brentonico e l’indomani per portarci sul Monte Stivo abbiamo inforcato le E-bike, giusto per adattarci allo stile vacanza outdoor che tanto caratterizza l’Alto Garda. Dal rifugio Marchetti la terza giornata ci ha visto seguire la lunga cresta che conduce alle Tre Cime del Bondone, raramente percorsa d’inverno, per poi riprendere le biciclette e scendere fino in Piazza Duomo a Trento, per un aperitivo in grande stile all’Aquila d’Oro, dove anche la statua del Nettuno pareva guardarci perplessa. Due settimane più tardi abbiamo iniziato a fare sul serio e, nonostante il maltempo, siamo salpati per la mitica traversata del Lagorai. Devo dire che da quando ho memoria scialpinistica ho visto davvero pochissimi gruppi, forse tre-quattro in tutto, portare a termine il percorso integrale che dal Monte Panarotta porta al Passo Rolle o viceversa. La carenza di punti di appoggio lungo il percorso obbliga a tappe lunghe e complesse e di certo scoraggia l’approccio a questa magnifica Haute Route che attraversa vallate silenziose e fuori dal tempo. Vista la quantità di neve fresca presente e la scarsa visibilità, anche noi abbiamo dovuto deviare dal tracciato ottimale ed evitare diverse cime, ma è stato comunque un punto di orgoglio riuscire a portare a termine queste due tappe difficili dove serve anche spirito di adattamento e lavoro di squadra.

A marzo siamo approdati in Dolomiti, dove la presenza antropica cambia radicalmente, ma come tutti sanno la scenografia è talmente grandiosa da lasciare sempre a bocca aperta. Nei primi tre giorni dal Rolle a Corvara abbiamo ancora pagato pegno con il meteo, sebbene con dei risvolti positivi, come la possibilità di affrontare la Val Mezdì, alias il fuoripista più famoso e gettonato delle Alpi Orientali, in perfetta solitudine! Quando è stato il tempo di ripartire dalla Val Badia, però, ai piani alti hanno deciso che dopo tante bastonate era il tempo della carota, e ci sono state regalate tre giornate da cineteca, con neve commovente e un susseguirsi ininterrotto di scenari mozzafiato: Lagazuoi, Fanes, Sennes, Croda Rossa d’Ampezzo, Tre cime di Lavaredo… per rubare le parole all’amico e collega Marco Maganzini, «SciAlpinismo con la A maiuscola, tra pareti di disperante verticalità!».
In aprile abbiamo provato a sfuggire all’avanzare della primavera alzandoci di quota e inoltrandoci nel gruppo delle Vedrette di Ries, inseguiti da un caldo feroce ed esagerato… qui per la prima volta siamo dovuti tornare sui nostri passi e rinunciare a svalicare sul Collalto, visto che alle 9.30 del mattino a 3.000 metri c’erano quindici gradi. Il gran finale, ovvero i tre giorni conclusivi, ci hanno visto invece impegnati sugli Alti Tauri. Da programma inizialmente avevo pensato di spingermi fino al Grossglockner, ma il tempo splendido e le condizioni strepitose ci hanno invogliato a chiudere in bellezza con tre belle cime: in ordine Picco dei Tre Signori, Großer Geiger e GroßVenediger, prima di scendere fino a Matrei e quindi a Lienz, con prati e alberi ormai in fiore ad annunciare il cambio di stagione.

Mi sono chiesto che cosa resterà di questa fantastica cavalcata da Sud a Nord. Sicuramente gli incontri lungo il percorso, perché una traversata di questo tipo è fatta anche per conoscere persone, prima fra tutti i tanti rifugisti con i quali abbiamo condiviso fantastiche serate. E poi tre momenti emergono sopra a tanti ricordi. Dal punto di vista paesaggistico la lunga tappa dal Lagazuoi al rifugio Sennes, nel cuore delle Dolomiti, davvero una di quelle scialpinistiche che ti rimangono nella testa a lungo. Per quanto riguarda lo sci, non dimenticherò i mille metri di dislivello su perfetto firn, tutti tra i 25 e 30 gradi, dal Collalto, sopra Anterselva, e la lunghissima discesa dal GroßVenediger, con oltre 2.000 metri di dislivello. Col senno di poi, direi che meglio di così non poteva andare: al di là delle 14 giornate di bel tempo sulle 21 totali e delle ottime condizioni d’innevamento, la traversata è stata letteralmente al di sopra delle aspettative, e questo soprattutto grazie al fattore umano, ovvero la passione che tutti i partecipanti hanno messo in questa piccola grande sfida. Come ha detto giustamente Barbara, siamo stati trascinati in un turbine di emozioni e amicizia. Per questo sarò eternamente riconoscente a tutti gli amici che ci hanno creduto e mi hanno aiutato in tante maniere diverse, dai sopralluoghi preventivi ai carichi di viveri da portare in bivacco, fino al grosso lavoro fatto con foto e riprese per documentare adeguatamente l’esperienza. A nome di tutti, credo di poter dire che la prima attraversata scialpinistica del Tirolo Storico sia stata e rimarrà un’esperienza indimenticabile: ora la strada è aperta, e auguriamo a quelli che in futuro vorranno ricalcare il nostro cammino di divertirsi almeno quanto noi! E io, finalmente, ho potuto tagliarmi la barba. Sì, perché me l’ero tagliata appena prima della partenza a gennaio e durante la prima tappa mi hanno detto: adesso lasciala crescere per tutta la traversata. Così ho fatto, aspettando l'ultimo giorno per tagliarla!
Traversata del Tirolo Storico
Tappe 1-3: dal 12 al 14 gennaio 2018, da Riva del Garda a Trento via Malcesine, Monte Grande, Monte Altissimo di Nago, Monte Stivo, Cima Alta, Cornetto del Bondone, Viote.
Tappe 4-6: dal 2 al 4 febbraio 2018, dalla Panarotta alla Val Campelle via passo della Portela, lago di Erdemolo, rifugio Sette Selle, passo dei Garofani, Passo Cadino, lago delle Buse, forcella Montalon, forcella Valsorda, Colle di San Giovanni, Malga Conseria.
Tappe 7-9: dal 23 al 25 febbraio 2018, da Malga Sorgazza a San Martino di Castrozzavia forcella Magna, Malga Val Cion Alta, passo Copolà, rifugio Refavaie, cima Paradisi, cima Fossernica, Malga Miesnotta di sopra, forcella Valzanchetta.
Tappe 10-12: dal 9 all’11 marzo 2018, da Passo Rolle a Colfosco in Badia via Monte Mulaz, Falcade, Passo San Pellegrino, Forca Rossa, Malga Ciapela, Marmolada, Porta Vescovo, Passo Pordoi, rifugio Boè, Val Mezdì.
Tappe 13-15: dal 23 al 25 marzo 2018, da passo Falzarego alla Val Fiscalina via Lagazuoi, forcella del Lago, rifugio Fanes, forcella Ciamin, Fodera Vedla, rifugio Sennes, Ra Stua, forcella Colfiedo, passo Cima Banche, Lago d’Antorno, rifugio Auronzo, rifugio Locatelli, valle di Sasso Vecchio.
Tappe 16-18: dal 6 all’8 aprile 2018, da Santa Maddalena in Val Casies a Riva di Tures, via Hoher Mann, forcella Hexenscharte, Passo Stalle, lago di Anterselva, Schwarze Scharte (respinti!), trasferimento con mezzi pubblici a Riva di Tures, salita al triangolo di Riva e discesa per la Valle dei Dossi.
Tappe 19-21: dal 20 al 22 aprile 2018, da Predoi a Matrei, via Picco dei Tre Signori, Reggentörlscharte, Essener und Rostocker Hütte, Großer Geiger, Kürsinger Hütte, Venediger Scharte, GroßVenediger, Gschlosstal, Tauer.
Mezzi di trasporto utilizzati: Barca a vela, funivie e seggiovie, E-bike, furgone Fiat Ducato, treni, autobus.
Lunghezza tappe: tra i 900 e i 2.300 metri di dislivello, gradualmente in crescendo.
Dislivello medio giornaliero: 1.300 metri.
Sviluppo medio giornaliero (solo sci, senza i trasferimenti): 22 chilometri.
Sponsor: Scarpa, Millet, Völkl, Marker, Julbo, APT Valsugana, Guide Alpine Mountime-Outdoor Adventures
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 118

Tour de La Meije quattro giorni au refuge
Continua la pubblicazione dei più interessanti articoli di viaggio di Skialper per non dimenticare che gli sci sono la migliore scusa per partire alla scoperta del mondo.
1893. È già passato un po’ di tempo se ci riflettiamo. Una storia racconta che quattro persone tra cui Cristophe Iselin si incontrarono verso sera fuori dal paese di Glarus, quasi di nascosto, per non stuzzicare la curiosità e l’ilarità dei vicini: da lì partirono con sci verso il colle Pragel. Uno era con le racchette ma le cronache giustamente non lo citano troppo volentieri. La salita in sci al suddetto passo, quota 1.554 metri, nel Canton Glarona, in Svizzera, è da considerarsi la prima vera scialpinistica sulle Alpi. A scanso di fake news, si può dunque pensare che quel giorno sia iniziata la storia dello scialpinismo. Mi è sempre piaciuto pensare che questa disciplina non si sia mai allontanata troppo dalle proprie origini: gli sci rimangono il miglior modo di muoversi in montagna in ambiente innevato. Non ce n’è. Sono fatti per sostenere, distribuire il peso sul manto nevoso limitando la fatica dei nostri spostamenti, aiutandoci e agevolandoci. Non saremmo lì in mezzo alle bianche alture senza di loro. O forse ci saremmo, magari con un paio di ciaspole, ma forse a quel punto avremmo pantaloni attillati, zaini enormi, pile rossi, calli sulle caviglie e sui polpacci e insomma… addio stories su Insta, salamini gratis da parte del salumificio dello zio che ci sponsorizza e zero tipe rimorchiate in ufficio mostrando le discese del weekend mentre ululiamo giù da vertiginosi pendii cercando di avere l’espressione delle Guide di Cham.

Forse diamo troppo per scontata l’importanza dei nostri sci. Ma è la loro natura intrinseca di mezzo di trasporto che ci consente di fare i fighetti. E come ogni mezzo di trasporto sono fatti per permetterci di affrontare un viaggio. Uno spostamento che si compie da un luogo di partenza a un altro distante dal primo. Una linea che collega due punti sulla neve. L’occasione per riscoprire l’essenza dello scialpinismo è stata del tutto inaspettata. Il cellulare si illumina: messaggio. È Mathias, un collaboratore di una rivista francese sempre del settore sci e outdoor. Mi informa che i rifugisti degli Écrins e l’ente turismo dei Pais des Écrins, nelle Alpi del Delfinato, in Francia, stanno organizzando un viaggio stampa per promuovere e far scoprire il loro meraviglioso massiccio. Un raid a sci negli Écrins! Meraviglia! La risposta è ovvia. Il massiccio transalpino lo conosco abbastanza bene, da Torino non è così distante e offre un terreno selvaggio con infinite discese, canali, pareti. Una mecca dello sci, selvaggia e spesso isolata. Negli anni però l’approccio è sempre stato un po’ mordi e fuggi. Quando ho cercato di ricordare tutte le volte che ero stato da quelle parti, la sequenza che mi veniva in mente è stata sempre più o meno la stessa:
- Uno: sveglia ad orari in cui la Convenzione di Ginevra vedrebbe certamente la violazione dei diritti umani;
- Due: caffè e biscotti in automatismo;
- Tre: macchina, motore, fari, cassa dritta propedeutica all’occhio aperto;
- Quattro: appuntamento tipo scambisti in qualche parcheggio autostradale o meglio di centro commerciale… con le quattro frecce;
- Cinque: auto, velocità elevata;
- Sei: arrivo, salita, sciata;
- Sette: birra, Pastis, nutrimento, guarda foto, guarda parete, discuti, sogna;
- Otto: auto, velocità elevata (ma in senso contrario);
- Nove: ritardo;
- Dieci: fai cose, dimostrati disponibile con i tuoi cari, sei in ritardo, dimostrati collaborativo.

Una sorta di decalogo, operazioni automatizzate. Che è un po’ quello di chi si spara le gite in giornata. Qualche menoso dirà che è un modo consumista figlio dei nostri tempi. Sì. Ma siamo un po’ tossici dell’aria aperta e della neve, con la faccia abbronzata delle Guide di Cham, sempre loro, ma magari abitiamo a 200 chilometri da dove vorremmo sciare, lavoriamo in ufficio, cantiere, ospedale o in università: quindi appena possiamo settiamo quella maledetta sveglia ancora un quarto d’ora prima perché magari ci scappano altri 300 metri in più. Un raid però è diverso. È un viaggio, ci si sposta in montagna, si entra in sintonia, si rimane ovattati dall’ambiente che ci circonda. Si riesce ad entrare in esso, passando attraverso diversi stati d’animo, ascoltando il proprio corpo, specie il giorno in cui le gambe andranno meno. Da un punto a un altro, una linea, con gli sci. Un sogno. Dopo gli ultimi consulti sul meteo, non proprio stabile dopo un inverno secco e avaro di precipitazioni come quello di quest’anno, il raid viene confermato. Il tour della Meije, giro classico del massiccio. Quattro giorni La Bérarde to La Bérarde: nel mezzo tutti i rifugi e i loro gestori che accolgono alpinisti e scialpinisti in queste vallate remote. Si parte! Dopo una notte a La Grave in un posto degno di un film di Tarantino, con Federico arriviamo a La Bérarde sorprendentemente in orario. Si conosce il gruppo, si fa un piccolo briefing con le due Guide, Julia e Mathilde, e si parte in direzione del vallone di Etacons, dominato dal versante meridionale della Meije. Nei viaggi, oltre ai chilometri, al dislivello e alle discese, sono le persone che si incontrano, spesso per la prima volta, a caratterizzare la linea del percorso. Le impressioni che riceviamo da questi incontri diventano un tutt’uno con quelle del nostro movimento, creando l’esperienza. In questo caso abbiamo avuto l’occasione di condividere il rifugio quasi sempre con i soli rifugisti, complice la poca gente in giro e le previsioni non così definite. E fu così che…

Sandrine - Refuge du Promontoire
Oggi il menù prevede solo salita. Non c’è fretta, abbiamo tutta la giornata per arrivare al Refuge du Promontoire. Il set-up che preferisco per i raid classici non è leggero, lo sci è largo e lo scarpone un onesto 1.400 grammi. Piuttosto si alleggerisce lo zaino con meno cambi e pazienza per i vicini di branda. Le nuvole in cielo intanto si dissipano e arriviamo al Refuge du Châtelleret proprio dove il piatto vallone inizia a impennarsi in direzione Brèche de La Meije. Charles, occhi blu, mascella squadrata e abbronzatura non certo timida, ci accoglie con la sua compagna in questa isola spersa nel sole del vallone circondato da picchi che ben superano i 3.500 metri. Dopo una meravigliosa omelette, ripartiamo alla volta del Promontoire dove le nuvole che ci avevano avvolto con del nevischio lasciano posto a un bel sole. La gestrice è Sandrine, una gentile ragazza bionda. Giovane, con sorriso che lascia trasparire timidezza e una luce irrequieta negli occhi. Quelle persone che sembrano scappare da qualcosa. Le primissime rughe intorno agli occhi blu confermano che in realtà sta vivendo la vita che ha scelto: nata a Chamonix, sono sei anni che gestisce dei rifugi dopo aver lavorato per quattro come aiuto al Refuge Albert 1er ai piedi dell’Aiguille de Chardonnet, nel Bianco. Sandrine serve tutti, sparecchia, rassetta la cucina e poi mangia anche lei in sala. Convincerla a fare qualche foto si scontra con la sua timidezza, ma ce la facciamo e le strappiamo una risata quando ci improvvisiamo come sui set con le modelle e le chiediamo prima uno sguardo imbronciato e poi una mano nei capelli e uno più sexy. Ci perdonerà, credo. Ah, sappiate che Sandrine vi scatterà anche lei qualche foto: con una piccola automatica bianca, ruberà un momento del vostro passaggio per ricordo, senza chiedervi di mettervi in posa, quasi di nascosto. È timida, l’ho detto.
Jeff - Refuge de l’Aigle
Il giorno seguente, se non sarete trascinati a valle dal compagno che si dovrà legare con voi e se scamperete le insidie della conserva corta con gente poco avvezza ai ramponi risalendo il budello del Serret du Savon, ai piedi dei seracchi della parete Nord della Mejie, arriverete in quel magnifico nido d’aquila (appunto!) che è il Refuge de L’Aigle. Siamo su un cucuzzolo ai piedi della Meije Orientale che domina il caleidoscopico Glacier de l’Homme e il vasto Glacier du Tabuchet. Jeff è il rifugista: sulla cinquantina, sorriso da marinaio. A sedici anni è scappato da Parigi, biglietto sola andata per le montagne del Sud della Francia. Un richiamo a cui non ha saputo resistere. Ha lavorato prima come portatore, poi al Refuge du Viso e quindi al Refuge des Écrins. Fino all’anno scorso quando… Chiacchierando, ho collegato questo dettaglio subito e ho capito che mi trovavo davanti alla voce che per anni mi ha risposto al telefono quando chiamavo il Refuge des Écrins per chiedere info sulle condizioni e nevicate di fine primavera. Tutto per capire se sarebbe stato il giorno buono per scendere integralmente i 4.102 metri della Barre des Écrins per il versante Nord. Mai una volta che all’accento italiano rispondesse con info certe: solo pessimismo, desolazione e condizioni catastrofiche. Poi puntualmente il giorno dopo almeno una pulminata di francesi scendeva la parete. Eccolo davanti a me il maledetto! Non sembra neanche così scorbutico, anzi è simpatico, tanto che alle mie rimostranze la serata si anima e finiamo con una risata davanti a una birra. Accidenti a te Jeff!
Sabine - Refuge Villar d’Arène
Dopo la notte all’Aigle, il risveglio sul mare di nubi dopo una lieve nevicata fa sorgere qualche dubbio sul fatto di essere effettivamente svegli. Forse si sogna ancora e il dubbio permane anche durante la discesa del Tabuchet, intonso fino a Villar d’Arène. Dopo un provvidenziale passaggio a Pied du Col il nostro gruppetto riprende a salire in direzione del rifugio per la notte. La giornata è primaverile e la luce sulle pareti nord dell’Agneaux, in fondo al Cirque d’Arsine, fa capire che sarebbe il momento buono per sciarle. Questa notte dormiremo al Refuge Chamossière. Essendo però un viaggio alla scoperta dei vari rifugi che potrebbero fare da appoggio a questo raid, è d’obbligo una tappa enogastronomica al rifugio di Villar d’Arène, situato a circa cinquanta metri lineari dal Chamossière. Qui facciamo la conoscenza con Sabine, 20 anni trascorsi in questo angolo di paradiso. E arriva anche il momento critico del viaggio: la tarte au chou di Villar d’Arène. Una torta-sformato di cavolo, castagne e carni assortite che Sabine ci presenta con un sorriso sfidante. Ragazzi dimenticatevi tutte quelle barrette, cibi, gel che riportano la scritta energetica. Qui si gioca in un altro campionato. Eccellenza contro Champions League. Un’iniezione calorica e di fiducia in se stessi. Sabine si ripresenta al nostro tavolo solo dopo più di un’ora. A raccogliere i cocci di un gruppo disfatto dalla sfida appena sostenuta e a condividere ancora un dolce e un sorso di vino. Menzione per Federico a tavola: testa altissima.
Seb - Refuge Chamossière
Se qualcuno dicesse che Seb Louvet è uno che fa 1.300metri/ora non penso che si vedrebbero molte mani alzate di saputelli contestatori o diffidenti. Lo si capisce subito. Entri nel rifugio, curato come una spa, e ci si imbatte in una cyclette con i pedalini. Si allena dunque anche col brutto. Quindi si allena sempre. Seb è magro, molto magro. Persino le mani, seppur decisamente forti, sono magre. Seb corre, pedala, scia. E non lo fa piano. Seb è colui che ha organizzato il tutto per promuovere il giro della Meije e i suoi rifugi. Ha capito che i rifugi funzionano e rendono se costituiscono una rete tra di loro. Negli Écrins ci sono due associazioni di rifugi in base ai dipartimenti regionali, Hautes Alpes e Isère, ma sarebbe meglio che si ragionasse nell’ambito del massiccio e non secondo suddivisioni burocratiche. Il rifugista ci fa notare che l’attenzione è sempre maggiore, anche da parte della politica e degli enti turistici. Ci confessa che sua madre quando era giovane gli avrebbe dato dei soldi per dormire in un albergo piuttosto che saperlo in un rifugio. Erano luoghi più spartani, un punto di ricovero tra il parcheggio e la cima prefissata. Ora è diverso, il tempo dell’alpinismo vero in questa parte di Écrins secondo Seb è finito. Si lavora molto più con il trekking e il trail running. Il rifugio è diventato una meta a se stante al pari di una cima. Il Chamossière è un gioiellino molto curato con tanto legno e materiali naturali utilizzati per la ristrutturazione. Vale la pena di venirci anche solo per vederlo e cenare. A Seb piace chiacchierare e ci confessa che non sente alcuna competizione con il vicinissimo rifugio di Villar d’Arène di Sabine, anzi collaborano e si aiutano. La cucina di Sabine è super, ma lui ci va solo a prendere il caffè perché se no addio ai sacrifici che fa con l’allenamento. Per Seb quella del rifugista non è stata una vocazione, ma uno scherzo del destino: la prima cosa che aveva iniziato a sorvegliare era una rifugista dell’Adèle Planchard. La vita è strana.
Fanny - Refuge Adèle Planchard
Oggi si torna alla Bérarde, ma allunghiamo il giro verso il Col della Casse Désert per passare a conoscere il nuovo gestore del rifugio Adèle Planchard. Ventitre anni, riccioli d’oro e occhi azzurri: Fanny sorride nel suo piccolo regno al cospetto delle più belle montagne degli Écrins, ai piedi della Grand Ruine. Non ci fermiamo molto, ma quanto basta per capire che, seppur così giovane, ha trovato il suo mondo. La sua pace. Serenità, se dovessi scegliere una sola parola per descriverla. Ad aiutarla Cristophe, un omone timido che d’estate fa il malgaro in un altro massiccio transalpino. Omelette di rito e salpiamo a riprendere la nostra linea immaginaria che chiuderà il cerchio alla Bérarde. Oggi le gambe van da sole. La discesa sui pendii Ovest della Casse Déserte passa dalla farina alla neve trasformata senza praticamente nessuna zona di transizione. Ambiente Écrins, l’aria in faccia, sole. Ognuno un po’ per sé, liberi. Perché fare scialpinismo? Perché è bello.
TOUR DE LA MEIJE
Il raid in sci de La Meije è uno dei più classici e famosi delle Hautes Alpes. Un percorso vario, in alta montagna, riservato a scialpinisti preparati, a loro agio anche con ramponi e qualche basilare manovra alpinistica. Un itinerario che si può prestare a numerose varianti, regolando i tempi di percorrenza in funzione delle ambizioni e delle condizioni del momento. Il periodo migliore generalmente è ad aprile. Gli Écrins e i loro rifugi vi sapranno stupire. Quello che i nostri inviati hanno percorso è l’anello con partenza e arrivo alla Bérarde, sperduto paesino francese, vero cuore del Massif des Écrins.
Giorno 1: La Bérade (1.720 m) – Refuge du Promontoire (3.092 m)
Milletrecentosettandue metri di sola salita per raggiungere uno dei più iconici e famosi rifugi del massiccio, arroccato ai piedi della cresta del Promontoire. Dalla Bérarde risalire il vallone des Etacons, superare il Rifugio Châtelleret (altro punto d’appoggio) e dirigersi verso la Brèche de La Meije. Giunti sui pendii che la precedono, svoltare verso destra riportandosi in direzione delle rocce della cresta del Promontoire, dove sorge il rifugio.
D+ = 1.372 m
Difficoltà = 2.3 E1
Giorno 2: Refuge du Promontoire (3.092 m) – Brèche de La Meije (3.357 m) – Serret du Savon (3.399 m) - Refuge de L’Aigle (3.450 m)
Dal Promontoire, prima con le pelli e poi con i ramponi, reperire la Brèche de La Meije (100 m, 45°), quindi a seconda delle condizioni scendere il ghiacciaio lato La Grave per circa 300 m e ripellare quindi costeggiando la parete Nord del Gran Pic della Meije fino in corrispondenza dell’attacco del Couloir Gravellotte (sceso da Tardivel nel 1997); proseguire in discesa svelti sotto i seracchi del Corridor fino alla base del Couloir del Serret du Savon che si risale per circa 250 m (massimo 45°) e poi brevemente con le pelli si arriva al Refuge de l’Aigle.
D+ = 900 m circa in funzione del punto delle ripellate
Difficoltà = 3.3 E3 (tratto sotto ai seracchi, couloir a 45° in salita, tratto alpinistico in discesa o possibile doppia dalla Brèche della Meije)
Giorno 3: Refuge de L’Aigle (3.450 m) - Meije Orientale (3891m) - Villar d’Arène (1.600 m) – Pont de l’Arsine (1.700 m) – Refuge Chamossière (2.106 m)
Dal Refuge de l’Aigle salire alla sella Nord della cresta a sinistra della cima della Meije Orientale, percorre tutta la cresta con passi di misto facile in funzione delle condizioni e giungere in vetta. Una volta tornati al luogo dove si sono lasciati gli sci è possibile scegliere tra la discesa del Glacier de l’Homme (soluzione più diretta e che vi porta già più vicino al Rifugio Chamossière senza bisogno di passaggi) o quella del Glacier du Tabuchet da noi percorsa fino a Villar d’Arène. Da qui in autostop raggiungere il parcheggio nei pressi del camping di Pont d’Arsine e in circa un’ora e mezza raggiungere il rifugio con comoda salita.
D+ = 800 m
D- = 2.200 m
Difficoltà = 3.3 E1
Giorno 4: Refuge Chamossière (2.106 m) – Col de la Casse Déserte (3.483 m) – La Bérarde (1.720 m)
Dal Rifugio salire il pianeggiante e lungo vallone di Valfourche passando sotto all’evidente canale Nord della Roche Faurio, poco prima di giungere al canale della Brèche Charrier, ben visibile davanti a voi, svoltare sulla destra e rimontare il vallone via via più ripido (ultimi 100 m a 45°) fino al Col de la Casse Déserte. Da lì scendere i pendii ovest (primi 100 m ripidi, possibile doppia) fino a reperire il vallone di Etacons poco sotto al Rifugio Chatelleret e di qui alla Bérarde.
D+ = 1.400 m
D- = 1.700 m
Difficoltà = 3.3 E2
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 124

Great Himalaya Trail, 24 giorni che ti cambiano la vita
In questi giorni in cui abbiamo tutti un po' voglia di evadere e andare lontano riproponiamo l'articolo sul Great Himalaya Trail e l'impresa del runner sudafricano Ryan Sandes. Per non smettere mai di sognare
Dopo ventiquattro giorni, quattro ore e ventiquattro minuti oppure 1.504 chilometri o ancora 70.000 metri di dislivello positivo su e giù per i sentieri dell’Himalaya con i tuoi piedi impari due lezioni che ti aiuteranno a trovare la strada giusta per il resto della vita. «Dobbiamo apprezzare le cose semplici, ci affanniamo per avere sempre di più e non ci godiamo la nostra famiglia e quello che abbiamo: se sei felice potrai inseguire i tuoi sogni, però se vivi per inseguire i tuoi sogni ma sei infelice, non li realizzerai mai». La prima lezione sembra (ed è) un insegnamento buddista. «Sono stato in villaggi minuscoli, lontani da tutto e da tutti, con tanta povertà, eppure sono felici e ti aprono la porta alle undici di notte, nel buio immenso, ti preparano da mangiare e ti fanno dormire senza chiederti chi sei, mentre noi abbiamo perso il giusto punto di vista e per ritrovarlo non ci rimane altro che scappare dalla civiltà e dal bombardamento di informazioni e social media, camminare nella natura, correre per ritornare in noi stessi». I Beatles andarono in India per ritrovare la loro ispirazione. Il trail runner sudafricano Ryan Sandes, il primo uomo a vincere tutte e quattro le 4 Deserts race, l’uomo che ha vinto una gara ultra-trail in ognuno dei sette continenti, tra le quali anche la Leadville e la Western States, non è nuovo a imprese da record nella natura, eppure il lungo viaggio del Great Himalaya Trail, da un confine all’altro del Nepal, lo scorso marzo in compagnia dell’amico e compagno di tante avventure Ryno Griesel, lo ha fatto tornare a casa diverso. È un viaggio incredibile, dalle vette più alte del mondo alla giungla. Ma è anche un viaggio alla scoperta di se stessi. «È stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita, in positivo. Penso che sia stata la tappa finale di un percorso, la cosa più grande che abbia mai fatto e sono molto soddisfatto, ma non la ripeterei».
Il Great Himalaya Trail non è un solo sentiero, ma la combinazione di vari itinerari sia nella parte montuosa del Nepal (GHT High Route) che in quella più popolata e ricoperta dalla giungla (GHT Cultural Route) e va da un confine all’altro del Paese, lungo la direttrice Ovest-Est. Per questo, sebbene Ryan e Ryno abbiano fatto segnare il FKT (fastest known time), non si può parlare di vero e proprio tempo record in quanto un crono di riferimento non esiste data la possibilità di alternative lungo il percorso e le varianti imposte dai tanti imprevisti. Quello seguito dai due sudafricani ripercorre fedelmente le orme del connazionale Andrew Porter dell’ottobre 2016 ma, per esempio, Lizzy Hawker, nel 2016, ha fatto segnare un tempo di riferimento lungo la parte in quota del GHT, tra le montagne. «Quello che volevamo non era un record a tutti i costi, ma un’avventura che unisse la bellezza delle vette più alte del mondo alla possibilità di conoscere la cultura e le città perché per me, che vengo da Città del Capo, trail running significa correre nella natura, ma non in montagna». Una lunga avventura… «Dopo la vittoria alla Western States 100 dello scorso anno cercavo proprio qualcosa del genere e l’Himalaya mi ha sempre attirato, però mi spaventava la lunghezza del percorso perché voglio anche continuare a partecipare alle gare ultra e devo avere il tempo di recuperare». Già, la lunghezza: muoversi a piedi per 24 giorni consecutivi, con una media di 16 ore di attività e poco tempo per dormire e ancora meno occasioni per farlo in un letto, è stato l’aspetto più duro del Great Himalaya Trail di Ryan. «Il ritmo era lento, più lento di quanto sono abituato, e anche questa è stata una sfida: ci sono stati giorni nei quali abbiamo camminato per 20 ore e altri per 12, notti passate nelle case dei nepalesi in villaggi isolati dal mondo e momenti nei quali ci fermavamo giusto una ventina di minuti ogni tanto per dormire sul sentiero o su qualche tavola di legno usata dai pastori, piuttosto che nei loro ripari di fortuna». Impossibile pensare di dormire all’addiaccio nella prima parte del percorso, in quota e in parte ancora innevata, più pratico farlo verso la fine, negli ultimi 300 chilometri, quando Ryan e Rino hanno camminato e corso nella giungla, con temperature che superavano i 30 gradi. Per trovare la motivazione in quei 25 lunghi giorni Ryan si è inventato degli obiettivi giornalieri, ragionando step by step, ma non è sempre stato facile.

L’altro aspetto che ha reso difficile il Great Himalaya Trail, soprattutto nella prima parte, è stato l’orientamento. Faceva freddo e il percorso era ancora in parte ricoperto dalla neve. «Ci siamo affidati al GPS, ma di tanto in tanto dovevamo fermarci dieci minuti per ritrovare la traccia; abbiamo calcolato che ogni giorni, in media, perdevamo fino a tre ore per orientarci e in una di queste pause Ryno si è procurato il congelamento di alcune dita della mano perché siamo saliti fino a 5.500 metri di quota con temperature di - 15 gradi e il vento che accentuava la sensazione di freddo».
Quella del cibo è stata la sfida nella sfida. Per scelta e per alleggerire gli zaini è stato deciso di fare tutto il Great Himalaya Trail procurandosi da mangiare lungo il percorso, come dei normali turisti: acquistandolo o facendosi ospitare dai locali. Solo in tre punti c’è stata la possibilità di cambiare gli zaini e i vestiti e nelle tasche trovava spazio qualche barretta, gel o lattina di Red Bull. «Alla fine il mio corpo mi diceva che non ne poteva più di quell’alimentazione e sono stato male un paio di giorni: i nostri pasti consistevano di frittata, riso e lenticchie quando avevamo la fortuna di essere ospiti, oppure di biscotti e cioccolato comprati alle bancarelle e non era proprio l’ideale durante una traversata di 1.500 chilometri».
La mattina del 19 marzo, a 40 chilometri da Patan, Griesel ha iniziato a soffrire di spasmi muscolari nella zona del torace ed è andato in iperventilazione. «Ho veramente temuto che da un momento all’altro cadesse a terra sul sentiero: aveva i battiti del cuore molto alti e la febbre» ricorda Ryan. Mai come in questo momento la fine dell’avventura è stata vicina. «Da una parte non avrei mai voluto che Ryno avesse dei problemi seri di salute, dall’altra so quanto ci teneva a portare a termine il Great Himalaya Trail e che il ritiro sarebbe stata la più brutta notizia per lui, è stato il momento più difficile per tutti». Ci sono mali fisici e mentali e i fantasmi hanno iniziato a popolare il cervello di Ryan. «Ho iniziato a pensare a mio figlio di 19 mesi e a come fosse cresciuto durante questi 24 lunghissimi giorni: quanto mi fossi perso!». Per non farsi mancare nulla, negli ultimi giorni Ryan si è anche imbattuto in una gang locale che, nella notte, li ha inseguiti tra le montagne, anche con le luci delle frontali spente, fino a quando i due non sono arrivati a una locale stazione della polizia. Questo ultimo contrattempo non ha impedito l’arrivo a Pashupatinagar, sul confine con l’India, alle prime luci dell’alba del 25 marzo.
Tre mesi dopo la grande avventura rimangono un centinaio di chilometri in più non preventivati, il messaggio di congratulazioni di Lizzy Hawker, tante energie, la velocità delle gambe ancora da recuperare. E la consapevolezza di avere vissuto 24 giorni che hanno cambiato le vite di Ryan e Ryno.

Il Great Himalaya Trail
Il Great Himalaya Trail (GHT) non è un vero e proprio sentiero ma una combinazione di itinerari. Quello seguito da Ryan Sandes e Ryno Griesel ha comportato la partenza da Hilsa, al confine con il Tibet, e l’arrivo a Pashupatingar, dove il Nepal confina con l’India, lungo la direttrice da Ovest a Est. Le stime prevedevano 1.400 chilometri e 70.000 metri di dislivello, ma alla fine la lunghezza totale è stata superiore di poco più di 100 chilometri. Questo percorso è quello seguito dal sudafricano Andrew Porter nell’ottobre 2006 e portato a termine in 28 giorni, 13 ore e 56 minuti. Ryan e Ryno si sono consultati a lungo con Andrew e sono passati da 12 precisi checkpoint che coincidevano con quelli di Porter. Cinque semplici regole hanno dato un senso all’impresa: autonomia nell’orientamento e nell’alimentazione, acquistando il cibo lungo il percorso o facendosi ospitare dai locali, nessun uso di sherpa e muli, pernottamenti all’aperto o nei lodge e nelle case per non appesantire lo zaino, utilizzo di una compagnia di trekking locale per cambiare gli zaini in tre occasioni e l’assistenza per i permessi. Il sito di riferimento per il Great Himalaya Trail, con tutte le informazioni utili per chi volesse percorrere anche solo una parte del GHT, è www.greathimalayatrail.com
I 12 checkpoint
- Hilsa
- Simikot - km 77
- Gamgadhi - km 150
- Jumla - km 193
- Juphal - km 280 o Dunai - km 290
- Chharka Bhot - km 380
- Kagbeni - km 444
- Thorang La Pass - km 463
- Larkya La Pass - km 561
- Jiri - km 928
- Tumlingtar - km 1.075
- Pashupatinagar - km 1.504
Gli altri record
- Sean Burch (UK): 2010 - 49 giorni, 6 ore, 8 minuti (2.000 km - da Est a Ovest, combinazione dell’High e del Cultural GHT).
- Lizzy Hawker (UK): 2016 - 42 giorni, 2017 - 35 giorni (circa 1.600 km - da Est a Ovest - prevalentemente sulla High GHT Route, evitando i tratti tecnici che richiedono passi di arrampicata).
I NUMERI
- 70 km la lunghezza minima delle tappe giornaliere
- 120 km la lunghezza massima percorsa al giorno
- 500 m il dislivello minimo giornaliero
- 000 m il dislivello massimo giornaliero
- 124 palle di riso mangiate
- 43 palle al curry
- 300 barrette di cioccolato
- 600 cookie
- 46 donuts
- 2 pizze
- 24 lattine di Red Bull
- 3 ore di sonno a notte in media
- 2 le volte che Ryan e Ryno hanno potuto lavarsi i denti
- 0 le docce fatte lungo il percorso
- 24 giorni, 4 ore, 24 minuti il tempo fatto registrare da Ryan Sandes e Ryno Griesel
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 119, INFO QUI

Fast is the new trendy
Visto che la nostra diretta quotidiana su Instagram sarà con Denis Trento, abbiamo pensato di riproporvi l'articolo pubblicato su Skialper 124 sulle sue imprese in velocità nel massiccio del Monte Bianco in compagnia di Robert Antonioli. Così arrivate preparati ;)
Per tutti coloro che hanno vissuto negli anni avanti Kilian, partire dal fondovalle per scalare una montagna suonerà più blasfemo ancora dell’additare il catalano come una sorta di profeta. Anche io, pur essendo da sempre nel mondo delle gare, in passato poche volte avevo osato provare un simile approccio, se non per salire su vie facili, con la sola ottica di fare un lungo. Con Manfred Reichegger, nei nostri anni da atleti, partendo dal punto più alto raggiungibile con mezzi a motore avevamo salito le normali di Bianco e Jorasses. Una decina di anni fa, quando, sempre insieme, abbiamo scalato l’Innominata al Bianco, solo il fatto di aver snobbato i bivacchi Eccles in favore di una buona cena al Monzino, per l’epoca era sembrata una mezza impresa. Oggi tutto è diverso. Sono cambiati i materiali, i metodi di allenamento, ma soprattutto a essere cambiata radicalmente è la mentalità. Il successo commerciale delle gare di trail ha sdoganato l’idea che, per chiunque, sia possibile percorrere distanze lunghissime, senza per forza doversi fermare a fare tappa nei rifugi.

I tempi sono maturati velocemente, mancava però ancora un illuminato che avesse la visione per portare tutto questo dai sentieri alle alte quote, passando però per vie con difficoltà non banali, e a questo ha provveduto Kilian Jornet. Storicamente, non si può dire che a livello alpinistico mancassero gli esempi di salite in velocità: negli anni ’80/’90 tutti i big dell’epoca si sono cimentati in salite lampo e concatenamenti, mettendo al centro del tutto la ricerca della difficoltà, meglio ancora se in quantità sproporzionate. In questi concatenamenti la performance alpinistica andò a comprimere un po’ gli spazi di stile ed etica, ammettendo qualsiasi mezzo per spostarsi da una nord all’altra. Dall’elicottero al deltaplano, l’importante era riuscire ad andare il più velocemente possibile a mettere il sedere nei calci. L’eredità di Profit, Boivin e soci è stata raccolta a distanza di molti anni da Ueli Steck. Purtroppo il suo ricordo rimarrà indissolubilmente legato a un cronometro, mentre il suo stile era invece connotato da un’etica molto severa e da una prospettiva in cui lo sviluppo della velocità era il fattore determinante per fare il passo successivo sulle montagne più alte del mondo. Pur avendo incentrato l’attività sul salire in velocità vie molto tecniche, nel suo ultimo periodo neppure un alpinista con la A maiuscola come Ueli ha potuto rimanere insensibile al nuovo stile che si stava affermando. D’altronde, esiste forse uno stile più logico ed elegante del partire dal fondovalle, scalare una o più montagne e tornare al punto di partenza con il minimo materiale indispensabile, in un solo, rapido, assalto? In questo stile la velocità rappresenta ovviamente una componente essenziale: senza di essa non sarebbe possibile fare così tanto dislivello. Senza di essa non si avrebbe la sensazione di cavalcare le montagne.

Pur condividendo la ricerca della rapidità, gli approcci a questo tipo di salite sono molto differenti a seconda che si parta dal lato trail running oppure da quello alpinistico. A creare confusione, al di là delle basi culturali, è proprio la disciplina in sé: per la metà del tempo si corre su sentieri, per l’altra metà si scalano vie alpine. Nella prima parte della giornata si starebbe quindi bene in scarpette, pantaloncini e canotta; nella seconda ramponi, piccozze e friend diventano fondamentali per la riuscita. Quanti e quali materiali portare è ovviamente la questione cruciale. In questo caso non esiste una lista ideale, come ama imporre il sindaco di St. Gervais per la salita al Bianco. Il discorso è però molto semplice e, sia in alpinismo che nelle gare di corsa, ha radici antiche: la velocità è inversamente proporzionale al peso. Detto ciò, bisogna essere ben consapevoli che dovrò essere capace di compensare con le mie capacità la mancanza di ogni attrezzo della cui compagnia deciderò di fare felicemente a meno nelle ore di avvicinamento e di ritorno a valle. Come Guida alpina non posso prescindere dall’avere con me attrezzatura alpinistica adeguata e di autosoccorso, con qualche piccolo adeguamento magari sul materiale delle talloniere dei ramponi o sui millimetri della corda. Ma soprattutto, nonostante si vada di fretta, non posso tralasciare le procedure corrette di utilizzo dello stesso quando sono legato con qualcuno (nella fattispecie Robert Antonioli). Con procedure corrette intendo anche lo scegliere di percorrere senza la corda i tratti in cui non ci si può proteggere correttamente. A volte la corda, piuttosto che essere un fattore di sicurezza, comporta soltanto un duplicarsi delle conseguenze in caso di incidente. È quindi ovvio che la ricerca del record o della performance pura passi per lo scalare in solitaria, ma questo è un discorso con implicazioni troppo personali e che comporta un’accettazione del rischio troppo grande per poter essere trattato in poche righe. A ogni modo, anche se il cronometro per uno sportivo è il termine di paragone per eccellenza, fortunatamente nell’alpinismo è solo uno degli elementi per valutare un’ascensione e vale molto meno dell’estetica della via, dello stile con cui viene affrontata e delle difficoltà affrontate. Purtroppo però il tempo rimane l’unico fattore obiettivamente misurabile grazie a cronometri e gps. Va da sé che quindi entri in gioco un po’ di sana competizione ma, visto il numero crescente di praticanti, mi auguro di non arrivare a vedere anche segmenti dell’Innominata su Strava!
3 GIRI IN MONTAGNA IN VELOCITÀ
Nella stagione estiva 2018 Denis Trento e Robert Antonioli hanno concluso ognuno dei tre raduni della squadra di scialpinismo del Centro Sportivo Esercito con un’uscita in quota con difficoltà alpinistiche affrontata in velocità. La prima tappa è stata la salita al Monte Bianco per la cresta dell’Innominata il 28 giugno con partenza e arrivo dal campeggio La Sorgente in Val Veny e rientro dal rifugio Gonella e dal Miage. Secondo step il 4 agosto concatenando la Courmayeur Mont Blanc Skyrace, chiusa al sesto e ottavo posto da Trento e Antonioli, con la cresta di Rochefort e la traversata delle Grandes Jorasses. La discesa è avvenuta dal Boccalatte e poi fino a Planpincieux. Terza e ultima tappa sul Monte Rosa il 25 agosto: partenza da Staffal, nella valle del Lys e giro che ha toccato Lyskamm, colle del Lys, punta Dufour e punta Zumstein. Ogni giro è stato affrontato in modalità fast & light ma con tutta l’attrezzatura alpinistica e di autosoccorso necessaria, seppur nella versione più leggera possibile.
1 — 3.442 M D+ / 3.442 M D- / 35 KM
Camping La Sorgente Monte Bianco (6h10’)
Rifugio Monzino (1h15’) Rifugio Gonella (7h40’)
Bivacchi Eccles (3h10’) Lago Combal (9h25’)
Col Eccles (3h40’) Camping La Sorgente (9h57’).
2 — 3.772 M D+ / 3.200 M D- / 24,5 KM
Courmayeur Punta Helbronner (1h52’ Denis Trento, 1h53’ Robert Antonioli) / 25’ cambio di assetto
Gengiva (3h13’) Aiguille du Rochefort (3h40’) Canzio (5h08’) / 10’ pausa punta Walker (8h40’) Boccalatte (10h40’) / 10’ pausa Planpincieux (11h30’)
3 — 3.831 M D+ / 3.831 M D- / 35 KM
Staffal Rifugio Sella (2h13’) / 20’ circa di pausa Lyskamm Occidentale (4h10’)
Lyskamm Orientale (4h43’) Colle del Lys (5h15’) Punta Dufour (7h37’) Punta Zumstein (8h31’) Rifugio Mantova (9h42’) / 10’ pausa Staffal (11h39’)

QUATTRO CHILI IN MENO
Robert e io abbiamo approcciato questo tipo di salite in modo abbastanza dilettantesco, anche perché la nostra prima salita non era preventivata e l’unica cosa che ci interessava era passare una bella giornata in montagna. In occasione dell’Innominata infatti Robert aveva a disposizione soltanto materiale vetusto e pesante, ma nemmeno io ero veramente al top della leggerezza. Il che ha comportato diversi chili di peso supplementare. Nonostante ciò, quella rimane forse la nostra performance migliore. Nelle salite successive abbiamo prontamente corretto il tiro, riuscendo a selezionare con più precisione il materiale strettamente necessario. Eppure, sommando al materiale alpinistico il vestiario, l’acqua e il cibo, non siamo mai riusciti a partire con meno di otto chili sulle spalle. Per andare sotto quel peso, bisognava scendere a compromessi sulla sicurezza che non eravamo pronti ad accettare. In definitiva, per essere veramente leggeri in montagna bisogna andare da soli e senza corda. Meglio ancora se nudi e scalzi! Tabella comparativa tra materiale convenzionale (vale a dire quello che Denis avrebbe utilizzato lavorando come Guida alpina) e quello più leggero che è stato realmente utilizzato. Bisogna ricordare che adottando uno stile convenzionale, per queste salite al 90% bisogna aggiungere il materiale da bivacco: intimo di ricambio, fornellino, pentolino, posata, cibo liofilizzato. Il che aggiunge almeno un altro chilo al peso della zaino.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 124