Lettera dalla Nuova Zelanda
«Con 12 ski field, la regione di Canterbury ha più posti per sciare di tutte le altre. Molti di questi ski field sono in realtà dei club field gestiti in maniera comunitaria e no profit, il che significa che sono delle specie di comunità sciistiche socialiste. Nei club field non troverete molte piste battute, né seggiovie, qui gli impianti di risalita sono manovie in stile anni '40, un modo semplice, terrificante ed efficace per salire in montagna. L’assenza di discoteche nel raggio di 100 chilometri fa sì che la scelta migliore per l'après-ski sia quella di pernottare in uno dei lodge dei club field e bere quello che vi siete portati, oppure andare in un pub di campagna ad ascoltare le storie di caccia di contadini dall'aspetto rude o a guardare una partita di rugby (in Nuova Zelanda una vera e propria religione) in TV».

A scrivere la lettera dalla Nuova Zelanda su Skialper 132 di ottobre-novembre è Joe Harrison, che racconta questa simpatica formula di ski resort e tutte le sue implicazioni, ma anche delle possibilità di scialpinismo in rifugi sperduti nella natura selvaggia e anche dell’imprevedibilità del meteo a quelle latitudini: «Gli inverni kiwi possono essere più imprevedibili dei tweet di Donald Trump. Alcune bufere fanno diventare bianca l'intera Isola del Sud, ma altri inverni vi vedranno sciare un sacco sul tussock (erba di montagna). La cosa buona è che se la brutta neve vi butta giù, potrete sempre abbandonare gli sci e dirigervi verso uno dei tanti surf break lungo la East Coast: l'acqua sarà gelida ma non c’è niente che una calda muta, una hot steak pie (piatto nazionale) e un flat white coffe (il cappuccino local) non possano risolvere».


Alta Valtellina: scoprire, riscoprire, condividere
«Quando Edoardo e io abbiamo deciso di passare l’inverno insieme a sciare il più possibile non avevamo idea di dove andare; abbiamo scritto su un foglio di carta il nome di cinque località che, almeno a una prima apparenza, avevano le caratteristiche che secondo noi dovesse avere il posto in cui volevamo trascorrere la stagione. Per prima cosa, volevamo trovarci in un posto dove almeno la quota promettesse neve al momento dell’arrivo di ogni precipitazione. Poi ci interessava stare lontani dal turismo di massa e pagare un affitto ragionevole. Cercavamo un inverno più lungo possibile in cui sciare fino a non poterne più sopportare nemmeno l’idea. Non so perché - forse perché avevamo usato l’ordine alfabetico - ma Santa Caterina era l’ultima della lista. Abbiamo trovato casa quando ormai avevamo perso ogni speranza e, per quanto fosse difficile accorgersene nel caldo di Roma, l’inverno stava già bussando alla porta. Indossavamo ancora i pantaloncini quando abbiamo caricato la macchina di borsoni e speranze e ci siamo messi in viaggio verso nord. Verso l’inverno. Non avevamo la minima idea di quello verso cui stavamo andando incontro a testa bassa, e senza guardarci indietro».
Eva Toschi da tre inverni è ormai una local di Santa Caterina Valfurva. Ha esplorato con sci e pelli ogni versante della valle e nei mesi più freddi ama la zona dei Forni. Perché, con quattro chilometri di strada da fare con le pelli (o con gli sci in spalla) la folla primaverile si dilegua e diventa il regno del silenzio. Perché in Alta Valtellina, non solo in Valfurva, appena oltre gli itinerari più frequentati, c’è un paradiso per pochi.

«L’Alta Valtellina è una zona così ampia e con numerose valli limitrofe che è ancora difficile trovare la ressa sugli itinerari. Tolti quei quattro-cinque classici o altre zone più famose come i Forni o la Val Viola, quando aprono le relative strade, se esci a fare un giro è difficile che trovi tanta gente. Chi non ha le competenze si muove solo sugli itinerari conosciuti e già battuti; chi invece ha un po’ di esperienza e ama muoversi non lo vedi in giro perché va a cercare posti poco conosciuti. Poi va messo in conto che tante valli sono difficili da raggiungere, ma le prospettive sono cambiate grazie all’uso della bici a pedalata assistita con cui si può andare fino a dove in primavera puliscono la strada, metter le pelli e partire. Questo tipo di scialpinismo è ancora di nicchia, ma si sta espandendo. In un raggio di 20 chilometri ci sono montagne, fauna e flora così diversi ed è difficile trovare tanta varietà in un’area relativamente piccola altrove sulle Alpi».

A parlare è Giuliano Bordoni, Guida alpina, local per nascita. Giuliano, dopo avere provato freeride e freetouring, ora si lascia ispirare da quello che lui chiama ski savage, uno ski sauvage, vale a dire alpinismo con gli sci su terreno d’avventura. «Ogni tanto ti capita di ravanare, altre meno e qui sta il bello: sapersi sempre stupire di fronte al risultato finale». Sapersi stupire anche di fronte al risultato finale delle 10 gite suggerite da Giacomo Meneghello, il fotografo autore della maggior parte delle foto del dossier di 18 pagine che dedichiamo all’Alta Valtellina su Skialper 132 di ottobre-novembre. Anche lui, come Eva, è un local acquisito, ma ha imparato velocemente ad amare queste montagne.
Giù al Nord
Può l’Appennino, almeno per un giorno, sembrare il grande nord? Può un fitto bosco di faggi assomigliare a una foresta di aspen del Nord America? Nel giorno giusto tutto è possibile e anche il vento che spira incessante si ferma. «Una piacevole brezza ci accarezza la pelle, una delle tante stranezze di inverni sempre più atipici in Appennino. L’Appennino centrale è caratterizzato da condizioni meteo variabili, ma il climate change ha reso tutto ciò ancora più imprevedibile» scrive Lorenzo Alesi su Skialper 132 di ottobre-novembre.
Tornare sulla catena dei Monti della Laga, Colle del Vento e Monte di Mezzo è un po’ come andare oltre la distruzione del sisma del 2016. Attraversare Amatrice, con il campanile della sua chiesa, unica struttura rimasta in piedi, e gli altri paesi quasi del tutto rasi al suolo per raggiungere Campotosto, da dove iniziano le salite, è come allontanare il passato e riconnettersi al futuro che verrà. Fuori dal bosco si continua a fare traccia risalendo pendii ondulati e dolci su una neve ancora fredda, condizioni insolite per questo posto, dove solitamente le creste sono battute dal vento e la neve è icy e insidiosa. Ma la gioia e le emozioni della discesa giusta sono effimere, e quando meno te l’aspetti, dove meno te l’aspetti puoi vivere una delle più belle giornate sulla neve. «Ogni volta che torno in Appennino vengo su queste montagne, ma condizioni di neve così non le avevo mai trovate» scrive Lorenzo. È tempo di andare: la discesa nella powder, nel canale Sud-Est con vista Gran Sasso e sui pendii dolci e poi nella larga faggeta fino ad arrivare al lago dà un gran gusto. E a testimonianza ci sono le immagini di Alice Linari, che raccontano più di mille parole.

Lettera da Sauris
«Sono arrivata quassù forse per destino. Avevo un paio di ore di buco per un’intervista saltata durante una trasferta a Sauris e la voglia di scoprire quella frazione che non avevo mai visto. Era un’occasione da sfruttare anche perché nella valle del Lumiei, dove la Carnia si spinge verso il Cadore, bisogna venirci apposta. Era inizio marzo, c’erano il sole e la neve. Sono salita a Lateis senza davvero sapere cosa aspettarmi. Ho trovato un silenzio tangibile, una cinquantina di case con in mezzo una chiesetta e, intorno, una natura potente. I prati, chiusi da boschi di faggio e di abeti, e poi le montagne, più rocciose e potenti a Sud, più morbide verso Nord. Arrivata in cima, alla borgata Ameikelan, ho notato uno stavolo, una vecchia stalla con il suo fienile, in posizione strategica: non solo davanti al Tinisa, la montagna che protegge Lateis, ma affacciato sul Bivera. Il Bivera si distingue dalle altre Alpi Carniche per la forma svettante, per il tratto di cengia orientale rossa di ammoniti. In sintesi, per la sua bellezza. Da quello stavolo, la vista sul Bivera era indubbiamente perfetta. Sono passati quattro anni e il Bivera ora lo ammiro praticamente da ogni finestra di casa, dallo stavolo scoperto in quella luminosa giornata di marzo».

A Sauris il distanziamento è da sempre uno dei leit-motiv, lo sa bene Anna Pugliese, che ha scritto per Skialper una delle lettere da che pubblichiamo da Skialper 132 di ottobre-novembre . Di sciate, qui, se ne fanno parecchie. Anche perché si parte dai paesi già a una buona quota: 1.240 metri per Lateis, 1.212 per Sauris di Sotto, 1.398 per Sauris di Sopra. Il distanziamento fisico è garantito: gli abitanti sono meno di 400, c’è turismo, sì, ma non è certo opprimente. Puoi salire e scendere senza incontrare nessuno. «Il problema, spesso, è che ti tocca batter traccia». Quello che fanno Francesca Domini e Marco Stefanuto, che gestiscono un’azienda agricola che crea formaggi di capra e si sono sposati nel maggio del 2011 quasi in sella al Bivera, dove erano saliti con don Piller, il parroco sciatore di Sauris, e il suo cane, Fox. Anche loro sono alcuni dei (pochi) fortunati local. Ne parliamo su Skialper 132 di ottobre-novembre.

Lettera dal Gennargentu
«Mentre sulle Alpi si cerca di combinare una salita nei giorni seguenti la nevicata, a queste latitudini, forse per paura che la neve si sciolga prima di averla toccata, si parte durante la nevicata stessa. Questo costringe già a tragicomici avvicinamenti in auto, su strade ovviamente non spazzate (in Sardegna si mormora di un fantomatico maialetto delle nevi che ripulisce le strade dopo la nevicata, ma noi non lo abbiamo mai visto!)».

Si può fare scialpinismo sul Gennargentu? Sì, almeno ci si può provare. Ed è un’esperienza che ha a che fare con lo scialpinismo di scoperta e molto con il ravanage. Ne sa qualcosa Maurizio Oviglia, che ha scritto per Skialper 132 di ottobre-novembre una lettera dal Gennargentu, ricordando le tante avventure tra filo spinato, fango e neve che sparisce a vista d’occhio. Oviglia parla del versante settentrionale del Bruncu Spina. «Ricordo una salita al Bruncu Spina da Nord dove, prima di raggiungere un pendio degno di questo nome, dovetti combattere per un’ora su un sentiero a ostacoli costituiti da filo spinato e muretti a secco. Alla base del pendio mi misi la cuffia, attaccai l’ipod con un pezzo di potente jazz rock, e mi sparai i 500 metri per cui ero venuto, tutti d’un fiato. Mi ero finalmente sfogato, ma sulla discesa meglio calare un pietoso velo». Poi sono arrivati i tentativi da Desulo e da Correboi. «Ci saranno stati 5 centimetri di neve e avevo oltrepassato 45 muretti di pietre con filo spinato; non ci crederete ma li avevo contati. In discesa mi si ruppe il vecchio scarpone come fosse un uovo di cioccolato (del resto l’attrezzatura buona l’avevo lasciata a Torino) e cercai di scendere alla meglio nella macchia mediterranea, mirando alla macchina. A un certo punto un cinghiale mi si parò davanti agli sci. Rimasi un attimo interdetto, ero sempre armato di bastoncini, avrei reso cara la pelle. Per fortuna con uno scatto si infilò nel bosco: provai a inseguirlo, a quel punto speravo in un ingresso in paese da eroe. Ma sapeva sciare meglio di me e lo persi…». Ora Maurizio ha smesso di partire con gli sci e le pelli alla scoperta del Gennargentu, ma in fondo quel sue peregrinare tra cinghiali, filo spinato e Mufloni usando gli sci come mezzo di trasporto è uno degli ingredienti che rendono lo skialp così bello, anche quando la neve non è proprio come nelle foto di copertina di Skialper.

Waffle, powder e wilderness
«È come muoversi in una tazza di latte. Il vento soffia, nevica di traverso e ho freddo. Non vedo molto, le croci rosse che segnano il percorso sono l'unico indizio che mi indica dove andare e a volte scompaiono del tutto nella desolazione bianca e infinita. Forse non è stata una buona idea fare un giro con gli sci oggi, ma dopo il lungo viaggio fino a Björkliden, nella Lapponia svedese, 195 chilometri a Nord del Circolo Polare Artico, volevamo sgranchirci le gambe e prendere un po' d'aria fresca».
A scrivere è Mattias Fredriksson, autore anche delle stupende fotografie. Nell’articolo Waffle, powder e wilderness, su Skialper 132 di ottobre-novembre, parliamo del Låktatjåkka Mountain Lodge, una casa di legno nero circondata da enormi muraglie di neve a 1.228 metri sul livello del mare. È il rifugio più alto della Svezia e, per la cronaca, bisogna sapere che la montagna più alta del Paese, il Kebnekaise, è di soli 2.097 metri. Il Låktatjåkka è una base perfetta per spettacolari escursioni in uno degli ultimi angoli selvaggi d’Europa. Oltre che una baita gourmet dove provare dei deliziosi waffle. Dormire al rifugio comporta un’esperienza un po’ diversa per lo scialpinista, perché si è a poche centinaia di metri di dislivello dalle vette, così la maggior parte del dislivello bisogna farla il pomeriggio per rientrare alla base.
«Stare al rifugio trasmette un senso di intimità. Gli ospiti e il personale la sera si incontrano nel soggiorno e nel bar per leggere e parlare. Si arriva a conoscersi tutti, soprattutto perché non c'è internet e gli smartphone non hanno praticamente campo. Invece ci sono un sacco di buoni libri e una selezione sorprendentemente di birra, vino e whisky di qualità. La cucina è di livello e si possono provare i piatti svedesi, a partire dalla carne di renna e alce». Appuntamento in edicola con Skialper di ottobre-novembre.

Dentro il van
«Un van è come un figlio. Quando lo scegli, lo vivi fino in fondo. Non è il tuo mezzo di trasporto, non è il tuo status symbol. Non è solo il viaggio alternativo. È ciò che ti rappresenta. E contiene te stesso».
Scrive così Veronica Balocco nell’articolo Dentro il Van, su Skialper 132 di ottobre-novembre. Veronica è un vanlifer da sempre e ha cambiato diversi mezzi. Chi meglio di lei per raccontare la vita in van e in camper d’inverno? Oltre gli stereotipi e la moda social, non c’è dubbio che il camper è il mezzo dell’anno, perché in sintonia con il momento che stiamo vivendo. Sono in molti quelli che affrontano la montagna in inverno dormendo su quattro ruote. E molti quelli che vorrebbero farlo… «Viaggiare, e passare del tempo, su un van d’inverno richiede una certa attitudine allo sgamo». Dalla scelta del carburante, che spesso alimenta anche il sistema di riscaldamento, agli pneumatici e alle batterie di servizio.

«Oltre a questo mare magnum di insegnamenti in continua evoluzione, il van mi ha regalato anche qualcosa di diverso. Ed è forse la cosa più importante. Obbligandomi a guardare la vita da uno spazio minimale poggiato su quattro ruote, mi ha costretta a rivedere gesti normali. E a dare una nuova visione a tutto quello che sembra banale» scrive ancora Veronica. Per esempio parcheggiare evitando che lo spazzaneve depositi muri di cemento sulle ruote, farsi la doccia centellinando l’acqua e cercando di non bagnare troppo attorno, asciugarsi i capelli tenendo conto del voltaggio… Insomma la vita in camper va oltre le foto di mezzi da sogno e l’appeal glamour degli oltre otto milioni di hashtag #vanlife. Veronica racconta le sue esperienze, dispensa consigli, affronta la scelta del mezzo, le disposizioni per il parcheggio nelle località sciistiche e nella natura. Insomma 14 pagine di vademecum con la leggerezza di un racconto e le belle fotografie di Federico Ravassard che ha immortalato outdoor addicted del calibro di Cala Cimenti, Enrico Mosetti e Paolo Marazzi con i loro mezzi. Skialper 132 è acquistabile anche nella nostra edicola digitale.


Chiude Powder Magazine
Anche per uscire di scena hanno scelto lo stile leggero e inconfondibile che ha attraversato come un filo rosso tutti i 49 anni della loro storia, con la foto in bianco e nero di una ragazza che sorride e guarda la neve che cade dal cielo. Un po' come Radiofreccia che chiude un minuto prima di compiere 18 anni. La notizia, prima diffusa dal passaparola di Instagram e anticipata in un interessante articolo di Steve Casimiro, a lungo anima della rivista e ora editore di Adventure Journal, è ufficiale: Powder Magazine cesserà le pubblicazioni (e di conseguenza anche l’aggiornamento del sito internet e dei canali social) a partire dal prossimo 20 novembre. La comunicazione è arrivata venerdì scorso con una email ai dipendenti da A360 Media LLC, il gruppo editoriale (editore anche di tabloid e testate generaliste ad alta tiratura) di cui fanno parte Bike, Surfer e Snowboarder, altre testate che verranno chiuse.
«Non sappiamo se e quando questo iato finirà - scrivono sul sito della rivista statunitense - Sappiamo, però, che abbiamo ancora da lavorare e due numeri della rivista da fare». Il 16 novembre uscirà l’ultimo Photo Annual, il marchio di fabbrica di Powder, dal quale sono passati tutti i grandi nomi della fotografia di sci fuoripista e che ha creato mode e stili.
Powder ha attraversato epoche, mode, crisi, mantenendo sempre uno stile originale e producendo contenuti di qualità, nonostante il passaggio di diverse proprietà. «Sì, abbiamo giocato molto. Ma abbiamo anche lavorato molto, e credo di poter parlare a nome di tanti di noi quando dico che quelle serate passate a lavorare fino a tardi sono state magiche. Stressanti, sì, ma allo stesso tempo eravamo nella nostra piccola bolla, una manciata di persone unite nel tentativo di creare qualcosa di speciale e a suo modo importante» ha scritto Steve Casimiro. La parabola della rivista si è incrociata più volte con quella delle grandi case editrici nordamericane con numeri, obiettivi e costi sempre più inconciliabili con il mondo della neve e degli sport outdoor dove sopravvivono - negli States come in Europa - gli editori indipendenti. La crisi portata dalla pandemia ha fatto da detonatore. Proprio negli stessi giorni sul sito di Backcountry Magazine, altra rivista di riferimento nordamericana e principale competitor di Powder, è bene in evidenza un editoriale nel quale la redazione al completo sottolinea come la buyer’s guide uscirà con i consueti standard di qualità ma 16 pagine in meno, tutte di pubblicità, e chiede di sostenere i piccoli editori indipendenti. Il direttore editoriale della casa editrice di Backcountry, Tyler Cohen, ha scritto un interessante articolo sulla chiusura di Powder. «Il monitoraggio regolare di Powder ha portato in parte al nuovo logo e allo stile di copertina di Backcountry, ridisegnato l'anno scorso; ci ha spinto a includere più storie in ogni numero; (...) Powder ha contribuito a plasmare Backcountry, ben oltre la direzione di Adam Howard, CEO di Height of Land (editore di Backcountry, ndr), con la consulenza di Steve Casimiro». «Per 43 anni, Powder ha fatto tutte queste cose e le ha fatte molto, molto bene. Ora il mondo dello sci sarà più povero» conclude Cohen.
«Non sappiamo cosa ne sarà di Powder, solo che la sua assenza per un certo periodo di tempo sarà pesante per chi di noi è rimasto affascinato dalle sue parole e dalle sue immagini lungo il viaggio di 49 anni - scrive Sierra Sfaher, editor in chief della rivista - Ci auguriamo che vi abbia offerto una casa; un luogo dove gli sciatori possano venire per l'umorismo, la riflessione, l'ispirazione, l'onestà, e un piccolo assaggio della gioia che sappiamo si può trovare solo, come hanno scritto i redattori che fondarono la rivista, nell'allontanarsi dalla folla verso un luogo dove non ci sono linee, non ci sono impianti, non ci sono recinti e altri sciatori. Solo neve».
Auguriamo alla redazione di Powder di riuscire a trovare una forma per riaffermare il suo spirito libero, perché, come hanno scritto Dave Moe, Jake Moe e Bruce Bailey sul primo editoriale della rivista, per noi powder significa libertà, con un'enfasi non su come esserlo, ma solo su come esserlo sempre di più.
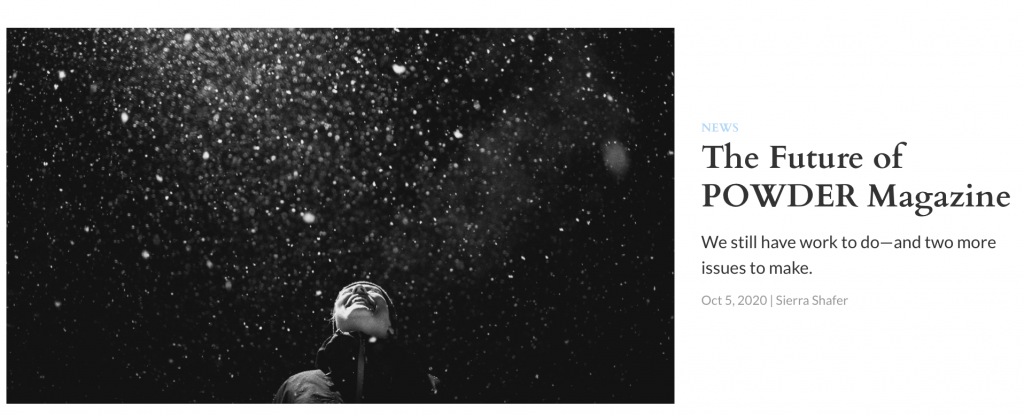
Al via la nona edizione del Blogger Contest di Altitudini
«Il metodo è la cronaca, il fine è la letteratura: la cronaca viene utilizzata per i fini letterari e per offrire ai lettori un contesto reale, multiforme e dalle molteplici declinazioni e manifestazioni». È questa la base dell’edizione numero nove del blogger contest di Altitudini, il principale incubatore di talenti letterari legati alla montagna. Un’edizione che stravolge i canoni adottati fino a oggi perché dopo contest nei quali «vi abbiamo chiesto di partecipare con un racconto di finzione − i fatti descritti potevano anche non essere realmente accaduti − in questa edizione vogliamo confrontarci con un genere, il reportage narrativo, in cui l’autore ha fatto esperienza diretta dei fatti e li descrive attraverso gli strumenti narrativi».
Un reportage come piace a noi di Skialper, con tre comandamenti: camminare, osservare, raccontare. Perché camminando si ha una visione delle realtà completamente diversa. «Potete raccontare qualsiasi cosa abbiate visto e di cui siete stati testimoni, oppure che vi è stata raccontata perché eravate a caccia di quella storia. Storie di quotidianità che ci portano dentro la vita delle persone, che contengono un potere speciale perché sappiamo essere reali. Una sola regola, le storie del vostro reportage narrativo devono incontrare le montagne» dicono gli organizzatori.
Il contest è diviso in tre categorie: racconto breve, audio storie e web comics. Skialper, insieme a Suunto, premierà il primo classificato nel racconto breve con 500 euro e la pubblicazione del racconto sulla rivista nel corso del 2021. Simona Righetti, che dirige la nostra casa editrice con il compagno Davide Marta, fa parte della giuria insieme a Luisa Mandrino, Matteo Melchiorre, Ornella Bellucci, Gianluca Costantini e Alice Martinelli. Si può partecipare al blogger contest fino al 31 dicembre e il regolamento è qui.
Il blogger contest ha anche fatto da incubatore per il nuovo progetto editoriale della nostra casa editrice, AA Arcipelago Altitudini / Storie di Montagna. Ha le fattezze di un libro, ma nell’idea di periodicità è inteso come una rivista, contenuti curati con i tempi di un libro e impaginati con gli elementi di grafica, le illustrazioni e le immagini fotografiche di una rivista. AA è un contenitore di racconti, ma anche di saggi narrativi, di poesie, di foto reportage e di graphic novel con tema la montagna nei suoi diversi aspetti e significati. Un insieme di tante storie eterogenee e voci diverse, in cui scrittori affermati si affiancano a esordienti, componendo un vero e proprio affresco, un racconto sfaccettato e originale sulla montagna, per scoprirla, approfondirla e per lasciarsi ispirare.

Lontano dalle tracce
«Il raid degli amici ha iniziato a fare capolino nella mente di François qualche inverno fa, così un gruppo di persone si riunisce ogni anno per qualche giorno per sciare e scoprire un massiccio. È un’esperienza per uomini, non ci sono ragazze e Layla è l'unica donna a essere accettata perché sa sciare, bere vino e raccontare stronzate o fare battute pesanti come i ragazzi. Ma il raid degli amici non è solo scherzi e vino, si scia molto anche se il biglietto d'ingresso è un magnum di rosso o champagne nello zaino. Qui niente barrette energetiche e bevande vitaminiche, è come una versione hard core della Sentinelle. I protagonisti sono per lo più Guide alpine, cercatori di cristalli, alpinisti, medici del Soccorso alpino. Insomma, il livello atletico e sciistico è alto. Basti pensare che a volte del gruppo ha fatto parte anche Hélias Millerioux…».

Introduce così Bruno Compagnet il raid degli amici in Val Maira e Val Varaita. Qualche giorno lontano dalle code per firmare la powder di Chamonix, lontano dalle responsabilità, tra amici, per riscoprire i valori più autentici dello scialpinismo, quelli che non verranno mai meno. Discese, silenzio, bufere, villaggi popolati da cani e gatti. Nelle 14 pagine con le coinvolgenti foto in bianco e nero di Layla Kerley c’è l’anima dello skialp. E nelle sei pagine a seguire una mini-inchiesta di Federico Ravassard sulla Val Maira, icona di un turismo slow e human powered che si candida a paradigma del turismo alpino del futuro. Appuntamento su Skialper 132 di ottobre-novembre.


Transamericana
Probabilmente per la prima volta Salomon TV abbandona il format del cortometraggio per un film di 75 minuti. Lo fa con uno straordinario tempismo perché il viaggio di corsa e a piedi di Rickey Gates dalla South Carolina alla California, Transamericana, è un pellegrinaggio alla scoperta di un Paese che Rickey si rende conto di non conoscere, soprattutto quel cuore degli States dove è radicato il successo di Donald Trump. E Rickey parte da Folly Beach il primo marzo del 2017, poco dopo quell’elezione, per scoprire non solo i luoghi, ma soprattutto le persone, per capire, per conoscere meglio se stesso.
Il primo tempismo, voluto, è quello di andare alla scoperta degli States più profondi con il più antico mezzo di locomozione dell’uomo, i piedi, nel momento in cui ci si interroga sull’esito delle prossime elezioni. Il secondo, ancora più potente e non voluto, è che Transamericana è tutto quello che ci manca ora: abbracci, dialoghi con sconosciuti o amici, senza timore, senza mascherina, senza diffidenza e distanza. «Sono partito pensando di essere più diverso che simile e sono tornato pensando di essere più simile che diverso» dice Gates. Ecco, in fondo il segreto di Transamericana è proprio questa sfilata di persone, parole, stili di vita che si parano davanti ai passi leggeri di Rickey. Dopo un’ora abbondante quello che ti rimane dentro è proprio il senso del viaggio, della corsa come mezzo, per scoprire, per cambiare, per spurgarci da tutte le schiavitù quotidiane, per essere pienamente presenti in quel momento e in quel luogo. Certo poi ci sono gli straordinari panorami del deserto dello Utah o delle Montagne Rocciose, ma passano quasi inosservati, perché c’è anche tanta pianura tutta uguale o foreste di robinie degli Appalacchi, ma soprattutto perché c’è l’America delle persone prima ancora che dei luoghi.
Le soggettive di Rickey inquadrano volti, case, auto, negozi. Un diario on the road fatto di up & down, di momenti belli e difficili, quando senti di avere dato tutto e il tuo fisico non risponde più, quando per attraversare il deserto ti ingegni prima con un caddie da golf e poi con un passeggino e un ombrellino per trasportare un po’ d’acqua. Quando capisci che non puoi correre di notte e dormire di giorno semplicemente perché fa troppo caldo anche per dormire e trovi la soluzione più equilibrata (no spoiler). Quando devi dormire fuori, hai solo un poncho che serve anche da tenda e nevica. I appreciate è la parola più utilizzata da Rickey, apprezzo. Apprezzo il vostro interesse per me, il vostro aiuto, anche solo spirituale. «Sono le persone più povere quello che sono pronte a darti di più» osserva Gates. Cinque mesi e 3.700 miglia in 75 minuti, da Folly Beach a Ocean Beach a San Francisco, con la delicata curiosità di Gates e la collaudata regia di Wandering Fever. Per trovare la risposta al perché andiamo raminghi con le scarpe da trail. Da vedere.
Skialper 132, alla ricerca dello spirito selvaggio dello scialpinismo
Come sarà l’inverno che verrà? Quanto le limitazioni imposte dalla pandemia incideranno sui nostri comportamenti? Non lo sappiamo, sappiamo però che l’estate appena finita ha visto la montagna in forte crescita e che nella primavera 2020, dove il lockdown è stato meno severo, lo skialp è stato lo sport più trendy. Perché è prima di tutto uno sport di distanziamento, nella natura. E il numero 132 di Skialper di ottobre-novembre va proprio alla scoperta - o alla ri-scoperta - dei valori più belli e profondi dello sci con le pelli. 176 pagine ricche di spunti per un inverno mai atteso come quest’anno.
Su quale nuvola vivevamo per non accorgerci della nostra fortuna?
Il diario dal lockdown in un monolocale di 26 metri quadrati di Maxence Gallot è un invito alla riflessione e a fare tesoro di quelle lunghe settimane per vivere il prossimo inverno con uno spirito nuovo. Abbiamo sempre avuto l’impressione di dominare il mondo, eccoci ora molto meno potenti e molto più insignificanti. Ma potremo vivere la montagna e l’inverno con occhi diversi.

Covid-19, provare a conviverci
È un dato di fatto, con la pandemia bisogna convivere, cercando di adottare le strategie più utili ad evitare il contagio (anche per proteggere le persone più deboli). Ne abbiamo parlato con un personaggio molto conosciuto nel nostro ambiente perché è l’organizzatore del festival Milano Montagna. Però Francesco Bertolini è anche molto competente in materia perché direttore della Divisione di Laboratorio di Ematoncologia all’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Così abbiamo sfruttato la sua esperienza per capire se ci sono dei consigli ad uso skialper.
Lontano dalle tracce
Un gruppo di amici, un gruppo abbastanza eterogeneo, con Guide alpine, cercatori di cristallo, professionisti della montagna. Un appuntamento, ogni anno, per qualche giorno con le pelli ai piedi, per una traversata nella quale condividere i valori più belli dello stare insieme. In valli meno frequentate di Chamonix & co. Dopo averlo intervistato, abbiamo chiesto a Bruno Compagnet di scrivere per noi e lui ci ha raccontato la sua traversata dalla Valle Varaita alla Val Maira. Le stupende foto in bianco e nero sono di Layla Kerley. Sulle orme di Bruno & co, Federico Ravassard è andato in Val Maira alla scoperta della proposta turistica diversa di questa valle e di come si proponga a esempio per il turismo alpino post-Covid.

Alta Valtellina: scoprire, riscoprire, condividere
Non si può dire che la zona dei Forni, Bormio o Livigno siano destinazioni poco popolari tra gli scialpinisti. Però ci sono itinerari o momenti nei quali è possibile sciare senza incontrare nessuno. Basta, per esempio, andare ai Forni in pieno inverno, quando la strada è chiusa. Oppure darsi allo ski sauvage nelle valli più difficili da raggiungere, abbinando avvicinamenti in e-bike, ravanage, qualche passo alpinistico… Abbiamo chiesto di parlarci delle loro esperienze solitarie a un local doc come Giuliano Bordoni, Guida alpina e da sempre amante della glisse valtellinese, e a una local acquisita, Eva Toschi, che ha scelto la Valfurva come casa. Un ampio dossier con consigli pratici e racconti da leggere con attenzione.

Lettera da…
Negli anni Trenta Ernest Hemingway pubblicava delle lunghe lettere da Cuba o dal cuore dell’Europa su Esquire. Dei racconti su come viveva e cosa faceva. Così abbiamo provato anche noi a stare al gioco in questo momento così particolare, scegliendo luoghi e persone lontani, non sempre dal punto di vista geografico, ma anche negli stili di vita. Il postino arriva da Val di Rhêmes, Gennargentu, Sauris, Alaska, Nuova Zelanda. A scrivere Louis Oreiller, Maurizio Oviglia, Anna Pugliese, Gabriella Palko e Joe Harrison.
Giù al Nord
A volte gli stereotipi si capovolgono. Così può capitare che i Monti della Laga, nel Centro Italia, siano ricoperti di powder, non ci sia il vento, ma solo il fluff e il silenzio della montagna. Come è successo a Lorenzo Alesi.

Waffle, powder e wilderness
Il nome è abbastanza impronunciabile, Låktatjåkka Mountain Lodge, però è il rifugio più alto della Svezia e - oltre a essere molto accogliente - si trova al centro di una delle ultime zone di natura selvaggia europee. A visitarlo per noi Mattias Fredriksson, autore anche delle favolose fotografie.

Dentro il van
L’hashtag #vanlife conta più di otto milioni di citazioni. Non c’è dubbio che dormire su quattro ruote sia ormai una moda e che rientri tra i trend in crescita nell’emergenza pandemia. Così abbiamo pensato di fare scrivere a una ‘vera’ vanlifer, con varie esperienze e di lunga data, Veronica Balocco, cosa vuol dire vivere in van in inverno. E per documentare il tutto siamo andati a fotografare alcuni nomi noti del mondo outdoor con i loro mezzi. Cala Cimenti, Enrico Mosetti o Paolo Marazzi dicono qualcosa? Le foto sono di Federico Ravassard.

Must have
Abbiamo tutti una dannata voglia di tornare a scivolare sulla neve polverosa. Così abbiamo scelto alcuni giocattoli che renderanno i nostri vizi ancora più belli e li abbiamo fotografati per farveli vedere meglio. E per farvi venire voglia…
E tanto altro…
Come sempre presentazioni materiali (il nuovo scarpone skialp race Ayr Nirvana, la gamma Ortles, Stelvio e Gavia di Ski Trab, la Scarpa Spin Ultra con Gore-Tex Invisible Fit), le pagine dedicate ai prodotti must have, ma anche portfolio fotografici e riflessioni per fermare l’obiettivo sul momento particolare che stiamo vivendo. E su un inverno che – ne siamo sicuri - sarà indimenticabile.












