Le UTMB World Series sono la Superlega del trail?
L’annuncio della nascita delle UTMB World Series - non del tutto inaspettato - segna un ulteriore step verso la spettacolarizzazione, professionalizzazione (e la fine dello spirito trail, secondo i più nostalgici) del mondo della corsa in natura.
Il gioco è semplice ed è piramidale. Si parte dall’alto, dalle finali, OCC, CCC e UTMB. Le tre gare della settimana chamoniarda saranno, rispettivamente, il gotha sui 50K, 100K e 100M (miglia). Per qualificarsi bisogna partecipare o a una gara delle UTMB World Series Majors (sono qualificati i primi 10 uomini e donne di ogni categoria 50K, 100K e 100M), o a una delle UTMB World Series Events (si qualificano i primi 3 di ogni categoria e distanza). Poi, ancora più sotto, ci sono le migliaia di gare UTMB World Series Qualifiers. Partecipare alle Events farà guadagnare delle pietre che permetteranno di essere ammessi all’estrazione dei pettorali UTMB, mentre le probabilità di essere estratti aumenteranno per gli iscritti alle Majors.
Nasce anche un nuovo indice di performance calcolato su quattro categorie (20K, 50K, 100K e 100M). E le gare? per ora ci sono solo le prime otto perché il calendario definitivo verrà svelato in autunno e il sistema sarà operativo dal 2022. Oltre all’UTMB ci sono Val d’Aran by UTMB (Spagna), Thailand by UTMB (Tailandia), Panda by UTMB e Gaoligong by UTMB (Cina), Tarawera Ultramarathon by UTMB (Nuova Zelanda), Ultra-Trail Australia by UMB (Australia) e Mozart 100 by UTMB (Austria). Le ultime tre gare sono targate The IRONMAN Group con il quale viene organizzato il circuito.
Nella pratica l’iniziativa UTMB diventa il vero circuito mondiale del trail e dell’ultra-trail, al quale, prevedibilmente, parteciperanno gli elite. Una specie di Superlega del trail. Rimane da capire quale sarà la posizione di gare simbolo trail come, per esempio, la Diagonale des Fous o di altre storiche competizioni che sono nel calendario dell’Ultra-Trail World Tour, come d’altra parte la maggior parte delle gare delle World Series, per esempio la Western States. Non c’è dubbio che potrebbe essere proprio l’UTWT a essere messo in ombra dal nuovo circuito. Ci saranno gare italiane? Anche questa è una domanda alla quale non c’è per ora risposta. Peraltro il più importante appuntamento italiano, la LUT, insieme, tra le altre, a Patagonia Run, Ultra Pireneu e Trans Gran Canaria, non fa più parte dell’UTWT ma del circuito Spartan Trail World Championship.
Nel comunicato di presentazione delle UTMB World Series si fa riferimento alla consultazione di una decina di atleti elite prima di dare vita al nuovo circuito. E i runner italiani come la pensano? Stefano Ruzza, settimo a Chamonix nel 2018, ha preso una posizione netta con un lungo post su Facebook. La conclusione? «L’ultratrail non è l'ironman, e Chamonix non è Kona. Gli atleti elite cosa pensano? Io non sono abbastanza elite, ma non ho alcuna intenzione di fare una delle poche gare imposte da loro per qualificarmi per un futuro UTMB. Ci sono tantissime altre belle gare che vorrei fare. E per quest'anno, mi verrebbe proprio di non andarci e di guardarmi intorno».
Il comprensorio sciistico senza impianti
Tra le poco più di mille anime di Kremmling, a 125 miglia da Denver, i cappelli con scritto Trump 2020 sono più popolari dei caschi da sci. Eppure a mezz’ora da questo sonnolento villaggio del West, lungo la strada per Steambot Springs, nel bel mezzo di una steppa fangosa, lo scorso dicembre ha aperto quella che potrebbe diventare una pietra miliare nell’evoluzione di un’industria multi-milionaria, come ha scritto Simon Usborne sul Financial Times. L’idea è semplice da immaginare quanto complicata da mettere in pratica: la prima località sciistica human powered o, come preferisce definirla Erik Lambert, co-fondatore di Bluebird Backountry con Jeff Woodward, a backcountry light ski area, un comprensorio sciistico per avvicinarsi allo scialpinismo. Bluebird Backountry ha aperto i battenti per due settimane di test nella scorsa primavera, a febbraio e marzo, al Whiteley Peak, nel Peak Ranch, e dopo un migliaio di skipass venduti, per il 40 per cento a persone che non avevano mai messo le pelli sotto i piedi, ha affrontato la sua prima, vera, stagione sciistica. Sempre su una proprietà privata, all’interno dello stesso enorme ranch, ma in un’area leggermente diversa da quella del marzo scorso, sulla Bear Mountain.
Poco meno di 400 metri di dislivello, cinque chilometri quadrati, il 15 per cento di discese verdi, il 35 per cento di blu, il 40 per cento di nere e il 10 percento di double black diamond (che nelle località sciistiche americane sono paragonabili alle nostre nere, visto che nella classificazione manca il colore rosso). L’unica differenza rispetto a un tradizionale ski resort è che non ci sono seggiovie o telecabine, ma sette tracce di salita con le pelli. E che il terreno è completamente naturale, nessun albero è stato abbattuto per fare spazio alle discese. Per il resto è tutto molto simile: un parcheggio, dove dal giovedì alla domenica è consentito dormire sul proprio van, un base lodge ospitato in una calda tensostruttura, il noleggio dell’attrezzatura, il posto di primo soccorso, i bagni (chimici), un food truck e dei barbecue all’aperto. Non manca una mid mountain warming hut, una specie di baita con bagni chimici, barbecue, posto di primo soccorso e ski patrol lungo le discese. Oltre all’area inbound, messa in sicurezza, ci sono altri 12 chilometri quadrati ai quali si può accedere solo accompagnati da una Guida. Bluebird sta per chiudere la sua stagione e in pochi giorni, prima dell’apertura, sono stati venduti 500 skipass stagionali. Lo stagionale, in pre-vendita a 299 dollari (successivamente 350) garantisce l’accesso sempre, mentre il giornaliero, che costa 50 dollari, richiede la prenotazione.

Bluebird sembra l’asso nella manica nell’inverno del distanziamento perché prevede la presenza massima di 200 persone e si passa la maggior parte del tempo all’aperto, ma l’idea è nata molto prima della pandemia. Erik e Jeff, rispettivamente 37 e 38 anni, si sono conosciuti al Darthmouth College. Nel 2018 lanciano un’indagine online, alla quale rispondono 3.000 sciatori, poi degli eventi per testare il concetto, per un totale di 6 giornate, anche all’interno di alcuni comprensori sciistici, come Winter Park. A gennaio 2020 Erik e Jeff raccolgono più di 100.000 dollari con una campagna su Kickstarter, il 330 per cento dell’obiettivo che si erano prefissati, e la scorsa primavera ecco l’esperimento delle due settimane al Whiteley Peak. «Impariamo dall’esperienza, da un giorno all’altro abbiamo cambiato anche 15-20 protocolli, per esempio ora le tracce di salita sono doppie, perché la gente vuole parlare mentre sale, ma la prima sfida se vuoi creare una località sciistica, anche quelle con gli impianti, è trovare un bel posto con il terreno giusto e tanta neve, vicino al tuo pubblico potenziale, ed è un lavoro enorme - dice Erik – Così l’anno scorso eravamo al Peak Ranch per capire se i pendii e la neve fossero quelli giusti per la nostra clientela».
Oltre al distanziamento naturale c’è un altro motivo per il quale il concept di Bluebird Backountry è tremendamente attuale in un inverno nel quale non pochi sono passati dalle piste al mondo del fuori. «Vediamo che c'è molta differenza ad avvicinarsi allo scialpinismo in modo soft, come permettiamo qui, oppure in maniera più tradizionale. Nel secondo caso, se le persone non hanno un mentore, un amico esperto con il quale iniziare, si trovano a dover scegliere tra un corso costoso che dura quattro giorni e che li spaventa o evitarlo e andare direttamente in montagna e non è un bene. Quello che abbiamo cercato di creare è uno spazio dove le persone si sentano benvenute e possano avvicinarsi allo scialpinismo sviluppando abilità e abitudini, dai materiali, alla progressione, alle inversioni, sostanzialmente imparare ad affrontare la montagna aperta». Così, accanto al comprensorio inbound, Bluebird offre due tipi di corsi, le lezioni di backcountry, suddivise in tre livelli, che durano mezza giornata o una giornata e costano 69 o 79 dollari, e i corsi di sicurezza e autosoccorso certificati AIARE (The American Institute for Avalanche Research and Education), suddivisi in tre livelli, con moduli di uno o tre giorni. Nel corso base di backcountry si imparano a conoscere i materiali, le pelli e la tecnica ed è rivolto a chi non ha mai fatto skialp, mentre il livello due è per chi ha già praticato e si concentra sul miglioramento della tecnica di salita e discesa e i rimedi per i problemi ai materiali. Infine il livello tre riguarda la programmazione della gita e l’osservazione della montagna ed è la porta d’entrata ai corsi sulla sicurezza. Rivolgendosi prevalentemente a chi si vuole avvicinare allo scialpinismo, Bluebird Backountry propone anche il noleggio di sci, scarponi, splitboard e dell’attrezzatura di sicurezza ed esiste uno skipass giornaliero comprensivo di noleggio e corso base che costa 199 dollari, mentre per esperienze nella natura che circonda il compren- sorio si può acquistare il pacchetto che prevede la presenza di una Guida per tutta la giornata, al costo di 950 dollari e da dividere fino a sei persone.
Bluebird è un’idea che viene da lontano ed è solo all’inizio della sua parabola. Nella testa di Erik ci sono già tante idee, non solo a misura di beginner. «Il nostro progetto a lungo termine è di creare un comprensorio interessante come quello delle migliori stazioni sciistiche, ma interamente human powered, e questo significa terreno ampio e vario, tanta neve, insomma un resort dove le persone possano migliorare la loro tecnica e la loro educazione allo scialpinismo, ma anche per gli scialpinisti con più esperienza che cercano una montagna meno selvaggia dove divertirsi». Forse non sarà il futuro su larga scala dell’industria multi-milionaria dello sci di massa, ma, come ha scritto Usborne, potrebbe effettivamente essere una pietra miliare, che indica la strada. Però, come ogni curva nella neve fresca è diversa e ogni otto non perfettamente sovrapponibile, anche Bluebird Backcountry non è un concetto così facilmente replicabile. Erik ne è convinto. «È un progetto che nasce dalla passione, sappiamo quanto è difficile trovare il giusto terreno; c’è ancora tanto lavoro, ma andiamo avanti perché abbiamo avuto segnali incoraggianti. C’è il rischio che una società più grande di noi copi il concetto che stiamo sviluppando anno dopo anno, magari una località sciistica? Ovviamente sì, ma i resort si concentrano su quello che sanno fare meglio, cioè gestire impianti per portare tanta gente sulle montagne, invece noi cerchiamo di creare un’esperienza unica, esclusiva. Immagina di non essere mai andato a sciare e di arrivare da solo in un comprensorio sciistico, senza amici, in un enorme parcheggio. Gli scarponi devi metterli prima di salire sul minibus che porta agli impianti o dopo? Poi arrivi al lodge e cosa devi fare? Come funziona l’attrezzatura? E gli impianti? Non c’è nessuno che ti aiuti a meno di spendere tanti soldi per prendere una lezione. Noi cerchiamo di creare un’esperienza amichevole perché ci mettiamo tanta attenzione e passione. Fondamentalmente vogliamo creare un ambiente completamente diverso». Stay hungry, stay foolish… stay backcountry.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 133

Rimbocchiamoci le maniche
Mia figlia pratica ginnastica ritmica a livello agonistico da dieci anni eppure, per qualche anno, il suo voto in ginnastica è stato un sei secco. Nella corsa è lenta, nel salto in lungo atterra corta. Le motivazioni erano le più svariate, peraltro comprensibili. Non mi piace parlare di me o della mia famiglia e, per principio, sono il tipo di genitore che, ancora oggi che si dà del tu al professore, considera a priori la ragione dalla parte di chi insegna. Però credo che questo esempio sia lo specchio del fallimento della scuola italiana, che emerge prepotentemente dopo un anno di pandemia. Un’estate e un inverno che hanno visto la riscoperta della montagna aperta hanno messo in luce i limiti di un sistema educativo che non sa (o non vuole) guardare oltre il compitino. In montagna sono arrivati ragazzi che non sanno camminare mi hanno detto senza troppi giri di parole alcune Guide alpine attive nel soccorso alpino. C’è chi fa fatica a fare un paio di scale, chi va giù secco di tallone sulla neve ghiacciata e vola, chi arriva sul cucuzzolo con le infradito.
Manca cultura dello sport e dell’attività fisica, manca ancora di più cultura dell’ambiente. Arrivano senza scarpe e abbigliamento adatto, quando il sole è già alto, e chiedono qual è il sentiero per andare su vette che richiedono tempo, preparazione e tecnica dicono i soccorritori. Oppure sono vestiti per una spedizione himalayana ma la meta è la baita poco oltre le piste di sci chiuse. Naturalmente è un’iperbole, ma dà il senso della realtà. È capitato anche a me. A febbraio, mentre partivo per un giro con sci e pelli, vedo due ragazzi, uno con la splitboard e uno attrezzato di tutto punto, con scarponi e sci top di gamma. Ci chiedono dove si può andare a fare una gita perché erano diretti da un’altra parte, fidandosi di una guida degli itinerari, ma un’ordinanza comunale vietava scialpinismo e fuoripista per rischio valanghe. Quel giorno la scala del pericolo era al livello 3. I due si accodano e, parlando, capisco che non hanno mai messo il naso fuori dalle piste e che il corso con la Guida lo faranno solo più avanti. Arriviamo a una cresta, bisogna mettere gli sci sullo zaino, ma lo zaino non ha il portasci…
Per fortuna le condizioni favorevoli e le piste di sci chiuse, che hanno attirato la maggior parte dei nuovi arrivati, hanno reso l’inverno meno problematico dell’estate, ma il punto è un altro: una società immersa nel mondo virtuale si trova ad avere sempre meno legami con l’ambiente del quale noi tutti facciamo parte e di cui dovremmo conoscere le regole. E la scuola, prigioniera di schemi novecenteschi, burocrazia e politichese, fa poco per educare all’ambiente e allo sport. Quel poco al posto del nulla è giustificato dall’intelligenza e dall’impegno di tanti professori e dirigenti, ma è il sistema che ha fallito perché non garantisce uno standard. Due anni fa mia figlia è arrivata terza ai campionati italiani del suo circuito e l’istituto dove studia (non lo stesso dove prendeva sei) le ha fatto i complimenti sul sito web. Ma quanti meriti di quella medaglia sono della scuola italiana e quanti della passione e dedizione dei ragazzi e delle famiglie o dei singoli professori? Un sistema educativo che crede nei valori dello sport per la formazione dei cittadini dovrebbe dare a priori un voto in più a chi lo pratica tutti i giorni a livello agonistico. O no?
La scuola è lo specchio del futuro di un Paese e per riparare i danni di decenni di immobilismo ci vorrà tempo, quindi meglio iniziare a rimboccarci tutti le maniche e dare il nostro contributo per creare una cultura dell’attività fisica all’aria aperta. «Attraverso i nostri canali digital e social non vogliamo solo promuovere le novità di prodotto delle maggiori aziende dell’outdoor, ma anche diffondere la cultura dell’attività sportiva e ricreativa a contatto con la natura, immaginando la possibilità di grandi campagne a tema dirette a stimolare nel pubblico e anche nelle istituzioni una sempre maggior consapevolezza sull’importanza del rapporto uomo-natura, come uno dei presupposti fondamentali per il benessere e la crescita sociale». A parlare è Vittorio Forato, responsabile per la comunicazione di Italian Outdoor Group, l’associazione che nell’ambito di Assosport raccoglie i più importanti marchi italiani dell’outdoor. Avanti così, tutti. Perché chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso.
Alex Txikon, l'alpinismo è immediatezza
In questi giorni l’alpinista basco Alex Txikon si trova in hotel a Kathmandu, insieme a Inaki Alvarez e Simone Moro. Sta facendo passare i giorni della quarantena richiesta alle autorità locali prima di dirigersi al campo base del Manaslu, che i tre tenteranno in invernale. Puntano a salire la via normale della montagna, lungo la parete Nord-Est. L’obiettivo è, oltre al raggiungimento della vetta principale, il concatenamento con il pinnacolo est (7.992 m). Inoltre l’intero progetto si sviluppa secondo le moderne regole invernali che prevedono di arrivare al campo base dopo il 21 dicembre e portare a termine la salita entro il 21 marzo. La spedizione polacca che ha compiuto la prima invernale il 12 gennaio 1984 ha raggiunto le pendici della montagna il 2 dicembre, realizzando buona parte dei lavori di preparazione della via prima del solstizio d’inverno.
Abbiamo pubblicato una lunga intervista a Txikon sul numero 130 di Skialper, lo scorso giugno. La riproponiamo a seguire.
«La vita media oscilla intorno ai 33.000 giorni, se dipendesse da me passerei la maggior parte del tempo di questo viaggio tra le montagne. Se ci fermiamo un attimo a pensare, ci sono molte cose importanti. Però solo due sono essenziali: la vita e il tempo. Ed è proprio in questi momenti che guardo indietro e vedo un bambino che gioca e sale sulla bici e, sorpreso e inquieto, mi domando: come è passato tutto così velocemente, vero?».
Alex Txikon è nato nel 1981 a Lemona, nei Paesi Baschi, ultimo di 13 fratelli. E ha cercato di mettere in pratica sempre il suo comandamento. Anche nei mesi scorsi quando si è allenato in Antartide per andare a scalare l’Ama Dablam e tentare l’Everest invernale. Risultato? Road to Himalayas: partenza da Puerto Williams, in Cile, a bordo di una barca a vela il 14 dicembre insieme a Juanra Madariaga per andare a scalare ed esplorare nelle isole Shetland Meridionali attraversando il burrascoso Canale di Drake. Poi all’inizio di gennaio, con solo due giorni di riposo, subito in Nepal per trovare Félix Criado e Ínigo Gutiérrez Arce, che hanno raggiunto il Nepal in auto dalla Spagna. Rientro a inizio marzo, giusto in tempo per chiudersi in casa per il lockodwn. «L’Antartide è uno dei posti più meravigliosi della terra e credo che, piuttosto che attraversare mezzo mondo per raggiungere l’Himalaya od organizzare conferenze stampa e rilasciare interviste, sia molto più interessante stare in montagna con le persone che ti sei scelto e arrivare con una motivazione molto più grande in Nepal. Non era la prima volta in Antartide per me: i paesaggi e la logistica sono unici e si può ancora fare alpinismo ed esplorazione di altissimo livello».
Alex Txikon non è rimasto mai fermo. Il suo curriculum, sulla soglia dei 40 anni, è una lunga lista. Dopo i primi 4.000 nelle Alpi, nel 2003 è arrivato il primo Ottomila, il Broad Peak e l’anno successivo il Makalu; ha iniziato a lavorare come cameraman-alpinista per la trasmissione tv Al Filo de lo Imposible, si è unito al progetto di Edurne Pasaban, prima donna a raggiungere tutti i 14 Ottomila. Lui ne ha raggiunti 11, il Shisha Pangma due volte, alcuni in stile alpino. Dal 2011 è andato in Himalaya ogni inverno e spesso anche nella stessa estate. Nel 2016 la prima invernale del Nanga Parbat sulla via Kinshofer con Simone Moro e Ali Sadpara, nell’inverno 2013 la prima del Laila Peak e in primavera il Lhotse. Nell’inverno 2011 e 2012 tenta il Gasherbrum I, ma è costretto a fermarsi sopra i 7.000 metri e nella seconda occasione perde tre compagni di spedizione. Il G1 e G2 si sono arresi nell’estate del 2011, il K2 mai, nonostante più tentativi, l’ultimo nell’inverno del 2019. E neppure l’Everest, che lo scorso inverno non si è concesso come in quello del 2017 e del 2018. In mezzo spedizioni e prime salite in Antartide, Groenlandia, Himalaya, base jumping, documentari pluripremiati ai vari film festival.
Alex, che cos’è il nuovo alpinismo?
«È immediatezza, perché oggi con i social media è tutto istantaneo, ma dipende dal tuo Paese di origine, dalla tua visione e soprattutto, oggi, rispetto alle generazioni precedenti, ci sono moltissimi tipi di alpinismo di alto livello».
E l’himalaysmo invernale, che cosa rappresenta per Alex Txikon?
«Gli Ottomila invernali continuano a essere un luogo nel quale mi trovo a mio agio, mi piace lottare con le condizioni meteorologiche, mi piace soprattutto la montagna, perché è completamente diversa e non c’è l’affollamento degli altri mesi dell’anno».
Hai detto che gli 8.000 invernali sono una questione di velocità prima ancora che resistenza, il fast & light è il nuovo alpinismo?
«Credo che più veloce sei, meno tempo passi nei campi in quota, più possibilità hai di raggiungere la vetta e di farlo in maggiore sicurezza, cioè di sopravvivere, perché le finestre meteo favorevoli sono limitate. Passare dal campo 1, 2, 3, 4? Oggi in inverno, con un buon lavoro di preparazione, puoi arrivare direttamente al campo 3».
L’himalaysmo è stato a lungo conquista nazionalistica delle vette, oggi invece unire le forze tra spedizioni può aiutare a raggiungere gli obiettivi, come al Nanga Parbat nel 2016. Però le montagne sono ricche di episodi di rivalità ed è quello che è successo nella tua spedizione al K2 nel 2019 quando non c’è stata collaborazione con la spedizione russo-kazaka-kirghisa.
«Domani (il 14 maggio, ndr) si festeggia il quarantesimo anniversario della prima scalata basca dell’Everest, la quattordicesima bandiera a sventolare sul tetto del mondo, portata dalla Ci sono gli Ottomila invernali, ma ci sono anche i Settemila o i Seimila… «Certo, siamo saliti sul Pumori, l’Ama Dablam, il Laila Peak, il Gasherbrum I, a quote più basse: siamo degli specialisti, non ci ciucciamo il dito e sappiamo quello di cui parliamo».
Come ti acclimati, hai mai usato le tende ipossiche?
«Sì, una volta, aiutano molto, però credo che non ci sia niente di meglio dell’acclimatamento fatto sul luogo, le tende sono un aiuto per chi ha poco tempo».
Limiti, paura, rischio, come ti confronti?
«I limiti, la paura, il rischio li stabilisci tu stesso. La paura, il limite e il rischio sono i compagni della prudenza: più paura, più prudenza. Al contrario di quanto si pensi».
Hai lavorato come cameraman in una trasmissione tv, cosa pensi dell’alpinismo-show e dei mezzi di comunicazione?
«Ci sono anche i social media e io sono attivo, però non sono un appassionato di questo mondo, mi piace ancora leggere sulla carta stampata, invece di premiare l’immediatezza e diventare un consumatore seriale di video, preferisco leggere una rivista mensile e cercare la qualità».
Ali Sadpara, Simone More, Daniele Nardi, Ferran Latorre, Adam Bielecki, Krzysztof Wielicki, Denis Urubko, Tomasz Mackiewicz, Ueli Steck, Reinhold Messner. Le tue strade si sono incrociate con quelle di altri alpinisti, hai qualche ricordo particolare?
«Con tutti, belli e brutti. Ognuno ha la sua strada che ogni tanto incrocia le altre, ma corrono parallele tra di loro e nella stessa direzione. Voglio conservare ricordi positivi di ciascuno di loro».
Ed Edurne Pasaban?
«Questa settimana cade il decimo anniversario della scalata del Shisha Pangma che nel 2010 l’ha fatta diventare la prima donna ad avere salito tutti i 14 Ottomila e sono orgoglioso di avere fatto parte del suo team».
Hai definito il Nanga Parbat la montagna delle montagne, qual è la montagna della tua vita, sempre il Nanga?
«Tutte, tutte le montagne sono spettacolari, tra il Nanga e il Makalu scelgo il Makalu perché è tra le prime che ho scalato e ho dei ricordi particolari, il Nanga Parbat per me è importante come tutte le altre montagne».
Cosa vuol dire essere il tredicesimo figlio?
«Ho sempre dovuto lottare, ogni dettaglio di tutto quello che ho raggiunto l’ho conquistato con il lavoro e l’aiuto degli amici e delle persone vicine, però l’insegnamento più grande che mi ha dato è l’importanza della vita e della forza di volontà, sapere qual è il tuo posto».
La pandemia ha cambiato le nostre vite, anche la tua. Qual è l’insegnamento che ti ha dato?
«Ho lavorato molto, a un nuovo libro, a un film. Ho lavorato quindici ore al giorno, ma ho dedicato il tempo a me invece che agli altri o a stare in aeroporto. Fermarsi, guardare e pensare dove mettere il prossimo granello di sabbia e in che direzione stiamo remando è l’insegnamento più importante».centoquattresima persona, se non sbaglio. Però oggi ognuno scala per sé, per essere più veloce, ci sono gli sponsor: è cambiato tutto. Unire le forze ti dà più opzioni, come è successo con Simone e Tamara, perché noi eravamo in tre, loro in due, e se uno sta male, cosa fai? Credo che per salire un K2 in inverno bisogna unire le forze, costruire e non distruggere».
Qual è la tua filosofia di spedizione?
«Semplice, che ci sia empatia tra i partecipanti, che tutti siano pagati e che ci sia trasparenza: abbiamo gli sponsor ed è giusto dividere i soldi con gli altri. Devi comportarti bene, devi scegliere l’attività che credi conveniente per sopravvivere e perché il tuo team sia supportato e non ci siano incidenti o morti, ci vuole tutto il necessario per affrontare la sfida».
Nel 2019 volevi provare l’Everest invernale dal versante Nord e poi hai ripiegato sul K2 perché non hai avuto i permessi, perché nel 2020 hai attaccato ancora l’Everest dal Khumbu?
«Anche quest’anno ci sono stati problemi per i permessi e abbiamo sentito che al K2 ci sarebbe stata tanta gente: non abbiamo voluto trovarci nel gioco del 2019 con i russi. Credo che avessero perso del tutto la testa, che pensassero di essere in una partita contro quelli che erano accanto a loro».
Stazioni meteo portatili e droni, nuovi attrezzi per un nuovo alpinismo? I droni sono utili solo per i soccorsi o anche per le ricognizioni? Invece per il campo base ami costruire igloo, perché?
«Avere i dati reali delle piccole stazioni che puoi portarti dietro e quelli che arrivano da lontano è molto diverso. I droni? No, non li usiamo per la ricognizione della via, ma sono fondamentali per i soccorsi. In uno dei voli alla ricerca di Tom e Daniele (Ballard e Nardi sul Nanga Parbat, ndr) dal campo base li ho visti in modo netto. Però solo guardando al passato possiamo costruire il futuro. Per questo al campo base sono utili gli igloo: ci hanno aiutato tantissimo a mantenere un ritmo cardiaco e una saturazione dell’ossigeno nel sangue migliori, a riposare di più, a essere protetti, ma soprattutto a tenere alta la temperatura; ci sono i dati a dimostrarlo: fuori c’erano meno venti e dentro si stava bene, intorno agli zero gradi».
Tra i tuoi partner tecnici c’è Ferrino, da quanto tempo?
«Da un anno, è una marca che mi è sempre piaciuta molto, già al tempo di Edurne Pasaban, è un’azienda di famiglia che quest’anno compie nientemeno che 150 anni. Sono orgoglioso di fare parte di questa grande squadra e di usare zaini, tende e altri prodotti, ma soprattutto di essere ambasciatore dei valori di Ferrino che vanno a braccetto con i miei. Le tende sono le migliori che ci siano, senza alcun dubbio».
Steve House, Mark Twight, Ueli Steck ci hanno insegnato che si può allenarsi per l’alpinismo, come per qualsiasi sport. House ha scritto che l’alpinismo è all’80% mentale e al 20% fisico. Sei d’accordo?
«Steve, Mark, Ueli sono la punta di una freccia che ha segnato una tendenza, anche a me piace allenarmi duramente, ma la motivazione viene prima di tutto. È la motivazione che mi fa raggiungere gli obiettivi e canalizzare tutte le energie. Ottanta/venti? Sono totalmente d’accordo, io direi settanta/ trenta, però devi avere fiducia, credere in te stesso, altrimenti sei fottuto».
Quel bambino che andava in bici ora ama le moto. Nel 2007 si è comprato una Royal Enfield Line Art con la quale ha attraversato il Nepal da Nord a Sud e che è stata distrutta nel 2015 dal crollo dell’edificio che la ospitava a causa del terremoto. Poi è arrivata una Royal Enfield Bullet Machismo con la quale ha viaggiato da Kathmandu ad Amristar, attraversando l’India. «Questo tipo di moto, la sua storia, mi hanno sempre affascinato, così tre anni fa ho comprato la terza, un modello del 1978. L’ho presa a Nuova Delhi e l’ho completamente restaurata, trasformandola in una reliquia da trattare con cura». Nel 2019 quella Royal Enfield è salita su una nave fino a Barcellona e poi su un camion fino in Bizkaia. «Vederla arrivare a casa e aprire quella cassa mi ha fatto salire le emozioni, tornare a quelle strade nelle quali sono cresciuto, ai suoni e ai ricordi di quegli angoli di India e Nepal. Incredibile».
A PROPOSITO DELLA SPEDIZIONE AL MANSALU
Una sfida umanitaria e sostenibile
Come già accaduto lo scorso inverno, anche questa volta Alex cercherà di offrire il suo aiuto ai popoli delle montagne. In questa occasione avrà con sé centinaia di lampadine solari da distribuire alle famiglie che abitano la regione del Makalu. «Una lampadina cambia radicalmente la vita di una famiglia» il commento di Txikon. «Non ce ne rendiamo conto, ma per questi villaggi avere la luce di notte può significare che i bambini possono imparare a leggere e a scrivere». L’altra finalità è quella di fornire strumenti, come le lampadine solari, che lascino il minor impatto possibile sull’ambiente. La stessa cosa anche al campo base dove verranno installati due pannelli solari (uno verrà poi donato alla locale scuola al termine della spedizione).
I prodotti scelti da Alex Txikon
Alex Txikon partirà per il Manaslu con materiali della linea Ferrino High Lab. Il campo base sarà composto dalle tende Colle Sud e Campo Base, mentre per i campi più alti Alex e compagni potranno contare sulle tende Snowbound, Maverick e Pilier, dormendo nei sacchi a pelo HL 1200 RDS Revolution. Tra le tende della linea High Lab spicca la nuova Pilier. Si tratta di un must di Ferrino che è stato aggiornato per alcuni dettagli e uscirà sul mercato il prossimo inverno. Questa tenda, testata da Alex anche nelle sue precedenti spedizioni, è dotata di un sistema di paleria esterna che permette un montaggio rapido.

The players: Pier Luigi Mussa
«Un tempo a Lanzo, 500 metri di quota, nevicava a inizio stagione e quei 20, 30 centimetri rimanevano per tre mesi, ora fa al massimo una spruzzata che si scioglie subito». Pier Luigi Mussa, classe 1956, vive da sempre a Lanzo, anche quando faceva il pendolare tutti i giorni per lavorare a Torino, in un’azienda del mondo delle telecomunicazioni. E in montagna ci va da fine anni ‘70. «La quota neve è salita di almeno 500 metri, ma non è l’unico effetto del cambiamento del clima: l’estate una volta finiva con i primi temporali dopo Ferragosto, oggi va avanti anche fino a ottobre e poi pioveva quasi tutti i pomeriggi, ora molto meno, ma quando arriva il temporale fa danni».
Tutte osservazioni frutto di tanti giorni passati sulle sue montagne e di una passione per la meteorologia. Una delle tante, perché Pier Luigi non ama annoiarsi e anche lo scialpinismo era all’inizio solo uno dei tanti hobby. Più un modo per mantenersi in allenamento che una vera e propria passione. «Per un po’ di anni ho fatto un po’ di tutto: deltaplano, tanta montagna e alpinismo, bici e mountain bike, sci di pista e snowboard. Lo scialpinismo era un altro modo per andare in montagna anche in inverno, le prime uscite le ho fatte con gli scarponi da pista nello zaino e gli sci normali, poi ho comprato la prima attrezzatura vera da scialpinismo». Poi smette di fare deltaplano e quel modo di andare in montagna in inverno diventa davvero una passione. «Ho anche fatto parte del Soccorso Alpino e ho partecipato a tanti interventi, soprattutto per escursionisti e fungaioli che si erano persi».
In anni di escursioni Pier Luigi non si è mai trovato a tu per tu con la valanga. «Ripensandoci, qualche rischio l’ho corso, ma soprattutto da giovane, poi ho cominciato a studiare la neve e con la conoscenza e con l’esperienza ho adottato un atteggia- mento conservativo, la montagna è talmente grande per scegliere i posti più sicuri, se li conosci, e poi è importante soprattutto sapere uscire con le condizioni giuste». Ed ecco che si arriva al consumismo, quella voglia di macinare, di consumare metri e metri, di salire solo sulle vette più iconiche e vendibili sui social, di cambiare sempre meta e vallata. Mentre lo scialpinismo è tanto bello per quel senso di attesa, di profonda conoscenza dei luoghi, di studio e preparazione della gita giusta e nel posto giusto. E anche per la rinuncia. O per la ripetizione. «Incontro sempre più spesso scialpinisti che sono in valle per la prima volta e poi scappano via alla ricerca di altri posti oppure che vanno al Ciarm del Prete in pieno inverno perché lì bisogna esserci stati prima possibile e poi postano relazioni su una brutta sciata, ma le gite vanno fatte nel periodo giusto. Oggi se non scii oltre una certa quota o fai solo mille metri di dislivello non va bene». Posti giusti nei momenti giusti, e allora dove? «Per esempio nel vallone degli Ortetti che è proprio qui sopra: io amo soprattutto itinerari molto vari, dove il terreno è aspro e cambia continuamente e spesso sono posti che in estate sono più difficili da raggiungere, perché la montagna in inverno si trasforma. E poi se sei uno scialpinista, come dice la parola stessa, passi quasi dappertutto». Magari però dove non sono passate le orde da social...
QUESTO RITRATTO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 122
The players: Ezio Sesia
«La prima gita scialpinistica documentata di Adolfo Kind è stata proprio qui in valle, a fine dicembre 1896 e anche la prima ascensione di alpinismo invernale del CAI, il 24 dicembre del 1874 all’Uja di Mondrone» mi dice Ezio Sesia, classe 1955, mentre guida verso Cornetti, nell’alta valle di Ala, la centrale delle tre Valli di Lanzo. Non è facile trovare qualche fazzoletto di neve dopo settimane di alta pressione e vento e anche oggi il cielo è blu intenso e solo le vette delle montagne e i valloni in ombra conservano un po’ di oro bianco. E per parlare di scialpinismo vogliamo andare in ambiente, se poi riusciremo anche a fare una breve pellata, meglio. «Lo faccio per voi, dopo anni di gite e ora che ho il tempo a disposizione esco solo se ci sono le condizioni per divertirmi, se ne vale la pena». E di uscite con le pelli Ezio ne ha fatte tante visto che, insieme a Pier Luigi Mussa, nostro compagno di gita, ha scritto per i tipi di Mulatero editore Scialpinismo nelle Valli di Lanzo. Originario della valle, di Mezzenile, Ezio ha vissuto 45 anni a Torino, dove faceva il bancario, per poi ritornare in valle quando ha ottenuto il trasferimento lavorativo in zona. «Per me il primo gennaio del 2000 non è stato solo il passaggio del secolo, ma l’inizio di una nuova vita» scherza ricordando quella decisione.
In montagna, con o senza sci, Ezio ci è sempre andato. «In quegli anni tutti i bambini mettevano un paio di sci, si sciava nei prati, scalinando per salire». Ma lo scialpinismo è arrivato in un altro modo e quello spirito delle origini è rimasto dentro Ezio. «Era il 1973, avevo 18 anni e con una compagnia di amici con i quali ci ritrovavamo durante le vacanze estive decidemmo di salire per andare a vedere come erano con la neve quei posti tanto belli in estate, naturalmente con gli sci in spalla per tutta la salita». Fu amore a prima vista, però solo per Ezio. «Ancora oggi ci frequentiamo e qualcuno mi dice che vuole iniziare, ma non so se mai lo faranno». Questo non vuol dire che Ezio in montagna ci vada da solo. «Qualche volta sì, se la neve non è il massimo faccio anche fondo escursionistico, ma l’anno scorso sono caduto stupidamente, praticamente da fermo, e mi sono rotto la spalla: comunque mando sempre un sms a un’amica dicendo dove vado e poi al rientro». Spesso il compagno di gita è Pier Luigi, come oggi, ma in valle anche altri condividono la passione. «Ci siamo conosciuti a un torneo estivo di pallone e, ritrovandoci dopo alcuni anni, abbiamo iniziato a fare scialpinismo insieme». La valle non è il confine dei sogni di Ezio: «Se si organizza una macchinata con gli amici, andiamo anche altrove, ma la maggior parte delle volte rimaniamo nelle Valli di Lanzo, dove dopo anni comunque riusciamo ancora a trovare alcune varianti o addirittura qualche gita nuova». Ripetere gli stessi itinerari non a tutti piace, non è sempre così per Ezio. «Ce ne sono talmente tanti che non capita spesso, ma alcuni grandi classici vale la pena di rifarli, io vi consiglio sicuramente la Punta Rossa di Sea, un bell’itinerario in ambiente aperto; quando ci sono le condizioni merita davvero». Appunto, quando ci sono le condizioni, e per ora non ci sono, così, dopo qualche fotografia, torniamo all’auto e togliamo gli scarponi. «Segnatevi questa data: 24 febbraio, quel giorno nevicherà perché Ezio va a fare la settimana bianca in Val Venosta e quando esce dalla valle arriva sempre la neve» dice sorridendo Pier Luigi.
QUESTO RITRATTO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 122
Chiude Powder Magazine
Anche per uscire di scena hanno scelto lo stile leggero e inconfondibile che ha attraversato come un filo rosso tutti i 49 anni della loro storia, con la foto in bianco e nero di una ragazza che sorride e guarda la neve che cade dal cielo. Un po' come Radiofreccia che chiude un minuto prima di compiere 18 anni. La notizia, prima diffusa dal passaparola di Instagram e anticipata in un interessante articolo di Steve Casimiro, a lungo anima della rivista e ora editore di Adventure Journal, è ufficiale: Powder Magazine cesserà le pubblicazioni (e di conseguenza anche l’aggiornamento del sito internet e dei canali social) a partire dal prossimo 20 novembre. La comunicazione è arrivata venerdì scorso con una email ai dipendenti da A360 Media LLC, il gruppo editoriale (editore anche di tabloid e testate generaliste ad alta tiratura) di cui fanno parte Bike, Surfer e Snowboarder, altre testate che verranno chiuse.
«Non sappiamo se e quando questo iato finirà - scrivono sul sito della rivista statunitense - Sappiamo, però, che abbiamo ancora da lavorare e due numeri della rivista da fare». Il 16 novembre uscirà l’ultimo Photo Annual, il marchio di fabbrica di Powder, dal quale sono passati tutti i grandi nomi della fotografia di sci fuoripista e che ha creato mode e stili.
Powder ha attraversato epoche, mode, crisi, mantenendo sempre uno stile originale e producendo contenuti di qualità, nonostante il passaggio di diverse proprietà. «Sì, abbiamo giocato molto. Ma abbiamo anche lavorato molto, e credo di poter parlare a nome di tanti di noi quando dico che quelle serate passate a lavorare fino a tardi sono state magiche. Stressanti, sì, ma allo stesso tempo eravamo nella nostra piccola bolla, una manciata di persone unite nel tentativo di creare qualcosa di speciale e a suo modo importante» ha scritto Steve Casimiro. La parabola della rivista si è incrociata più volte con quella delle grandi case editrici nordamericane con numeri, obiettivi e costi sempre più inconciliabili con il mondo della neve e degli sport outdoor dove sopravvivono - negli States come in Europa - gli editori indipendenti. La crisi portata dalla pandemia ha fatto da detonatore. Proprio negli stessi giorni sul sito di Backcountry Magazine, altra rivista di riferimento nordamericana e principale competitor di Powder, è bene in evidenza un editoriale nel quale la redazione al completo sottolinea come la buyer’s guide uscirà con i consueti standard di qualità ma 16 pagine in meno, tutte di pubblicità, e chiede di sostenere i piccoli editori indipendenti. Il direttore editoriale della casa editrice di Backcountry, Tyler Cohen, ha scritto un interessante articolo sulla chiusura di Powder. «Il monitoraggio regolare di Powder ha portato in parte al nuovo logo e allo stile di copertina di Backcountry, ridisegnato l'anno scorso; ci ha spinto a includere più storie in ogni numero; (...) Powder ha contribuito a plasmare Backcountry, ben oltre la direzione di Adam Howard, CEO di Height of Land (editore di Backcountry, ndr), con la consulenza di Steve Casimiro». «Per 43 anni, Powder ha fatto tutte queste cose e le ha fatte molto, molto bene. Ora il mondo dello sci sarà più povero» conclude Cohen.
«Non sappiamo cosa ne sarà di Powder, solo che la sua assenza per un certo periodo di tempo sarà pesante per chi di noi è rimasto affascinato dalle sue parole e dalle sue immagini lungo il viaggio di 49 anni - scrive Sierra Sfaher, editor in chief della rivista - Ci auguriamo che vi abbia offerto una casa; un luogo dove gli sciatori possano venire per l'umorismo, la riflessione, l'ispirazione, l'onestà, e un piccolo assaggio della gioia che sappiamo si può trovare solo, come hanno scritto i redattori che fondarono la rivista, nell'allontanarsi dalla folla verso un luogo dove non ci sono linee, non ci sono impianti, non ci sono recinti e altri sciatori. Solo neve».
Auguriamo alla redazione di Powder di riuscire a trovare una forma per riaffermare il suo spirito libero, perché, come hanno scritto Dave Moe, Jake Moe e Bruce Bailey sul primo editoriale della rivista, per noi powder significa libertà, con un'enfasi non su come esserlo, ma solo su come esserlo sempre di più.
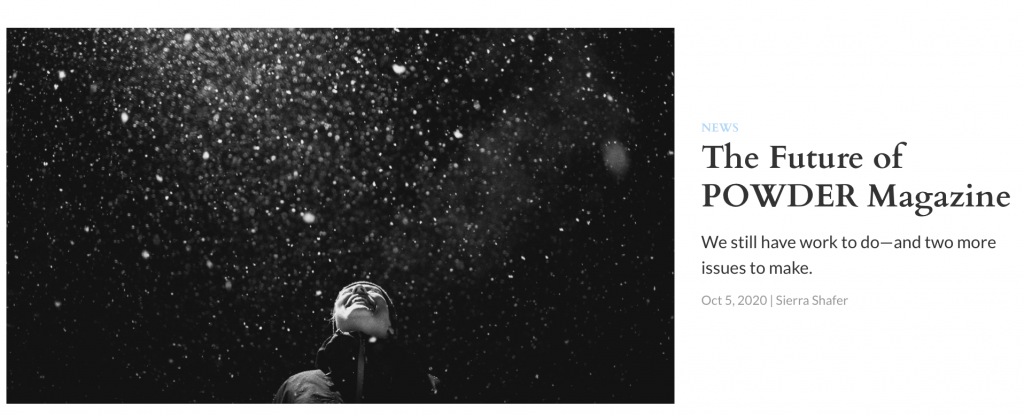
Transamericana
Probabilmente per la prima volta Salomon TV abbandona il format del cortometraggio per un film di 75 minuti. Lo fa con uno straordinario tempismo perché il viaggio di corsa e a piedi di Rickey Gates dalla South Carolina alla California, Transamericana, è un pellegrinaggio alla scoperta di un Paese che Rickey si rende conto di non conoscere, soprattutto quel cuore degli States dove è radicato il successo di Donald Trump. E Rickey parte da Folly Beach il primo marzo del 2017, poco dopo quell’elezione, per scoprire non solo i luoghi, ma soprattutto le persone, per capire, per conoscere meglio se stesso.
Il primo tempismo, voluto, è quello di andare alla scoperta degli States più profondi con il più antico mezzo di locomozione dell’uomo, i piedi, nel momento in cui ci si interroga sull’esito delle prossime elezioni. Il secondo, ancora più potente e non voluto, è che Transamericana è tutto quello che ci manca ora: abbracci, dialoghi con sconosciuti o amici, senza timore, senza mascherina, senza diffidenza e distanza. «Sono partito pensando di essere più diverso che simile e sono tornato pensando di essere più simile che diverso» dice Gates. Ecco, in fondo il segreto di Transamericana è proprio questa sfilata di persone, parole, stili di vita che si parano davanti ai passi leggeri di Rickey. Dopo un’ora abbondante quello che ti rimane dentro è proprio il senso del viaggio, della corsa come mezzo, per scoprire, per cambiare, per spurgarci da tutte le schiavitù quotidiane, per essere pienamente presenti in quel momento e in quel luogo. Certo poi ci sono gli straordinari panorami del deserto dello Utah o delle Montagne Rocciose, ma passano quasi inosservati, perché c’è anche tanta pianura tutta uguale o foreste di robinie degli Appalacchi, ma soprattutto perché c’è l’America delle persone prima ancora che dei luoghi.
Le soggettive di Rickey inquadrano volti, case, auto, negozi. Un diario on the road fatto di up & down, di momenti belli e difficili, quando senti di avere dato tutto e il tuo fisico non risponde più, quando per attraversare il deserto ti ingegni prima con un caddie da golf e poi con un passeggino e un ombrellino per trasportare un po’ d’acqua. Quando capisci che non puoi correre di notte e dormire di giorno semplicemente perché fa troppo caldo anche per dormire e trovi la soluzione più equilibrata (no spoiler). Quando devi dormire fuori, hai solo un poncho che serve anche da tenda e nevica. I appreciate è la parola più utilizzata da Rickey, apprezzo. Apprezzo il vostro interesse per me, il vostro aiuto, anche solo spirituale. «Sono le persone più povere quello che sono pronte a darti di più» osserva Gates. Cinque mesi e 3.700 miglia in 75 minuti, da Folly Beach a Ocean Beach a San Francisco, con la delicata curiosità di Gates e la collaudata regia di Wandering Fever. Per trovare la risposta al perché andiamo raminghi con le scarpe da trail. Da vedere.
Dolomiti Half Marathon Experience
l risultato dell’equazione della bellezza è, su per giù, 21. Ci rifletto la sera, stanco e abbronzato, dopo avere provato in fila il percorso dell’Alpe di Siusi Half Marathon e della Dolomites Saslong Half Marathon. Perché dopo che hai messo i tuoi piedi uno davanti all’altro per due giorni, immerso nella natura incredibilmente bella e unica delle Dolomiti nel cuore di un’estate particolarmente assolata, dimentichi tutto, anche la distanza coperta. E, probabilmente, il cronometro. Oppure è proprio questa bellezza che ti fa volare ancora più veloce. Non lo so, me ne frego come Achille Lauro, perché le emozioni superano tutto e quasi non mi ero accorto che due gare che si dipanano a pochi chilometri di distanza misurano entrambe la fatidica distanza della mezza maratona. E forse è anche questo il segreto del successo dell’Alpe di Siusi e della Dolomites Saslong, che sono riservate, rispettivamente, a 600 e 700 runner, perché anche la grande bellezza, per rimanere tale, deve essere per molti, ma non per tutti.
E poi tutti le hanno a disposizione sempre, come noi in questa breve ma intensa vacanza di corsa. Perché l’equazione della bellezza è 21, se vogliamo metterla in numeri, se vogliamo considerare una distanza umana.
Ma sta soprattutto nei percorsi e nell’ambiente nel quale si snodano come dei serpenti. E nel quale rimangono sempre, ben segnati, da provare e coprire al proprio ritmo, in un solo colpo o in sezioni, fermandosi nei mille rifugi gourmet piuttosto che al rifornimento. Perché l’Alpe di Siusi e la Val Gardena sono un immenso parco giochi per il runner, con tanti altri percorsi oltre a quelli delle gare, per cambiare itinerario ogni giorno e ubriacarsi di bellezza.

E perché quest’anno, a causa dell'emergenza Covid-19, le due gare non si sono disputae. Ma i sentieri saranno comunque lì, anche solo per allenarsi nel 2020 in vista dell’edizione 2021. «È bello correre qui perché, diciamolo, all’Alpe di Siusi Half Marathon vieni per fare il tempo e guardare la classifica dà sempre soddisfazione, ma vieni soprattutto per farti del bene, per correre nella natura e nei panorami incredibili dell’altopiano» mi dice Egon Zuggal, allenatore FIDAL di atletica, istruttore di functional fitness e di mountain bike mentre proviamo lo strappo nei pressi dell’hotel Icaro, dove c’è un tratto di sentiero abbastanza breve ma in costante e decisa pendenza fino all’arrivo della telecabina che sale da Ortisei, al Mont Seuc. Egon, insieme a Rudi Brunner, specializzato in sport di resistenza e diagnostica della performance, tecnico ortopedico e anche lui allenatore FIDAL, organizza l’Alpe di Siusi Training Camp, una settimana prima della gara, per allenarsi e migliorare la propria tecnica di corsa. Il Training Camp prevede la prova del percorso in due diverse sessioni, ma anche analisi ortopedica del piede, clinic di corsa, functional fitness, corsetta al chiaro di luna con cena in baita, seminari sulla nutrizione sportiva. La mezza dell’Alpe di Siusi, misurata dalla FIDAL per corrispondere alla fatidica distanza di 21,0975 km, ha un percorso abbastanza dolce, quasi sempre corribile e senza difficoltà tecniche. Il dislivello è di 600 metri e i primi tre chilometri sono su strada asfaltata, ma si lascia presto il nastro di bitume per sentieri e strade forestali. Proprio all’inizio c’è forse il tratto più tosto, quello che ti può subito tagliare le gambe, questa salita dell’Icaro, breve ma intensa. Poi si fila via leggeri con lo sguardo che corre verso il Sassolungo e il Sassopiatto, lo Sciliar, il Sella. L’Alpe di Siusi è un grande altopiano al centro delle Dolomiti, con pascoli e baite dalle pendenze dolci. Si parte da quota 1.842 metri e si superano di poco i 2.100 metri. «Dopo il Mont Seuc si scende ad anello verso il punto di partenza della salita e ci si dirige verso Wiednereck, al chilometro 10, per salire alla Baita Rosa Alpina, a 2.015 metri e all’hotel Punta d’Oro, a 2.049 metri». Egon non fa in tempo a descrivere questa parte del percorso, che corre sul versante opposto dell’Alpe e chiude un anello che disegna una farfalla insieme a quello del Monte Seuc, che saliamo a pestare con i nostri piedi le mulattiere e i pascoli. Dalla Punta d’Oro si prosegue verso il Panorama, il Laurin e si scende al punto di partenza a Compatsch. La vista, se possibile, è ancora più bella, più sconfinata. Lo sguardo corre anche a Nord, verso l’Austria. Il terreno è un docile sali-scendi, con una riga bianca disegnata tra i pascoli e le baite. Di tanto in tanto delle passerelle di legno galleggiano sui campi in fiore. E il naufragar m’è dolce in questo mare.
Saliamo di prima mattina al Monte Pana. Il cielo è terso e l’aria frizzante. Non ero mai stato quassù, a 1.616 metri di quota. I prati lasciano subito il posto ai boschi e gli scogli del Sassolungo e Sassopiatto ti sovrastano. Abbiamo appuntamento con Manuela Perathoner all’hotel Cendevaves. Manuela è la presidentessa dei Gherdëina Runners, 70 tesserati con nomi illustri come quelli di Alex Oberbacher, Christian Insam e Georg Piazza, ma anche tanti runner che hanno fatto della corsa una ragione di vita, con obiettivi di cronometro diversi. Manuela presiede anche il comitato organizzatore della Dolomites Saslong Half Marathon powered by Scarpa, in pratica un’emanazione dei Gherdëina Runners. «Prima della Dolomites organizzavamo la Mountain Run, con partenza da Ortisei e salita fino al Monte Seceda, 15,5 chilometri e 1.200 metri di dislivello, è stata anche Campionato italiano di corsa in montagna, ma non è mai davvero decollata» mi dice mentre corricchia per riscaldarsi attorno al laghetto nel bosco. Così a un membro del consiglio direttivo dei Gherdëina è venuta l’idea di disegnare una corsa attorno al Sassolungo e al Sassopiatto. «Alla prima edizione abbiamo chiuso le iscrizioni due settimane prima, alla quota massima di 400 persone, l’anno scorso i 600 pettorali sono andati sold out» dice con il sorriso sulle labbra Manuela. Già, la Dolomites Saslong è solo al terzo anno di vita ma è diventata una grande classica in grado di attrarre tre volte più runner della precedente gara. Il perché lo scopriremo poco dopo, ma forse volgendo lo sguardo alle cime sopra la nostra testa potrebbe già arrivare una prima risposta. Però i nostri occhi vengono attratti da altro. Un gruppo di persone con maglietta, pantaloncini e scarpe da running sta facendo ripetute sugli scalini del trampolino del salto con gli sci. Sono Birgit e Christian Stuffer, i proprietari dell’hotel Cendevaves, alla partenza e arrivo della gara, anche loro tesserati con i Gherdëina Runners. Si tirano dietro una decina di ospiti dell’albergo. Christian ha un personal best di 2h35’42’ nella maratona di Amsterdam, Birgit di 3h01’44’’ in quella di Francoforte. Hanno messo la corsa al centro del loro stile di vita e organizzano vacanze e stage a ritmo di running, con allenatori e atleti, anche keniani, oltre al pacchetto speciale per la Dolomites Saslong, con pasti e colazioni ad hoc, massaggio, late check-in il giorno della gara (cendevaves.it).

Non c’è tempo di fermarsi troppo a chiacchierare della nostra passione, ci aspettano i 21 chilometri di percorso. Da qui si sale al Rifugio Comici, a 2.153 metri, per poi correre in leggera discesa verso la Città dei Sassi, un dedalo di massi davvero suggestivo, e il Passo Sella. Dal Sella si risale per il rifugio Salei e per svalicare in direzione del Rifugio Friedrik August e correre sul versante più selvaggio, con lo sguardo che vola verso il Latemar e la Val di Fassa. Restano il Rifugio Pertini e il Sassopiatto prima della discesa nel bosco della Val Scura, che riporta al Monte Pana. In tutto sono 21 chilometri e 900 metri di dislivello positivo, con il punto più alto a quota 2.363 metri. Non c’è un metro di asfalto, per metà si corre su sentiero, per l’altra metà su trail ghiaiosi. Ma soprattutto si corre facendo il giro del Sassolungo e Sassopiatto, rispettivamente 3.181 e 2.969 metri di dolomia pura, nel cuore di uno dei Patrimoni Mondiali dell’UNESCO. In fin dei conti è una piccola Sella Ronda, ma più selvaggia e lontana dalle strade. «Da Monte Pana si sale costantemente e in modo abbastanza regolare fino al Comici, poi l’altro strappo, più breve ma secco, è dopo il Passo Sella» dice Manuela. Al Comici, dove ci fermiamo per una pausa, abbiamo appuntamento con Alex Oberbacher, skialper (ha vinto l’ultima Mountain Attack versione Tour), un titolo di campione del mondo under 23 di vertical e vice-campione nella skyrace oltre che vincitore della prima edizione della Dolomites Saslong. «È più corribile della Mountain Run, c’è subito una salita dura, proprio fino qui al Comici, che fa la prima selezione, poi si corre in quota, su saliscendi dove si può andare veloci e alla fine una discesa a capofitto, ma ormai i giochi sono fatti» dice Alex. Dopo uno spuntino rigenerante riprendiamo il percorso verso il Passo Sella. Attraversiamo la Città dei Sassi, saliamo e svalichiamo per il Friedrich August. Il passo è leggero, gli occhi rivolti verso l’alto. La mulattiera diventa un sentiero, poi single track. La piramide del Sassolungo che vedevamo dal Monte Pana è prima diventata una torre piatta, poi una lunga cresta, poi una cresta interrotta da una forcella. Ogni metro che percorri il panorama cambia. Il bosco e la discesa della Val Scura portano un po’ di refrigerio. E non ti accorgi che sono passate ore, 21 chilometri e 900 metri. Quando si riparte?

RACE TIME
Saltata l’edizione 2020, la prossima Alpe di Siusi Half Marathon è in programma il 4 luglio 2021. L’edizione 2019 è stata vinta da Massimo Farcoz in 1h09’17’’ (su Markus Ploner e Khalid Jbari) e da Tinka Uphoff in 1h23’14’’ (davanti a Petra Pircher e Marion Huber). Info: running.seiseralm.it
La Dolomites Saslong Half Marathon powered by Scarpa è in calendario anche nel 2021 a inizio giugno, il 12. Tutti le iscrizioni del 2020 verranno tenute valide per il 2021. L’edizione 2019 è stata vinta da Stefano Gardener in 1h41’32’’ (davanti a Georg Piazza e Daniele Felicetti) e da Petra Pircher in 2h05’44’’ (su Nicol Guidolin e Manuela Marcolini). Info: saslong.run
NON SOLO GARE
Il Running Park Alpe di Siusi è costituito da 27 tracciati circolari con una lunghezza totale
di 240 chilometri. Otto corrono tra i 1.800 e i 2.300 metri, mentre altri tra i 900 e i 1.100 metri, attorno ai paesi di Castelrotto, Siusi, Fiè allo Sciliar e Tires al Catinaccio. La quota dell’Alpe di Siusi offre le condizioni ideali per mettere alla prova muscoli e abilità e migliorare la resistenza, forse anche per questo qui si allenano maratoneti e squadre nazionali di sci di fondo.
CORSE GOURMET
Sono davvero tanti i rifugi dove la buona cucina è di casa tra le Dolomiti. Ne segnaliamo tre tra i tantissimi degni di citazione. Se vi trovate in vacanza all’Alpe di Siusi, non proprio sul percorso della Half Marathon, ma non lontano, merita una visita la caratteristica Tschötsch Alm (tschoetscherhof.com), in zona Bullaccia. Si mangiano piatti della tradizione a chilometri zero e si beve il vino di produzione interna del maso zu Tschötsch. Vicino al percorso della gara, in zona Icaro, c’è un classico, la Baita Sanon (sanon.it), che offre taglieri e piatti tirolesi nella rustica stube e sulla grande terrazza tra i prati. Alla fine della prima salita della Dolomites Saslong si incontra invece il Rifugio Emilio Comici (rifugiocomici.com), uno dei grandi classici della ristorazione dolomitica. In inverno è il regno del pesce fresco, in estate menù completamente rivoluzionato, con carni, paste, funghi e affettati e grande attenzione a servizio e impiattamento.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 129
Nadir Maguet, il Mago trasformista
È solo di pochi giorni fa la notizia che Nadir Maguet ha abbassato il record di salita e discesa dal Gran Paradiso, che resisteva dal 1995. Siamo andati a trovare Nadir a casa sua giusto qualche giorno prima del lockdown. Ecco cosa ci ha raccontato in quell'occasione.
Lo chiamano test Bertone e, a modo suo, è un metodo infallibile per valutare lo stato di forma e le potenzialità degli atleti. Non è proprio un test scientifico di laboratorio, come per esempio quello di Cooper, ma negli anni ha dato i suoi verdetti. Consiste in un vertical di corsa dalla base della Val Sapin, appena fuori Courmayeur, al rifugio Bertone, sul Mont de la Saxe: 700 metri circa di dislivello. Non una gara ufficiale, ma una tradizione per gli atleti del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur, da ripetere un paio di volte l’anno, cronometrati uno alla volta. E un tempo da battere, quello di Damiano Lenzi, che resiste dal 2012. Fino all’inizio di ottobre del 2019, quando Nadir Maguet ferma il cronometro su 22 minuti e 35 secondi, qualche secondo in meno di Lence e e una ventina davanti a Davide Magnini. Alla vigilia della finale delle Golden Trail Series, il circuito di running outdoor più ambito per le medio-corte distanze, un ottimo riscontro per l’atleta valdostano. E la conferma dell’ultima transizione del Mago, dallo scialpinismo al trail e allo skyrunning, dopo quella dal fondo al biathlon, con un passaggio fugace nel calcio. Nadir parte per il Nepal al secondo posto nella classifica del circuito, dietro a Kilian e davanti a Magnini. Guardacaso tre skialper e – sempre guardacaso – con un vantaggio nel test su uno dei suoi avversari.
Dopo due mesi di alta pressione il cielo si copre velocemente. Mentre tagliamo gli ampi tornanti che portano a Torgnon, nella valle del Cervino, iniziano a scendere i primi fiocchi. Google Maps indica di svoltare a sinistra su una ripida e stretta rampa, fino ad arrivare a un piccolo parcheggio. Forse la neve è la risposta dell’oracolo alla nostra domanda. In effetti siamo saliti fin quassù per chiedere al Mago se dobbiamo considerarlo uno scialpinista o uno skyrunner. Scendiamo dall’auto nel cuore di un grazioso borgo di pietra con i tetti in ardesia, i fiocchi si fanno più consistenti. «Ciao Nadir, siamo al parcheggio, dove dobbiamo venire?». «Nella casa bianca, aspetta che esco sulle scale così mi vedi». Nadir si sbraccia, insieme a lui c’è Buck, un bellissimo esemplare di lupo cecoslovacco. Saliamo le scale, entriamo nell’accogliente pied-à-terre che da qualche mese il Mago condivide con la sua Sharon. Legno in abbondanza e grandi finestroni, con la neve che cade là fuori. Il posto migliore per una chiacchierata sulla fatica, in inverno e in estate.
Nadir, allora, sei uno scialpinista o uno skyrunner? «Me lo chiedono in tanti adesso. Ma, come in tutte le cose, ci sono sempre delle novità. Ho iniziato con lo sci di fondo, poi ho scoperto il biathlon, diventando anche campione italiano Ragazzi. Ho provato, per un anno, pure il calcio e non andavo male: volevano farmi fare un provino per il Torino, ma non mi piaceva l’ambiente. Così grazie a Teto Stradelli, che era mio compagno di scuola e faceva già gare di skialp, ho provato sci e pelli e ho sfidato mio padre nel vertical notturno del paese: se l’avessi battuto mi avrebbe comprato l’attrezzatura, che per quell’occasione mi ero fatto prestare. Inutile dire come è andata e che grazie a Marco Camandona ho iniziato ad allenarmi con lo sci club Corrado Gex. Ricordo ancora quella volta al Trofeo Vetan quando mi ha insegnato i cambi di assetto sull’asfalto, pochi minuti prima del via. Poi dai vertical sono passato alle individual e in estate ho iniziato a fare prove di sola salita per allenarmi, infine la salita ha lasciato posto anche alle skyrace, perché sono molto simili a una gara di scialpinismo. E così siamo arrivati all’estate scorsa quando ho deciso di partecipare alle Golden Trail Series e di fare la mia prima gara di quasi quattro ore, a Chamonix. Un’altra novità».
In ogni sport hai dimostrato il tuo valore, a Fully nel 2016 hai vinto nell’anno in cui c’erano tutti i big, mettendoti dietro due mostri sacri come Zemmer e Kilian, al primo anno delle Golden Trail Series hai collezionato il secondo posto alla Marathon du Mont Blanc e alla Dolomyths di Canazei e la vittoria alla Ring of Steal, presentandoti al secondo posto alle finali, dietro a quel Kilian che hai avuto davanti anche alla skyrace dei Mondiali scozzesi, nel 2018. «Sì e quel test Bertone faceva ben sperare, ero in gran forma. Poi al raduno della nazionale di skialp mi sono preso un virus intestinale che mi ha debilitato. Sono partito per il Nepal già non al top, anche se poi la situazione è migliorata, però in gara ho capito che non era giornata e non riuscivo a tenere il ritmo di Kilian e Davide. Ho cercato almeno di portarla a termine, ma non ce l’ho fatta e mi è tornato quel virus intestinale; peccato, ho chiuso il circuito al quinto posto».

Ai primi due posti sono arrivati due scialpinisti, al quinto tu, che senza quel maledetto virus saresti stato sul podio. Possiamo dire che lo skialp è allenante?
«Non ci avevo pensato, però in effetti se consideri anche quanto è forte Eyda nell’arrampicata o Lence sulla bici potrebbe essere uno spunto interessante, in effetti non saprei, bisognerebbe fare il gioco al contrario e vedere come vanno nello skialp gli atleti top nel trail e nello skyrunning».
Dunque non hai una risposta alla nostra domanda, allora mettiamola così, ti piace di più sciare o correre?
«Lo scialpinismo ha più obblighi perché faccio parte di un corpo militare, nella corsa è tutto ancora da inventare e in parte da scoprire. Il piacere è uguale, ogni sport ha la sua stagione e per come sono io non potrei fare la stessa cosa tutto l’anno. Andare sui ghiacciai in estate? Anche no, come correre in pieno inverno. Conosco le mie potenzialità sugli sci e ho ancora margini, ma credo di averne di più nello skyrunning. Più che altro su dieci gare di scialpinismo quelle dove sto veramente bene sono la metà, nella corsa diciamo otto su dieci. Non so ancora perché, devo lavorarci, forse dipende dall’allenamento, forse dal tipo stesso di movimento. Trovo che il running sia più dinamico, ci sia più leggerezza, mentre i movimenti dello skialp sono più lenti. Prendi per esempio il vertical: è tanto bello e armonioso con le scarpe da corsa quanto lento e goffo con sci e scarponi».
Le skyrace sono simili alle gare individual dello scialpinismo, sia come impostazione che come tempi, alla Marathon du Mont Blanc invece hai corso per la prima volta sulla distanza maratona e sei arrivato pure secondo. Come hai fatto?
«Era tutto nuovo per me, non sapevo come avrei reagito su una gara di quasi quattro ore invece delle abituali due o meno, così ho cercato di tenere un basso profilo, soprattutto nei primi 17 chilometri, quando è molto veloce, facendo un po’ l’elastico sui migliori per mantenere un’andatura abbastanza costante. Poi nella seconda parte, quando inizia la lunga salita finale, ho visto che ne avevo e ho fatto gara con Davide. I programmi erano questi e li ho rispettati».
Chi ti ha consigliato?
«La Marathon, come tutte le gare, l’ho preparata con Stephanie Jimenez, che segue la mia preparazione atletica. Con lei mi trovo molto bene e allena anche il marito, Fulvio Dapit, basta guardare i risultati… Ci siamo conosciuti in aereo andando alla The Rut, negli Stati Uniti, qualche anno fa. Prima mi seguiva un po’ Manni Reichegger ma poi, quando sono entrato anche io nell’Esercito e lui era ancora atleta, ho pensato di rivolgermi a Stephanie. Anche se stiamo lontani ci sentiamo tutti i giorni e ha accesso al mio account Movescount».
Dal Vertical alla maratona, il passo verso le ultra è breve…
«Non mi interessano, almeno per ora, almeno fino a quando avrò due stagioni, magari a fine carriera una UTMB o anche un Tor potrebbero starci, ma è un pensiero molto lontano».
Scialpinismo, trail e skyrunning sono tre mondi molto vicini, con fatica e dislivello al centro: sono più i punti in comune o le differenze?
«Più che in generale tra i tre sport, farei una distinzione tra le Golden Trail Series e il resto, soprattutto su come sono gestite e comunicate. Prendi per esempio la Coppa del Mondo di scialpinismo: si corre con poco pubblico e per gli atleti non c’è visibilità. Alle Golden Trail Series ti intervistano prima e dopo la gara, producono un video per ogni tappa dove fanno vedere i momenti più importanti con la voce dell’atleta a commentare, c’è un live streaming. E poi la formula della finale alla quale partecipano solo i primi dieci, portando anche un accompagnatore, ti fa vivere a stretto contatto con gli altri, fino alla gara c’è un bello spirito, quasi di vacanza, mentre nelle altre occasioni sei sempre solo».
Una risposta che tira un’altra domanda, che piega sta prendendo lo scialpinismo agonistico? Cosa pensi del sogno olimpico?
«Si è puntato tutto su format che siano spendibili per la televisione e lo spettacolo, come le sprint, che ci stanno. Però devono rimanere anche gare tecniche e fuoripista che sono l’essenza dello scialpinismo, invece in Coppa del Mondo ci sono sempre più tratti in pista e percorsi meno tecnici».
C’è qualcuno con cui hai legato di più alle Golden Trail Series e nel mondo dello scialpinismo?
«Alle Golden Trail Series, soprattutto alle finali, un po’ con tutti perché c’era davvero un bello spirito, è stata come una vacanza, un’occasione per condividere l’esperienza, anche con persone come Thibaut Baronian che viene dal mondo del trail e non conoscevo. Poi in gara ognuno ritorna avversario. Nello scialpinismo ho fatto coppia con tanti, ma quello con cui ho più feeling è Kikko Nicolini».
A guardare questa stagione sarebbe stato un bel giro di valzer, da Hermann alla Monterosa Skialp a Aymonod con cui avresti dovuto correre all’Altitoy fino a Eydallin che sarebbe stato il tuo compagno al Tour du Rutor…
«Con Hermann è stata dura e non abbiamo ancora gareggiato (questa intervista l’abbiamo fatta proprio qualche giorno prima della gara, l’unica delle tre che si è svolta, ndr). Mi sa che è l’ultima volta che faccio coppia con lui perché mi ha già subissato di domande (ride). Con Henri Aymonod mi trovo bene, però ogni tanto ci prendiamo in giro perché lui ama parlare e io invece sono abituato ad andare in montagna da solo e sono di poche parole, con Eyda ho uno dei ricordi più belli, il secondo posto al Tour du Rutor che è anche la gara con la quale sono più in sintonia per l’ambiente d’alta montagna e perché ha tante tappe ma non troppo lunghe».
Skyrace e individual sono la versione estiva e invernale di una filosofia simile, però ci sono gare più nervose, con continue salite e discese, magari corte, e altre con poche sezioni, una o due lunghe salite o discese. Quale preferisci?
«Sicuramente quelle regolari, come regolare è il mio ritmo, la gara estiva ideale sarebbe la Aosta Becca di Nona che riprende proprio quest’anno e che purtroppo non riuscirò a fare perché coincide con un’altra gara del mio calendario. Anche nello scialpinismo quando cambio assetto riprendo alla stessa velocità, con un ritmo regolare, guarda invece Magnini e Boscacci: loro uscendo dal cambio guadagnano subito margine e poi si stabilizzano».
Mentre siamo nel garage della casa di famiglia, dove c’è anche la ski room di Nadir, apre un cassetto e tira fuori tutti i pettorali. Ci sono quelli più recenti e i primi, insieme a qualche medaglia. In un angolo è appoggiato anche il trofeo della Transcavallo.
Se dovessi dire due gare estive e due invernali sopra a tutte?
«In inverno dico il terzo posto alla Pierra Menta con Boscacci e il secondo al Tour du Rutor con Eydallin, in estate in effetti ho fatto meno gare, potrei citare la vittoria a Fully e poi forse quella alla Ring of Steal o il secondo posto a Canazei, però mi piaceva molto anche la skyrace dei Mondiali giovanili di skyrunning al Gran Sasso, tecnica e in un bel paesaggio».
I materiali sono importanti, sia in inverno che d’estate, quanto sei maniaco in materia?
«Essendo pigro, sono attento ma non esageratamente. Gli sci me li preparo io quando mi alleno qui a casa, ho in dotazione due La Sportiva Gara Aero World Cup 70 più quello per le sprint e due scarponi Stratos Cube, uno per le gare e uno per gli allenamenti. Come attacco uso ATK, mentre in estate prevalentemente le Kaptiva, anche se per alcune gare più corribili come a Chamonix metto ai piedi le Helios. Non avevo mai riflettuto sull’importanza del peso delle scarpe da trail prima, ma alla fine 50 grammi di differenza su prodotti che ne pesano al massimo 300 sono più rilevanti di 50 grammi in uno scarpone in carbonio».
Non ti viene mai voglia di andare in montagna per il piacere di stare fuori, senza l’assillo dell’allenamento, di fare una bella sciata in compagnia o una passeggiata?
«Faccio scialpinismo per l’insieme del gesto atletico e la discesa non è una parte così importante per me e poi mi piace stare nella natura da solo, quando esco con gli sci o le scarpe da trail riesco davvero a staccare. Però in qualche lungo mi accompagna mio papà o Henri Aymonod. Vorrei andare oltre la competizione fine a se stessa, per questo ho iniziato ad arrampicare con regolarità per migliorare la parte alpinistica perché la prossima estate vorrei fare qualcosa in velocità e in quota, magari un concatenamento di cime. Potrebbe essere il giusto completamento dell’agonismo stesso».
Insomma, non sei uno sciatore, non sei un trail runner, cosa vorresti essere?
«Se fosse per me la guida di caccia».
Mentre finiamo di parlare fuori è già tutto bianco, la neve scende copiosa. L’oracolo continua a lanciare il suo messaggio. Ma forse non c’è una risposta, il Mago è tutto questo insieme, scialpinista, skyrunner, trail runner. Ogni sport che ha praticato ha regalato soddisfazioni, magari le avrebbe regalate anche il calcio. La risposta sta nel suo nome. Nadir in arabo significa prezioso, straordinario. Come chi eccelle in molto.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 129

Cosa resterà di quei formidabili anni ‘90
È di questi giorni la notizia del record di Franco Collé sul Monte Rosa. Il suo non sarà probabilmente l'unico record di skyrunning di un anno senza gare e si inserisce in una storia gloriosa che nasce proprio con il record del 1988 di Valerio Bertoglio sullo stesso itinerario. Su Skialper 129 abbiamo ripercorso l'epopea dello skyrunning in quei favolosi anni '90 e per celebrare l'impresa di Franco ve la riproponiamo.
Nel 1988 Valerio Bertoglio è salito e sceso da Staffal, nella valle di Gressoney, alla vetta del Monte Rosa, in 5h29’33’’. L’anno dopo Marino Giacometti ha coperto il percorso Alagna-Punta Gnifetti andata e ritorno in 6h07’07’’. Valerio, Marino e i primi mountain runner, inconsapevolmente, hanno acceso la scintilla che avrebbe infuocato tutti gli anni ’90 e l’inizio del secolo, ma soprattutto hanno dato vita allo sport di velocità in montagna e, indirettamente, al mondo meno estremo del trail running, che li avrebbe poi fagocitati. Scrive il professor Giulio Sergio Roi, nel 1995 tra i fondatori della FSA (Federation for Sports at Altitude) nell’interessante libro Skyrunning, l’abc di chi corre in quota pubblicato da Correre: «La parola skyrunner è stata introdotta da Marino Giacometti all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, proprio per indicare quello che allora era chiamato mountain runner, che partendo da un paese del fondovalle tentava di raggiungere la vetta di una qualsiasi montagna, situata a una quota maggiore di 2.000 metri, lungo il percorso più breve e nel minor tempo possibile. La quota di 2.000 metri, che indica il limite inferiore della media quota, è stata arbitrariamente scelta come la quota al di sopra della quale gli effetti dell’altitudine cominciano a diventare importanti, poiché comincia a essere evidente la riduzione della massima potenza aerobica che penalizza le prestazioni di lunga durata e può già comparire il mal di montagna».
Tutte le intuizioni hanno bisogno di sognatori e visionari e anche lo skyrunning ha avuto i suoi, a partire da Marino Giacometti, dallo stesso Giulio Sergio Roi e da Enrico Frachey. Il primo è stato atleta e inventore di uno sport al quale ha dato regole e organizzazione attraverso la FSA e poi l’International Skyrunning Federation, il secondo, medico dello sport, ha posto le basi per studi sulle prestazioni in alta quota che ancora oggi fanno discutere. Frachey, amministratore delegato di Fila e grande appassionato di montagna, agli inizi degli anni ’90 aveva capito la potenza comunicativa dello sport di velocità in quota e incoraggiato Giacometti a organizzare la prima gara in altitudine. Perché le due parole chiave di un’epoca forse irripetibile sono proprio quota e velocità e sono alla base di tutta la filosofia fast & light che permea la nostra passione per la montagna. «Lo skyrunner è un atleta che fa della velocità un fattore di sicurezza» dice Giulio Sergio Roi. E lo fa in alto. Tutto il movimento dello skyrunning è un ingranaggio perfetto per lo spettacolo e per studiare la prestazione sportiva in altitudine. Per arrivare a intuirne i limiti estremi.
Il 28 luglio 1991 quattro atleti – Adriano Greco, Marino Giacometti, Angelo Todisco e Sergio Rozzi – partecipano alla prima edizione della salita al Monte Bianco da Courmayeur con ben 52 chilometri di sviluppo, vinta da Adriano Greco in 8h48’25’’. Al Monte Bianco si disputarono tre edizioni consecutive, fino al 1993, e la gara faceva parte del Fila Skyrunner Trophy. Il tempo migliore è quello del 1993 di Adriano Greco (7h06’31’’), poi nel 1994 il maltempo costrinse ad annullare la prova e non se ne fece più niente. Ma era scattata la scintilla. Dal 1992 al 1998 si organizza il Fila Skyrunning Trophy, poi diventato Skymarathon Trophy, Skymarathon Circuit e Skyrunning Circuit. È un’epopea fantastica con regole semplicissime: si parte dal fondovalle e si raggiungono le cime più famose delle Alpi, tutte sopra i 3.000 e molto spesso i 4.000 metri, rientrando a valle nel minor tempo possibile. Nel 1992 si sale sull’Adamello, sul Monte Rosa e sul Monte Bianco e sono 51 in totale gli atleti-alpinisti iscritti. Il Monte Rosa è la gara più longeva, disputata nel 1992 (anche se su percorso modificato causa maltempo), 1993, 1994 e 1996, poi dal 2002 al 2011 rinasce come Monte Rosa Sky Marathon, ma su un percorso diverso. Nel 1995 si inizia a correre anche sul Bretithorn occidentale e nel 1998 Cervinia ospita il primo Campionato Mondiale di Skyrunning che vede al via 46 atleti di 18 Paesi. La Skymarathon, vinta da Bruno Brunod, arriva proprio fin sul Breithorn Occidentale, a 4.165 metri.

L’idea di correre in alta quota esce dai confini alpini e si iniziano a disputare gare in Messico, in Kenya e in Tibet. In America si corre sull’Iztaccihuatl, fino a 5.286 metri. Nel 1996 la prima edizione è stata vinta da Ricardo Meija. Nel 1995 sul Mount Kenia (5.199 metri) si assiste all’avvincente duello tra quelli che saranno due degli indiscussi protagonisti di quegli anni: Fabio Meraldi e Matt Carpenter. La spunta il valtellinese in 5h03’22’’. Meraldi era stato anche protagonista di un episodio che ha dell’incredibile proprio in Messico. La gara del 1996 avrebbe infatti dovuto disputarsi sul vulcano Popocatépetl (5.465 m) ma il percorso fino alla vetta non era accessibile per motivi di sicurezza perché il vulcano era attivo. Fabio e Pep Ollé vollero comunque fare un giro esplorativo in vetta e furono arrestati al rientro perché le guardie del parco avevano visto le loro tracce sulla neve. Il viaggio dello skyrunning oltre i confini dell’Europa ha un significato ben preciso: sempre più in alto. Così si arriva al punto massimo dello studio della prestazione in quota, la Everest Skymarathon, corsa nel 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1998. La prima edizione della Everest Skymarathon raggiunge quota 5.050 metri, mentre le altre si svolgono su anelli con dislivelli inferiori ai 200 metri. La distanza è quella della tradizionale maratona, anche se solo quella del 1998 è stata certificata dall’Association of International Marathons and Distances Races. Quattro gare vengono disputate a quota 4.300 metri, una a 5.200 metri. A parte la prima, con 1.470 metri di dislivello positivo, vinta da Greco e Meraldi, le altre sono state vinte tutte da Matt Carpenter. «Carpenter è stato l’atleta, dal puro punto di vista della corsa, più forte che ho potuto studiare, mentre quando iniziavano le difficoltà, non essendo un vero skyrunner, emergevano altri» dice Sergio Giulio Roi. La miglior prestazione ufficiale su maratona a 4.300 metri è proprio quella di Matt Carpenter nel 1998 con 2h52’57’’, mentre, seppur non certificata, quella a 5.200 metri è sempre dell’americano in 3h22’25’’. Le maratone in quota hanno permesso la realizzazione del Peak Performance Project, un progetto di ricerca scientifica promosso dalla FSA. L’obiettivo era rispondere ad alcune domande: è pericoloso correre in quota? Danneggia cuore e cervello? Qual è il limite della prestazione in alta quota? «Il Peak Performance Project ha portato a numerose pubblicazioni scientifiche e si è scoperto che è possibile correre ininterrottamente per 42 chilometri sopra ai 5.000 metri e in un percorso pianeggiante non innevato è teoricamente possibile utilizzare la corsa come forma di locomozione fino a un’altitudine di 7.000 metri» dice Sergio Giulio Roi. Altre scoperte? Si può correre a 4’/km sopra i 4.000 metri, lo skyrunner sale a circa 1.200/1.500 metri di dislivello ora, anche di più nelle gare corte e scende fino a 3.000 metri/ora, non sono emerse patologie significative legate alla prestazione in quota e negli atleti che hanno corso fino a 5.000 metri non si sono mai riscontrati casi di mal di montagna.
«I dati raccolti sugli skyrunner che hanno partecipato a maratone disputare a livello del mare e in alta quota in Tibet, a 4.300 e 5.200 metri, indicano che in termini di prestazione gli atleti meno veloci sono più penalizzati in quota rispetto ai più veloci. Ad esempio il vincitore della maratona evidenzia a 4.300 metri di quota un peggioramento di velocità del 21 per cento rispetto al record personale a livello del mare, mentre l’ultimo classificato evidenzia un peggioramento di velocità circa doppio, del 42 per cento; queste caratteristiche sono dovute alla diversa capacità di sfruttare un’elevata percentuale della massima potenza aerobica, al diverso costo del lavoro dei muscoli respiratori in quota e solo in parte alle diverse caratteristiche dei terreni» dice Sergio Giulio Roi. Gli anni ’90 volgono al termine, ma non la voglia di exploit in alta quota, che tocca anche altri sport. Nel 1998 nasce lo SkySki du Mont Blanc, che si corre fino al 2002. È un raid di skyrunning, scialpinismo e alpinismo inventato da Romano Cugnetto per promuovere la preparazione sportiva e la velocità in montagna come concetti di sicurezza. Si corre da La Villette, vicino a Courmayeur, fino al Rifugio Torino, poi si mettono gli sci per toccare Col du Rochefort, Flambeau, d’Entrèves, Base de la Vierge, Col du Rognon e si raggiunge l’Aiguille du Midi con tecnica alpinistica. È una gara a squadre e la prima edizione la vincono Ettore Champretavy e Leonardo Follis che coprono i 30 chilometri e 3.500 metri di dislivello in 3h48’30’’. Già nel 1992 si era corsa la Skyraid Adamello che prevedeva bici, skyrunning e alpinismo, ma la massima espressione di questi raid multisport è stata nel 2002, in occasione dell’anno internazionale delle montagne, con l’Alpine Skyraid da Courmayeur a Cortina d’Ampezzo. Le squadre di tre-quattro atleti dovevano percorrere 500 chilometri e 23.000 metri di dislivello (in otto tappe) utilizzando la bici o mountain bike fino a 2.000 metri di quota, fino ai 3.000 in assetto skyrunning e oltre con tecnica alpinistica o scialpinistica. Per la cronaca la vittoria andò al Team Vibram di Stephane Brosse, Bruno e Dennis Brunod, Jean Pellissier in 27h00’40’’ e al Team Fila di Gisella Bendotti, Arianna Follis, Gloriana Pellissier e Alexia Zuberer. La combinata tra skyrunning, sci e bici era diventata di moda già prima e nel 2000 è stata organiz- zata la prima Olimpiade d’alta quota, gli Skygames, sulla scia delle imprese skybike di Giacometti del 1993 al Monte Rosa e del 1997 al Monte Bianco, raggiunto in 23 ore da Genova unendo bici e skyrunning.
Poi piano piano si è scesi di quota, lo skyrunning ha dato origine ad attività meno tecniche e meno d’élite, si è diffuso il trail running e la corsa del cielo è rimasta un sogno per pochi eletti. Ma tutto questo non sarebbe stato possibile grazie ai favolosi anni ’90. Sabato 23 giugno 2018 Franco Collé e William Boffelli hanno chiuso la salita e discesa da Alagna alla Capanna Margherita in 4h39’59’’ in quella che è stata la prima edizione moderna della gloriosa gara del Monte Rosa, rinata a coppie sulla distanza di 35 chilometri e 7.000 metri di dislivello totale. La Monterosa Skymarathon si è disputata anche nel 2019 e, al momento di andare in stampa, è ancora in calendario, ma rinviata a luglio e in data da destinarsi. Il Monterosa segna il ritorno dello skyrunning alle sue origini: sport d’elite, per pochi, oltre i 2.000 metri, che richiede progressione anche con i bastoncini, con tratti attrezzati o l’uso delle mani. E dei gran polmoni. Come quelli che servono alla Dolomyths, al Kima, alla Pikes Peak, al Sentiero 4 Luglio o al Uyn Vertical Courmayeur Mont Blanc. Perché lo skyrunning è sempre stato vivo. E il futuro ha un cuore antico.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 129, SE VUOI ACQUISTARLO CLICCA QUI
SE VUOI RICEVERE COMODAMENTE TUTTI I NUMERI DI SKIALPER A CASA TUA, ABBONATI

Eric delle Montagne
All’inizio di marzo del 2001 una marea umana di uomini senza diritti partiti dal Chiapas entra a Città del Messico dopo avere attraversato 12 stati e percorso oltre 3.000 chilometri. È la grande marcia del subcomandante Marcos «per reclamare infine i diritti degli indios, umiliati per cinque secoli e violentati dal liberismo selvaggio che ha strappato loro l’ultima manciata di mais» come scrive Goffredo Buccini sul Corriere della Sera del 26 febbraio 2001. Le centinaia di migliaia di persone avanzano lentamente, al ritmo della musica sparata a palla da un camion. Su quel camion ci sono i 99 Posse, band napoletana, ed Eric Girardini, venticinquenne di Lentiai, in provincia di Belluno. Festeggia gli anni proprio in quei giorni e fa partedelle oltre duecento tute bianche antiglobalizzazione italiane che assicurano il servizio d’ordine. «Ero l’unico ad avere dei cd e così mi sono ritrovato sul quel camion» dice oggi Eric seduto nella sua casa di Lamon, ai piedi del monte Coppolo, l’ultimo paese veneto prima di accedere alla valle del Primiero. Cosa ci faceva una Guida della Scuola delle Aquile di San Martino nel cuore della marcia zapatista a Città del Messico? La storia è un po’ lunga.
Lentiai, quota 261 metri sul livello del mare, alla fine degli anni Settanta è il paradigma dell’Italia pre-crisi e cambiamento climatico. Dietro casa ci sono le colline, d’inverno fa ancora freddo e la neve, oltre a cadere dal cielo, rimane a terra a lungo. I genitori di Eric gestiscono un piccolo supermercato e lavorano tutto il giorno. Così Eric e suo fratello Manuel stanno con Katia, la baby sitter. «Baby sitter, ma in realtà aveva qualche anno in più di noi ed era maestra dello sci club, in quegli anni si poteva, anche se non aveva il patentino» dice Eric. Le giornate invernali si trasformano in un piccolo paradiso. Il padre la mattina li accompagna in alto, al Pian di Coltura, dove c’era una rudimentale manovia, e loro sciano lì tutto il giorno. Il rientro fuoripista fino all’uscio di casa con gli sci, passando per il Colderù, dove abitava Massimo Braconi. «Massimo è di un’altra generazione, me lo ricordo, ma non ci siamo frequentati, lui era l’unico Maestro di sci con il patentino in paese». C’è anche lo sci club, il Lentiai, che durante le vacanze scolastiche riempie due corriere ogni giorno verso le piste di sci. E tra le case arrivava una gara di scialpinismo, proprio nella piazza centrale. «La neve c’era sempre, la portavano solo sugli ultimi metri, lungo la strada, ricordo che una volta vinse il mio Maestro del club, lo soprannominavamo cinghiale: non era fortissimo in salita, ma vinceva in discesa». Poi arriva la scuola,il liceo classico. Neanche il tempo di diventare maggiorenne e il temperamento ribelle di Eric lo porta lontanoda casa. «Sono scappato e sono andato a vivere con i ragazzi dei centri sociali, per un periodo avevamo due realtà autogestite in una cittadina piccola come Feltre. Dopo quel mese in Messico ho partecipato attivamente al G8 di Genova che è stato una batosta per tutti i movimenti, con una repressione mostruosa; così ho iniziato a riavvicinarmi ai miei genitori che avevano bisogno di aiuto in negozio e a ritornare in montagna per appagare quel bisogno di libertà così insito nella mia indole». L’approccio è abbastanza ribelle, d’altronde al DNA non si può mentire ma, come avviene a quei ragazzi che sbattono poco dopo aver preso la patente, distruggendo l’auto ma uscendone illesi, è proprio il suo trascorso ribelle ad averne fatto una delle Guide più affidabili tra la neve delle Dolomiti.
«Un giorno mi sono presentato in ufficio da Diego Dalla Rosa e gli ho detto che avrei voluto sciare con lui: mi ha risposto di fare il corso del CAI e l’ho fatto, presentandomi con un paio di Rossignol Bandit, tra i primissimi sci larghi: gli istruttori giustamente mi frenavano sempre in discesa!». Dopo le prime discese in solitaria (tra cui una in notturna del Monte Pavione terminata con tre ore di autostop a Imer alle tre di mattina con sci alla mano e scarponi ai piedi perché Arnaldo detto Napoli aveva rotto la coppa dell’olio della Citroen per accompagnarlo su per il Vallon de Aune ed era rimasto bloccato lassù e senza telefono) Diego accoglie Eric nel suo gruppo. Diego Dalla Rosa, classe 1952, da quelle parti (e non solo) è un’istituzione. Va forte sulla roccia e in discesasulla neve. Con Roberto De Bortoli, Aldo Bortolot e Maurizio Manolo Zanolla dà vita alle Formiche Rosse, arrampicatori funamboli contro il sistema. Ma è in discesa che Diego lascia tracce indelebili. Negli anni d’oro dei Valeruz e Vallençant è uno dei precursori del ripido tra le sue montagne, le Vette Feltrine e le Pale di San Martino, sua la prima e unica discesa in sci dalla vertiginosa parete Sud del Sass de Mur. «Diego ha fatto decine di prime discese, ma si sapoco, perché le ha fatte per lui, non per la gloria. Le Formiche Rosse venivano dal movimento studentesco degli anni ‘70, hanno rotto gli schemi dell’alpinismo, facevano parte di quella generazione ribelle dei Berhault ed Edlinger. Anche il nostro modo di andare in montagna era un po’ dissacratorio, almeno a me sembrava così; oltre a Diego ed altri c’era anche Hermann Crepaz, ancora oggi il mio socio preferito per le uscite in montagna, con un curriculum invidiabile di prime discese non ripetute, dalle Pale alle Vette Feltine. Eravamo tra i primi a usare gli sci larghi dalle nostre parti, ci guardavano come degli astronauti». Hermann è anche tra i fondatori del King of Dolomites e il sodalizio con Diego, Eric e gli altri amici ha una marcia in più nello stare insieme. «Siamo sempre stati così, nessuno di noi era un superfenomeno, ma come gruppo ci siamo fatti notare e poi, dopo le gite, nelle feste al bar aumentava l’ego di tutti. È il bello dello sci, quello stare insieme che in cordata non provi, perché ti muovi sempre da solo anche se sei legato a un’altra persona».

Le gite scorrono veloci, le pendenze aumentano, ma scorre anche la vita, con i suoi eventi. Un giorno, durante un’escursione facile di fine stagione, una valanga travolge un compagno di avventura di Eric, Luca, sepolto appena fino allo zaino, ma ucciso dal peso della neve. Qualche tempo dopo tocca a Eric finire sotto la neve. «Ero sulla Marmolada, la neve mi ha trascinato per 700 metri, facendomi fare un salto di 50 metri: sono vivo per miracolo perché due scialpinisti – uno si chiama Salvatore di nome e di fatto, l’altro Ivan, non potrò mai scordarmelo – hanno visto i miei sci affiorare. Da quel giorno mi sono detto che avrei voluto diventare Guida alpina per acquisire maggior consapevolezza nel mio muovermi in montagna». Eric è testardo e quando si mette in testa una cosa la ottiene. Così passa subito il corso Aspiranti e ora quel ragazzo che si è trovato nel cuore della marcia zapatista è una Guida di San Martino.
Raccontato così sembra un romanzo, ma non è stata una passeggiata. «Ho deciso di vendere l’attività di famiglia, anche se me lo sconsigliavano tutti e i primi anni non sono stati facili, ho dovuto spingere, e poi venivo da un paese di collina dove le Guide non sapevano neanche cosa fossero e sono andato in una valle; ancora oggi c’è qualcuno che mi guarda con diffidenza perché sono forestiero, un ‘Talian. D’altronde San Martino di Castrozza e il Primiero hanno una lunga tradizione di isolamento. «La prima strada d’accesso dal Feltrino è stata costruita nel 1875, prima c’erano solo sentieri o mulattiere impervie, perché nel 1500 Feltre è stata distrutta dall’invasione austro-ungarica scesa dal Primiero e volutamente l’accesso alla valle è stato mantenuto così, per frenare eventuali truppe». Però San Martino è anche uno dei posti più incredibili per chi ama lo sci e la montagna. E le Pale, che hanno stregato anche una mente profondamente illuminata comequella di Dino Buzzati, sono montagne uniche al mondo. «Sono stupende per arrampicare e sciare, le amo particolarmente d’inverno anche se per il mio lavoro sono meno redditizie di altre località iper frequentate delle Dolomiti, ma mi piacciono proprio per questo… Amo anche il Lagorai, ma non ha la stessa verticalità che provi nelle Pale, per me la montagna è roccia e neve, soprattutto canali: ho sempre cercato l’estetica e tra le Pale mi sento appagato, mi piace pensare all’estate, quando arranco su quelle pietraie che ora solco veloce. Lo sci è il motivo per cui sono diventato Guida, prima scalavo di più, soprattutto in falesia, ma con il passare degli anni è sempre più dura portare avanti difficoltà se hai poco tempo». Il curriculum di Eric è di tutto rispetto, anche se non è un tipo che ama stare lì a snocciolarti le sue prime, non gli interessa. Forse perché, come Diego Dalla Rosa, lo fa per se stesso. «E poi da noi è difficile nello sci dire se è veramente la prima discesa, anche se sono sicuro che con Hermann e Diego ne abbiamo fatte molte, comunque possiamo dire di avere sciato belle linee con il nuove tra virgolette. Ai Vani Alti c’è forse il canale più estetico, simile all’Holzer, incassato e chiuso, esposto a Nord. Poi ricordo la Cima di Ramezza, sulle Vette Feltrine, la parete Nord del Colbricon italiano. Ah, dimenticavo, la Nord del Piz de Sagron, nelle Vette Feltrine, è stata forse il nostro apice. Probabilmente è una prima, ci sono solo notizie vaghe di una discesa di Mauro Rumez, ma non si sa con precisione se abbia sciato quella parete». C’è un aneddoto che fa capire che cosa rappresentano la salita e la discesa per Eric. Qualche anno fa, quando non era ancora Guida, ha sciato la Nord del Lyskamm con scarponi da discesa noleggiati ad Alagna, penso che il negoziante si ricordi ancora, non ci credeva e quando li ha riportati non ha voluto nulla, diciamo che è stato contento di rivederli. «Vado forte in salita, ho anche fatto qualche garetta dicorsa, però non m’interessa, meglio qualche etto di attrezzatura in più, ma l’obiettivo è la discesa». E va forte anche in discesa…
«Il mio terreno sono i canali, ma sono sempre stato più portato per la velocità che per le curve strette». Logico che anche l’attrezzatura che usa segua questo teorema. «Usavo Black Crows perché ho sciato qualche volta con Bruno Compagnet, da due anni sono passato ad Armada, grazie anche all’aiuto del mitico Macho di Prosport di Vicenza, un negoziante illuminato, uno che ci crede sempre e comunque, che mi ha dato una mano e sostiene diversi rider. Il mio set-up? Ne ho vari: lo sci da tutti i giorni è il Tracer 98, poi ho un 88 per le gite lunghe e la primavera, un ARV116 JJ e lo sci di Tof Henry, Declivity X. Son tutti belli, il 116 è sbananato e divertente nei boschi, il 98 va bene davvero dappertutto, il Declivity perfetto per il ripido ampio, diciamo più sul Monte Bianco o sulla Marmolada che dietro casa». Al piede mette Roxa, attacco Armada Shift o Ski Trab Tr2 e per l’abbigliamento c’è Salewa con cui ha sviluppato diversi progetti tra cui uno short film di 15 minuti sullo sci nelle Pale (youtube – salewaski -mountaineering). L’attrezzatura da sogno deve pur supportarli questi sogni.
«Quest’anno voglio andare in Francia a fare il Chourum des Olympiques, una discesa ripida che si infila in duegrotte, l’anno scorso mi sono preso una bella soddisfazione nel Vallon delle Scandole, di fianco alla Nord dell’Agner, 1.900 metri di discesa ripida ma non estrema, in condizioni super top, in una zona un po’ defilata delle Pale». E il futuro? «Nei primi anni di professione ho fatto molti viaggi e spedizioni, ora, con due figli e un terzo in arrivo, nel tempo che mi rimane in inverno mi obbligo ad andare a sciare con gli amici per riprendermi la mia passione, fuori stagione curo l’orto e i campi con mia moglie Daniela e mia suocera e cerco di rendermi autonomo dal punto di vista energetico». Tutto quello che coltiva, dai prelibati fagioli di Lamon agli ortaggi, basta per quasi un anno grazie al congelatore, la legna che raccoglie nei boschi scalda la casa. «È un impegno, richiede tempo, ma mi sono reso conto che più lavori, più spendi: per andare a lavorare spendi, se guadagni di più ti senti giustificato a spendere, così ti accorgi che rinunciando a qualcosa e dedicando più tempo a te stesso e alla famiglia, la qualità della vita aumenta, anche se non è un equilibrio facile da trovare. E poi lo faccio anche per i miei figli Pietro e Anna, perché si rendano conto dell’importanza della terra e della natura. Se stai in montagna e fai la stessa vita della città non ha senso». Già, la terra, quella stessa terra per la quale gli indios hanno percorso oltre 3.000 chilometri fino a Città del Messico. Tutto torna.

Questo articolo è stato pubblicato su Skialper 128 di febbraio 2020. Info qui












