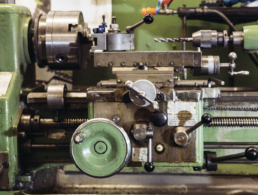Quale futuro per lo sci in un mondo sempre più caldo?
Località sciistiche con offerte ‘estive’ anche in inverno, comprensori più in quota con giro d’affari in crescita: quello che potremmo vedere fra qualche anno. Se ne è parlato allo Ski Industry Global Summit
Il problema non è se le prospettive di innevamento peggioreranno, perché la situazione peggiorerà di sicuro, però possiamo decidere se farla andare peggio o molto peggio. Questo in sintesi il pensiero di Oliver Fritz del WIFO, l’Istituto Austriaco per la Ricerca Economica. E la differenza tra ‘peggio’ e ‘molto peggio’ sta in 2 gradi in più o in meno di aumento delle temperature medie. Se saliranno di 2 gradi, il 53% delle località sciistiche avrà seri problemi di innevamento senza utilizzare quello programmato; se saliranno di 4 gradi la percentuale salirà al 98%. Lo Ski Industry Global Summit, organizzato lo scorso 14 e 15 gennaio a Bolzano, nell’ambito di Prowinter, da Atomic in collaborazione con Protect Our Winters Europe e The Winter Sports Sustainability Network ha permesso di fare il punto sulle prospettive dello sci in un futuro che si preannuncia caldo.
Tra le previsioni di Fritz anche la ’sostituzione temporale’ (vado a sciare quando c’è la neve) e la ‘sostituzione temporale’ (concentrazione dell’offerta in meno comprensori e più in quota). Un fenomeno, quello della ‘sostituzione temporale’, che può essere visto sotto diversi aspetti e potrebbe diventare, più di una vera ’sostituzione’, un adattamento darwiniano. Come nel caso del comprensorio sciistico francese del Grand Massif che ha presentato un business plan per i prossimi 10 anni, con uno sguardo che arriva fino al 2050. L’obiettivo è quello di utilizzare in modo pià consapevole terreni, acque ed energia, ma anche e soprattutto della sopravvivenza e di salvare i posti di lavoro. Il comprensorio prevede lo smantellamento graduale degli impianti sotto i 1.600 metri di quota, con riutilizzo delle strutture (impianti di innevamento compresi) in altre parti del comprensorio, ma anche una migliore gestione dei flussi di persone, per garantire un’offerta che privilegi la qualità e preservi le risorse. Si pensa, per esempio, a un sistema di prenotazione degli skipass e al numero chiuso. C’è anche un lato ‘non siistico’ dell’offerta che prevede non solo periodi di apertura estivi e autunnali ampliati, ma la possibilità di offerte ‘verdi’ anche in pieno inverno, in caso di mancanza di innevamento.
Intanto però lo sci e gli altri sport invernali sono ancora la fetta più importante del turismo alpino e lo confermano i numeri raccolti dalla Federation of European Sporting Goods Industry (FESI) sulla vendita di sci, scarponi e attacchi. Nel 2024/25 (periodo marzo-marzo) sono stati venduti 3.221.827 sci (1.913.468 in Europa), 3.136.048 attacchi (1.830.697 in Europa) e 3.536.883 scarponi (2.146.973 in Europa). I dati comprensono i 26 principali marchi, ma sono esclusi quasi tutti gli specialisti dello scialpinismo. La Francia è il mercato europeo più grande, seguito da Austria, Germania e Italia.
Qualche dato sullo scialpinismo arriva invece dal Nord America. Secondo la SIA (Snowsports Industries America), i pre-ordini all’ingrosso di sci per lo skialp, fatto 100 il valore della stagione 2019/20, nel 2025/26 sono stati pari a 51,7, contro 56,9 del 24/25. Il picco nel 2021/22 (217,8) e nel 22/23 /163). Tra i segmenti considerati (sci alpini flat, sci + attacco, scialpinismo, snowboard, sci di fondo flat, sci fondo + attacco) l’unico in crescita è quello di sci + scarpone alpini, a quota 107,9.
Inseguendo le ombre di Benjamin Védrines
A proposito di Piolets d’Or e del film sul record di velocità al K2
È fuori dubbio che sia l’uomo del momento nel mondo dell’alpinismo moderno, dove moderno sta per progressive, ma anche per poliedrico. Il problema è che trovare una definizione per Benjamin Védrines è difficile: alpinista? Atleta di endurance? Sciatore di ripido? La sua forza è proprio questa versatilità che sembra riunire in una singola persona un po’ di Ueli Steck, un po’ di Kilian Jornet e un po’ di Vivian Bruchez. Una forza che disorienta, se è vero che ha forzato la giuria dei Piolets d’Or a riconoscere una menzione speciale non per una singola impresa ma per tre anni di exploit. Una forza catalizzatrice, che solo i grandi protagonisti hanno. Lo si è visto martedì sera a Lissone dove l’atleta The North Face è stato ospite di DF Sport Specialist per la proiezione del docu-film Chasing Shadows, sul record di velocità al K2 del 2024. Una serata andata subito sold out, nella quale Védrines si è aperto senza reticenze alle domande di Simone Moro e del pubblico.
 Prima della proiezione del film abbiamo avuto l’opportunità di scambiare due battute con Benjamin sulla recente menzione speciale dei Piolets d’Or. Un’anticipazione del lungo e approfondito articolo che pubblicheremo su Skialper di gennaio, un vero e proprio longform in cui scoprirete tutto su Védrines, dai suoi esordi, al team che lo allena e ai dietro le quinte delle sue imprese e della sua vita.
Prima della proiezione del film abbiamo avuto l’opportunità di scambiare due battute con Benjamin sulla recente menzione speciale dei Piolets d’Or. Un’anticipazione del lungo e approfondito articolo che pubblicheremo su Skialper di gennaio, un vero e proprio longform in cui scoprirete tutto su Védrines, dai suoi esordi, al team che lo allena e ai dietro le quinte delle sue imprese e della sua vita.
«È un segnale di apertura mentale - ci ha detto Védrines - sono rimasto molto sorpreso che venga menzionato anche il record di velocità al K2, che non rispetta del tutto i valori dei Piolets d’Or perché ci sono anche le corde fisse. Però penso che il mondo stia cambiando e probabilmente hanno capito che questo tipo di imprese possono allenare anche le altre capacità necessarie per l’alpinismo moderno. All’inizio, a essere onesto, mi sentivo un po’ a disagio per la menzione perché so che l’ambiente è molto sensibile e che qualcuno non sarebbe stato d’accordo con il riconoscimento, ma credo anche che evidenzi la mia versatilità che mi permette di migliorare molto il modo di affrontare altre imprese. Se vuoi provare un ottomila in stile alpino, farlo in stile misto è un ottimo allenamento, dopotutto le vie normali dei quattromila alpini sono sempre state utilizzate come allenamento. Certo, non posso dire che il K2 sia stato un allenamento, è stato un bel risultato dal punto di vista fisico e mentale».
 Chasing Shadows, diretto da David Arnaud e girato da Sébastien Montaz-Rosset, tiene incollati allo schermo per 66 minuti, senza colpi di scena sensazionalistici, ma con uno sguardo privo di filtri e la filosofia della presa diretta che spesso si sono persi nel melting-pot di storytelling moderno. C’è la vita al campo base, ci sono le tende abbandonate e squarciate dal vento ai vari campi in quota, c’è la montagna, c’è il volo in parapendio dalla vetta, ma ci sono soprattutto le persone, a partire da Benjamin, naturalmente. Ci sono molte sequenze girate direttamente da Védrines con la action cam e c’è il fuoriprogramma del salvataggio di Marco Majori caduto in un crepaccio e debilitato, con Benjamin tra i protagonisti proprio dopo aver battuto il record di salita in velocità dal campo base avanzato alla vetta. Majori era presente in sala insieme a Tommaso Lamantia, anche lui protagonista al K2 (ha prestato a Benjamin parte dell’attrezzatura rubata). Ci sono le montagne e le loro ombre nella psiche inquieta di Védrines. La psiche inquieta di molti dei più grandi alpinisti della storia.
Chasing Shadows, diretto da David Arnaud e girato da Sébastien Montaz-Rosset, tiene incollati allo schermo per 66 minuti, senza colpi di scena sensazionalistici, ma con uno sguardo privo di filtri e la filosofia della presa diretta che spesso si sono persi nel melting-pot di storytelling moderno. C’è la vita al campo base, ci sono le tende abbandonate e squarciate dal vento ai vari campi in quota, c’è la montagna, c’è il volo in parapendio dalla vetta, ma ci sono soprattutto le persone, a partire da Benjamin, naturalmente. Ci sono molte sequenze girate direttamente da Védrines con la action cam e c’è il fuoriprogramma del salvataggio di Marco Majori caduto in un crepaccio e debilitato, con Benjamin tra i protagonisti proprio dopo aver battuto il record di salita in velocità dal campo base avanzato alla vetta. Majori era presente in sala insieme a Tommaso Lamantia, anche lui protagonista al K2 (ha prestato a Benjamin parte dell’attrezzatura rubata). Ci sono le montagne e le loro ombre nella psiche inquieta di Védrines. La psiche inquieta di molti dei più grandi alpinisti della storia.
Un film da vedere.
© Sébastien Montaz-Rosset
L’incredibile storia di Urban Zemmer, primo uomo sotto i 30’
Nel 2014 l’altoatesino è stato il primo a scendere sotto la barriera della mezz’ora
Fully, Vallese (Svizzera), sabato 25 ottobre 2014. Cielo coperto, temperatura 11,5 gradi, umidità 76%, vento quasi assente. I dodici rintocchi dei campanili hanno già segnato l’arrivo del mezzogiorno. Lungo il percorso di una vecchia funicolare immersa tra i vigneti e i boschi centinaia di persone si accalcano per fare il tifo. La partenza è a Belle-Usine de Fully, a 500 metri. L’arrivo a Garettes, esattamente mille metri più in alto. Se si potesse tendere un filo in orizzontale sarebbero 1.920 metri. La pendenza media è superiore al 50%. In questo angolo di Vallese c’è il chilometro verticale più corto e ripido del mondo, tanto che è obbligatorio indossare un casco. Senza bastoni è quasi impossibile salire. Si parte uno per volta, prima gli amatori, poi gli atleti élite. Il pettorale numero uno è quello del vincitore dell’anno precedente e parte per ultimo.
Castelrotto, Bolzano, venerdì 24 ottobre 2014. Cinquecentocinquantotto chilometri separano una fattoria sui pascoli ai piedi dell’Alpe di Siusi, da quella vecchia rotaia che corre su dritta per la montagna del Vallese con il sole che trasforma i binari in specchi.
Un’auto parte per la Svizzera. Salgono un uomo e una donna, Urban e Astrid. Lui si è appena tolto la tuta da lavoro. Si è alzato alle sei di mattina, è andato in stalla a controllare i vitelli. Poi si è messo gli abiti dell’idraulico e infine è tornato a casa ed è passato ancora per la stalla. Sopra casa ci sono prati e boschi ripidi, è tutto un vertical, basta decidere dove andare. E capire quanto tempo è rimasto prima che sia buio. Nonostante questo in estate fa qualcosa come 100.000 metri di dislivello tra bici e vertical.

Tra i vigneti di Fully la tensione sale, l’adrenalina dei concorrenti è alle stelle. Arriva il turno del pettorale numero uno. È proprio lui, Urban, contadino e idraulico, per hobby uomo verticale. All’anagrafe la sua nascita è stata registrata nel 1970, 44 anni fa. Ogni cento metri c’è un cartello a indicare il dislivello percorso. Lo sforzo è sovraumano, la fatica impossibile. Ogni metro il tifo si fa più forte. Salire per che cosa? Per fare la fine del toro nell’arena, con il pubblico impazzito come in un baccanale e il cuore a mille? No, 178, i battiti di soglia sono 178. Non perché Urban usi un cardiofrequenzimetro, ma perché alla visita medica per l’abilitazione sportiva il medico si è reso conto di avere tra le mani un motore da fuoriserie. Contano la testa e il cuore, quel cuore che pompa, quella testa che ogni tanto vorrebbe mollare. «Ci sono sempre quei momenti quando pensi che devi calare il ritmo, ma prima o poi vanno via e comunque ci vuole la testa dura, altrimenti non faresti mai questa fatica». Ci vuole un motore che ‘canta’, ma senza la caparbietà di Urban non funzionerebbe così bene. Strategia? «Partire subito a tutta». I minuti passano e ogni istante sembra eterno. Il tempo si ferma, come cristallizzato, tra le urla di incitamento del pubblico. Di prima mattina faceva fresco, ma ora, nel bel mezzo della giornata, fa caldo, forse troppo per una fatica da Ercole.
Si dice che le imprese sportive negli sport di fatica siano favorite dal clima fresco. Quel calore e quell’umidità dell’aria e del tifo riportano invece la lancetta indietro di due anni, a un altro clima, quello dell’estate 2012. Faceva caldo anche allora, a fine giugno. Ma a un certo punto qualcosa è andato storto e improvvisamente Urban non ha più sentito una parte del corpo. Un ictus, o qualcosa di simile. Tanto spavento, un ricovero in ospedale, esami approfonditi. E la paura di non potere salire più veloce. Per uno che ha scoperto l’arena agonistica per caso, un po’ per rinforzare le ginocchia dopo un infortunio, un po’ dopo avere vinto una garetta goliardica organizzata dagli amici tanto per divertirsi, per uno che ha messo le scarpe da mountain running solo a 34 anni, scoprire che a 42 devi fermarti è una doccia gelata. Ma lui non sa stare fermo e non lo ha mai fatto. Ha continuato ad allenarsi dolcemente. E ora è qui su questa salita infinita. Quei momenti, quegli istanti in cui il suo corpo non lo sentiva più, gli passano davanti agli occhi mentre una goccia di sudore cola dal naso. Mancano cento metri.
Cento metri verticali. Eppure le sensazioni non sono buone. Un paio di settimane fa, a Limone sul Garda, il vertical non è andato come sperava. Fa caldo. Le mani spingono a tutta sui bastoni. I passi si fanno un po’ più corti. Anche i suoi. Sì, perché Urban ha una tecnica tutta sua. Nel vertical non esiste, in realtà, una tecnica ‘ortodossa’, però la maggior parte degli atleti fanno passetti corti, altri continuano a corricchiare anche quando la pendenza sale. Lui no, lui non corre e fa i passi lunghi. Li ha fatti anche quando a Canazei è diventato campione del mondo e ha dovuto riacchiappare gli altri big che erano scappati via sul primo pratone dove si corre. Li ha fatti anche quando è diventato campione europeo.
Il tabellone del cronometro sul traguardo si ferma. Tutto si blocca, anche le bocche spalancate del pubblico che incita sembrano immobili, come in un fermo immagine. Il mondo si ferma. 29’42’’741. Per la prima volta un uomo ha percorso mille metri verticali in meno di mezz’ora. Quell’uomo si chiama Urban Zemmer, contadino e idraulico di Castelrotto, non Usain Bolt o Carl Lewis. Non è un atleta professionista, ma un working class hero. Non ha tabelle da seguire e gel nella tasca, ma la sua benzina sono le lasagne cucinate con amore dalla compagna Astrid. Non va al caldo ad allenarsi in inverno, la sua preoccupazione, quandolascia casa per una gara, sono i vitelli: chi li curerà? Mezz’ora vuol dire tutto e niente. È stato calcolato che l’uomo medio passa circa 54 minuti in viaggio per andare a lavorare, impiega 77 minuti per mangiare, trascorre 177 minuti davanti allo schermo dello smartphone e 168 davanti a quello della televisione. Tutti multipli del record di Urban.
«Sono venuto a Fully per vincere, non pensavo al record, in realtà non avevo nemmeno sensazioni così buone, a Limone un paio di settimane fa non è andata come volevo, il clima non era così fresco e poi quando non sai mai quanto tempo hai per allenarti e non puoi fare programmi non puoi neppure programmare un record» dice Urban. Sapeva che poteva andare sotto i 30 minuti, voleva andare sotto i trenta minuti, ma solo Dio può decidere quando.
(Il testo è tratto da La Sportiva 90, monografia realizzata da Mulatero Editore per il novantesimo anniversario del marchio)

© La Sportiva 90 - Mulatero Editore
Il fine settimana più caldo del trail running
L’ultimo week end di giugno è sempre molto affollato nel calendario del trail running. In Europa ci sono le gare della Laveredo Ultra Trail e quelle della Marathon du Mont Blanc, a Chamonix, mentre in Nord America va in scena la Western States Endurance Run. Negli ultimi anni è stato un fine settimana caldo sotto tutti i punti di vista, anche quello meteo, e il 2025 non è stato da meno. Quello che rimarrà però è soprattutto il ricordo di gare tra le più belle gare degli ultimi anni, con alcuni record di percorso infranti.
LA SPORTIVA LAVAREDO ULTRA TRAIL BY UTMB: FRECCIA DHIMAN
A Cortina il trono è tutto stars & stripes, con Ben Dhiman e Courtney Dauwalter in copertina. Lo statunitense classe 1992 vince polverizzando il record di percorso di Hannes Namberger di quasi otto minuti. Dopo la vittoria al Gan Raid Ventoux by UTMB, il secondo posto all’Asics SaintéLyon e il terzo alla Diagonale des Fous e la vittoria al MIUT 2024 il runner del team Asics Fuji Trail non può più nascondersi: è uno degli uomini da battere. La regina incontrastata dell’ultra trail, per la prima volta in gara in Italia - se si esclude il tratto italiano dell’UTMB - aggiunge la prova dolomitica, sempre più accreditata nel Grande Slam con le scarpe da corsa, al suo prezioso palmarès. Il caldo impedisce alla statunitense del team Salomon di portare a casa il record della gara, ma poco importa: Courtney rimane la più grande di sempre, anche per la simpatia che sa sucitare nel pubblico. Sul podio della 120k maschile anche Andreas Reiterer, del team La Sportiva, che riuesce a portare a termine la gara dopo anni di sofferenza a Cortina (che non è mancata neppure questa volta). Nelle gare più corte, da segnalare l’exploit della sudafricana Toni McCann nella 50k, che abbassa il record di nove ninuti. Tra gli uomini Francesco Puppi conferma di essere tra i grandi, sfiorando per soli 15 secondi il record, seguito, in un podio tutto italiano, da Luca Del Pero e Alex Oberbacher, che chiude in bellezza la sua prima 50k.
Guarda tutte le classifiche qui


MARATHON DU MONT BLANC: IL RITORNO DI DAVIDE
Dopo la vittoria nel 2019 e due anni difficili, tormentato dalla condizione fisica, un grande Davide Magnini trona a vincere in una delle classicissime, la 42 Km della Morathon du Mont Blanc. E lo fa a modo suo, recuperando 4 minuti di ritardo accumulati nella prima parte, veloce e corribile, e nella discesa su Vallorcine. «È stata davvero dura fin dall'inizio. Le gambe erano doloranti, il primo tratto era troppo veloce per me e la discesa verso Vallorcine è stata un incubo. Ero molto indietro, ma sono riuscito a rimontare. Ho rispettato il mio ritmo, ascoltando il mio corpo. Durante la salita verso La Flégère, ho iniziato a ridurre il distacco. Non ho potuto nemmeno fermarmi a bere, ma ho trovato la forza di scendere bene. Mi sono slogato una caviglia, ma rinunciare a 3 km dall'arrivo era fuori discussione. Ho tagliato il traguardo completamente vuoto, ma felicissimo». Ad aspettarlo a Chamonix Théo Detienne, altro atleta New Balance, come Davide e la vincitrice della 42k femminile, Joyline Chepngeno.
Guarda tutte le classifiche qui

WESTERN STATES: ETERNO KILIAN
La vittoria è andata allo statunitense Caleb Olson. E che vittoria, con un tempo veloce, due minuti sotto il record di Jim Walsley. Però la copertina è per Kilian Jornet che a 37 anni centra il terzo posto dietro Chris Myers. Tra le donne successo della statunitense Abby Hall sulla cinese Fuzhao Xiang e sulla canadese Marianne Hogan. La gara simbolo dell’ultra-running, con i suoi 369 pettorali, il mitico guado del fiume con la fune e il caldo torrido si è dimostrata particolarmente dura anche quest’anno.
Guarda tutte le classifiche qui
Azione di richiamo per gli airbag Litric di Ortovox
Ortovox segnala che è stata riscontrato un problema tecnico che in rari casi potrebbe compromettere il gonfiaggio dei palloni dei nuovi airbag elettrici LITRIC e ha sottoposto il nuovo prodotto a un'azione di richiamo. Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale dell'azienda.
Circa quattro anni fa, i marchi Ortovox e Arc’teryx hanno unito le proprie forze con l'obiettivo di sviluppare un sistema elettronico di airbag da valanga che definisse un nuovo standard. Il risultato è stato il sistema LiTRIC.
Ora i team hanno riscontrato un problema tecnico: in rari casi, questo problema potrebbe compromettere l'unità di gonfiaggio dell'airbag, riducendo così la protezione. Il sistema LiTRIC in sé non presenta alcun pericolo.
Per questo motivo, ORTOVOX ha deciso di richiamare volontariamente tutti i modelli ORTOVOX AVABAG LiTRIC (AVABAG LiTRIC TOUR, AVABAG LiTRIC FREERIDE, AVABAG LiTRIC ZERO), compresi i modelli zip-on.*
Il nostro processo di sviluppo include test rigorosi che non solo soddisfano gli standard del settore, ma spesso li superano se tecnicamente possibile. Lavorando a stretto contatto con i team di sviluppo, ci prenderemo tutto il tempo necessario per garantire che la tecnologia LiTRICTM soddisfi gli elevati standard di qualità e performance per cui sono noti Arc'teryx e ORTOVOX. Entrambi i marchi interrompono quindi le vendite di tutti i prodotti con tecnologia LiTRICTM per la stagione 22/23 e puntano a riprendere le vendite per la stagione 23/24.
I modelli Avabag LiTRIC acquistati presso un rivenditore specializzato possono essere restituiti direttamente in loco. I/le clienti che hanno acquistato Avabag LiTRIC tramite l'online shop di ORTOVOX verranno contattati direttamente.
Tutte le informazioni sul richiamo volontario e sulla restituzione dei prodotti sono consultabili sul sito web di ORTOVOX a questo link. È possibile contattare il team di assistenza ORTOVOX tramite il portale di assistenza (oggetto: richiamo volontario LiTRIC).
Tempo di Sunset 18k
Appuntamento per un trail nei colori cangianti dell’autunno sabato e domenica prossimi. L’Hoka Ultra Trail del Lago Maggiore, organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D. prevede quattro distanze WILD 81K/5.100 D+, BRAVE 52K/3.100 D+, SCENIC 37K/2.100 D+ e SUNSET 18K/700 D+ per permettere a tutti, in base al proprio livello di capacità tecnica, di vivere una giornata di sport.
Sunset 18k è adatta a tutti, anche in versione camminata non competitiva,proprio per permettere la partecipazione anche a chi non in possesso di certificato medico agonistico e non tesserato per un ente podistico. Partenza alle 16.30 da Cannero Riviera, comune celebre per il suo Parco degli Agrumi, per andare alla scoperta dei borghi affacciati sul Lago Maggiore verso Oggebbio, dove una breve salita dalla località di Novaglio porta gli atleti verso un sito UNESCO, il Sacro Monte della Santissima Trinità di Ghiffa, iscritto come patrimonio dell’umanità per la sua ricchezza in termini naturalistici, culturali ed archeologici. Da qui mancheranno gli ultimi chilometri per raggiungere Verbania nel tempo massimo di 4.5 ore. Per tutti t-shirt tecnica gara e medaglia finisher, da conservare in ricordo di una giornata dedicata ad un territorio speciale, ricco di offerte naturalistiche e culturali e che merita di essere conosciuto ed apprezzato.
Ci si può iscrivere a questo link
Westenberger sbaraglia la concorrenza all’Adamello Ultra Trail
È stata una gara aperta la 170 km dell’Adamello Ultra Trail-AUT, ma alla fine Alexander Marcel Westenberger si è aggiudicato il titolo più ambito. Il tedesco di Neubiberg ha concluso la prova nella mattinata di sabato 24 settembre, in 26 ore, 23 minuti e 57 secondi, grazie a una poderosa rimonta nella seconda parte di gara che gli ha permesso di superare prima e staccare poi i nomi più quotati alla vigilia. Sui camminamenti della Grande Guerra, Westenberger ha preceduto il piemontese Giulio Ornati (27:29:35) e Luca Manfredi Negri (28:46:11).
Per il giovane atleta bavarese classe 1995 si tratta di una prima volta sull’ultra distanza, dopo grandi risultati su percorsi più brevi negli ultimi anni. Tra il 2021 e il 2022, Westenberger ha trionfato in tutte le gare alle quali ha preso parte: dai 65 km della Ultratrail Fränkische Schweiz ai 110 km della Grossglocken ULTRA-Trail. La gara è stata incerta per oltre metà percorso, e solo nella seconda parte il tedesco è stato in grado di ingranare la sesta e sbaragliare l’agguerrita concorrenza. Pronti via e un duo ha preso subito il largo: in testa Manfredi Negri, seguito in scia da Daniele Nava, mentre più staccati Giulio Ornati, Pierre Augrit e lo stesso Alexander Westenberger. Il francese Augrit ha provato a forzare nel tardo pomeriggio, ma ha pagato dazio la notte e ha dovuto ritirarsi poco dopo il km 100. Ornati si è trovato quindi in un’ottima posizione per tentare il colpo grosso, ma verso il km 120 Westenberger ha scombinato i piani e preso definitivamente il largo. Il tedesco è giunto al traguardo poco prima di mezzogiorno, oltre un’ora prima dello stesso Ornati e con quasi due ore e mezza su Manfredi Negri, che ha chiuso il podio.
«Sono davvero contento - ha esordito il vincitore sul traguardo di Vezza d’Oglio - all’approssimarsi della metà gara mi sono accorto di avere ancora buone energie e di andare molto veloce. I panorami sono fantastici e ieri abbiamo avuto una giornata magnifica per goderceli: la gara è bellissima e difficile, bisogna sempre stare concentrati».
Il primo a tagliare il traguardo venerdì nella 90 km era stato ancora una volta Walter Manser: l’elvetico, già vincitore della distanza intermedia nel 2021, si è confermato il più veloce abbassando ulteriormente il proprio record di oltre dieci minuti. 11:39:32 il tempo finale dello svizzero, che ha preceduto sotto l’arco di Vezza d’Oglio il genovese Alberto Canessa (12:55:29) e il piemontese Michael Dola (12:59:11).Gara senza storia quella che ha aperto le danze dell’Adamello Ultra Trail: Manser si è infatti ritrovato in testa alla corsa da solo dopo 2 km e non si è più voltato indietro. Il divario ha continuato ad allargarsi fino ad arrivare all’ora abbondante sul finale, dove Canessa ha avuto la meglio di Dola.
Nella 90 km femminile è stata invece Francesca Crippa da Olginate ad imporsi con 15:31:04, dopo una trama simile a quella della 170 km maschile. La venticinquenne è infatti partita a marce ridotte, per poi accelerare nella seconda metà di gara e superare sul traguardo Martina Tognin (16:18:06) e l’atleta bresciana Patrizia Passeri (16:53:33), al secondo bronzo consecutivo nella 90 km di Adamello Ultra Trail.
«Sono incredula, vincere qui è veramente fantastico - ha commentato Crippa a fine gara - I posti sono bellissimi, i volontari super e la gara decisamente tosta. Come mia abitudine sono partita piano e ho accelerato nella seconda metà di gara: l’aver provato il percorso quest’estate mi ha aiutato molto. Dedico questa vittoria a me stessa e al lavoro che ho fatto per arrivare fin qui».
L’ultima categoria a sancire il proprio podio è stata la 170 km femminile, con Alessandra Olivi giunta per prima al traguardo nella serata di sabato 24 settembre in 34:59:36 nonostante un paio di escursioni fuori percorso dovute alla fittissima nebbia. Alle sue spalle, nella notte, la seconda piazza è andata a Melissa Paganelli in 37:09:51, mentre l’ultimo gradino del podio è stato conquistato dalla britannica Zoe Salt in 40:01:22.

Chi sopravviverà all’UTMB?
Inutile girarci intorno, ogni anno la cento miglia del Monte Bianco è LA gara, un campionato del mondo dell’ultra trail non dichiarato. Perché qui si sfidano tutti i migliori, infortuni e Covid permettendo. E il pronostico è sempre difficilissimo. Le sorprese non sono mai mancate. Solo nell’ultimo decennio, come dimenticare l’edizione 2013, con la vittoria di Thévenard e il settimo posto assoluto della vincitrice femminile, Rory Bosio, oppure la vittoria di Francesca Canepa nel 2018, quando la davano tutti per finita ad alto livello e quella di Ludovic Pommeret del 2016? Non è proprio una sorpresa, ma anche la vittoria di D’Haene del 2017 su Kilian non era così facilmente pronosticatile. E poi tutti gli statunitensi che hanno fatto flop nonostante i favori del pronostico, mentre le donne stars & stripes hanno scritto la storia, a partire dalla Dauwalter, vincitrice delle ultime due edizioni?
Chamonix è Chamonix, il Monte Bianco il Monte Bianco e il pathos che si respira questa settimana altissimo. Non solo in quell’incredibile mass start nella quale l’adrenalina sale a mille, anche per i runner più esperti o in quei primi chilometri molto corribili, velocissimi, spesso sotto il sole cocente, che hanno ammazzato più di un favorito. È tutto il contorno, l’atmosfera, l’attesa che sono capaci di uccidere chi non ha il pelo sullo stomaco. E poi c’è la lunga notte, ci sono la strategia e la tattica. Così, anche nel 2022, un pronostico è un indovinello su chi non salterà o non scoppierà come in un remake di Dieci Piccoli Indiani con le scarpe da trail. Di sicuro sarà meglio aspettare la seconda parte di gara, da Courmayeur, per iniziare a tifare seriamente, perché molto spesso giochi per la vittoria ha iniziato a prendere forma qui, tra il palasport della località valdostana e Champex.
Uomini
I favoriti assoluti, e non potrebbe essere diversamente, sarebbero loro: Kilian Jornet e Jim Walmsley. Il condizionale riguarda Kilian, che ritorna all’UTMB dopo le tre vittorie da enfant prodige tra il 2008 e il 2011, ma nel 2017 è stato battuto da D’Haene (che non sarà presente, ma all'ultima Hard Rock 100 la sfida l'ha vinta Kilian) e nel 2018 non è arrivato al traguardo. E l'UTMB ultimamente non sembra portargli fortuna visto che ieri sera sul suo account Instagram ha rivelato di essere risultato positivo al Covid, seppur asintomatico. «Tre giorni prima della Sierre-Zinal - ha scritto - ho visto che i valori della variabilità della frequenza cardiaca scendevano e che le pulsazioni a riposo salivano di circa 10 al minuto. Visto che ero un contatto stretto con un positivo (la compagna Emelie Forsberg, n.d.r.), ho iniziato a fare test, ma ero negativo e in grado di gareggiare, non al 100 per cento, ma quasi. Successivamente il test è risultato positivo, sempre asintomatico. Mi sento pronto e ben preparato per la gara e non ho sintomi, ma parlerò con il mio medico per prendere la migliore decisione per la mia salute e per gli altri runner». Il talento non manca, le motivazioni, da quando si è inventato un nuovo marchio di scarpe (Nnormal, proprio in questi giorni viene presentata la prima scarpa, la Kjerag, un modello leggerissimo, da 200 grammi) anche, ma, la vicenda Covid mette più di nuvola nera sulla sua (eventuale) gara. Lo sfidante numero uno è lo statunitense Jim Walmsley, fortissimo, eppure a Chamonix sempre nei guai (solo un quinto posto nel 2017, non arrivato nel 2018 e 2021). Corre veloce Jim (lo dimostrano le vittorie alla Western States, cento miglia fast), ma nel 2022 ha già vinto la MIUT, più simile per caratteristiche all’UTMB, anche se più corta e dalla primavera si è trasferito nel Beaufortain, dove i ben informati dicono che abbia corso anche con D’Haene. Sfida bellissima, indecifrabile. Diremmo più Kilian che Jim senza la variante Covid, ma ci vorrebbe la cabala e, se Kilian sarà al via, il pronostico a questo punto si inverte. Dietro ci sono lo spagnolo Pau Capell, vincitore nel 2019, poi tormentato da una noia al ginocchio. Alla LUT è saltato, molto dipenderà dallo stato di forma. Occhi puntati soprattutto sul francese Aurélien Dunand-Pallaz, secondo l’anno scorso, che potrebbe essere il terzo incomodo e anche sul tedesco Hannes Namberger, sesto l’anno scorso e vincitore della LUT. L’UTMB 2021 è stata la sua prima cento miglia e Hannes ha ora l’esperienza, la forma e il controllo della situazione dei grandi, attenzione… E poi, altri nomi da monitorare, almeno per un risultato top, Mathieu Blanchard, Pablo Villa, Thibaut Garrivier, Scotty Hawker, Tom Evans, Germain Grangier, Benoit Girondel, Hajnal. Ma le sorprese non mancheranno.
Donne
Nella gara femminile, vista l’assenza della regina delle ultime due edizioni, Courtney Dauwalter, i giochi sono più aperti. La svedese Mimmi Kotka è quella con il miglior piazzamento dell’anno scorso (terza). Il 2022 per lei è partito bene, con la vittoria della LUT ed è stata avvistata stabilmente sui sentieri di Chamonix. Il podio dovrebbe giocarselo con la spagnola Ragna Debats, le francesi Audrey Tanguy e Manon Bohard, la spagnola Azara Garcia. Occhio anche a Katie Schide, Emily Hangwood, Hillary Allen, Fu-Zhao Xiang.
Sulla carta i pronostici sono questi, ma la carta spesso è diventata straccia, non solo perché macerata dalla pioggia, che potrebbe arrivare sotto forma di temporali nella notte di venerdì e sabato, secondo le prime tendenze meteo, ma anche perché scolorita dal sole cocente. Però nei prossimi giorni le temperature potrebbero essere meno torride che in alcune edizioni passate, più in linea con le medie stagionali, in ogni caso non fredde. E poi, senza suspence, che UTMB sarebbe?
Veloce ma non troppo
Il peso è un limite, la sicurezza no dice Manuel Aumann, Operations and R&D Director Bindings, mentre a pochi metri di distanza, nella stessa stanza, uno strano apparecchio emette una luce verde. A intervalli regolari nel macchinario entrano piccoli pezzi metallici che vengono misurati: se le dimensioni sono corrette, la luce è verde, ma se sono sbagliate, diventa rossa. Di quei pezzi, stivati ordinatamente in scaffalature come quelle dei ferramenta, sempre nella stessa stanza, ce ne sono circa mille. Mille parti diverse, mille forme e 25 materiali. Ognuno viene inventariato per controllare la qualità quando arrivano le nuove commesse dai 40 fornitori, dei quali 25 nel raggio di pochi chilometri. Venticinque chilometri da dove? Da Aschheim, 6.879 abitanti, nell’ordinato hinterland di Monaco di Baviera.
Di fatto in questo tranquillo sobborgo, tra villette con giardino e qualche capannone, c’è la capitale dell’attacchino. Perché qui c’è il quartier generale di Dynafit e il reparto ricerca e sviluppo del famoso attacchino inventato da Fritz Barthel e prodotto da sempre dal marchio del leopardo delle nevi. Insieme a Manuel nei tre stanzoni del reparto che si occupa di R&D, qualità e logistica ci sono una ventina di persone. Nel locale della macchina che emette luce verde o rossa ci sono altri macchinari. Qui vengono fatti i controlli di qualità. C’è anche un apparecchio identico a quello utilizzato dal TÜV per i test sui valori di sgancio. Lì dentro passa un prodotto finito ogni cento, anche quelli non certificati. «Mettiamo l’incolumità al primo posto e riteniamo che non si possa scendere sotto un certo peso, se serve per garantire sicurezza, non accettiamo compromessi» dice Manuel mentre il rumore dei macchinari crea una sinfonia di sottofondo. Garantire è un altro dei verbi che sentiamo ripetere spesso. Perché gli attacchi Dynafit sono garantiti a vita. E anche questo si traduce in un severo lavoro di progettazione e di test. Per capirlo facciamo rimpiattino tra la prima stanza e il grande locale accanto a quello dove ci troviamo. Appena entrati in reparto, dietro a una porta a vetri, c’è un piccolo ambiente con diversi macchinari. Uno apre e chiude incessantemente un attacchino. Milioni di step in e out. Ma ci si può sbizzarrire con il test degli impatti laterali e c’è anche un ice box, che non è altro che una cella refrigerata dove vengono eseguiti gli stessi test. I valori di quello di impatto laterale a meno venti, quando tutto è più rigido, hanno una rilevanza maggiore, come quelli sulle vibrazioni di pre-release. E cosa succede quando si salta? L’effetto viene simulato con il test delle forze verticali. In totale sono una dozzina le prove effettuate in questo sancta sanctorum prima di andare sulla neve. Con diversi fori per i pin «perché ci sono cinque produttori e 0,2 millimetri possono fare la differenza» aggiunge Manuel.

Il motto di Dynafit è speed up. Nel DNA del marchio c’è la velocità, lo sguardo verso il futuro e l’innovazione, ma lo sviluppo di un attacco è un processo lungo. Mediamente tre-quattro anni dal primo white paper, dalle informazioni raccolte attraverso il dialogo con i consumatori, per capire le esigenze del mercato. Ma ad Aschheim sono abituati a guardare oltre e stanno già ragionando su cosa succederà fra cinque anni. Lavorano a gruppi di cinque persone su ogni singolo progetto. «Siamo orgogliosi di avere progettato il Radical, l’attacco a norma TÜV per i valori di sgancio, riteniamo di essere nella parte alta dell’asticella, per questo per qualche anno abbiamo rilasciato prevalentemente aggiornamenti dei prodotti esistenti, mentre ora stanno per arrivare diversi attacchi nuovi» dice sorridendo Manuel. Dall’idea alla produzione ci vuole del tempo, ma tutto è ottimizzato per essere veloci. Lo capiamo mentre varchiamo la porta dell’ultimo grande locale.

Lo schermo del computer sputa disegni 3D del puntale di un attacco. Con il mouse l’operatore ruota l’immagine per cambiare la visuale. Sembra un gioco, invece è il cuore del sistema. La parola magica è software di analisi agli elementi finiti. Permette di calcolare con precisione le forze in gioco e i punti di maggiore stress e di rottura. «In una notte possiamo fare una ventina di simulazioni, che equivalgono anche a un paio di settimane di test con i macchinari». Ai macchinari, quelli dei famosi 12 test, ci si arriva dopo, ma se si è lavorato bene con il software, difficilmente verranno rilevate anomalie. E così poi si va sulla neve. Di solito una ventina di persone, atleti, ma anche semplici appassionati, dei quali fanno parte anche alcuni dei venti addetti che lavorano nel reparto. Perché un’altra delle parole chiave in Dynafit è obsessed, ossessionati, ovvero appassionati. «Non è sempre facile trovare le figure professionali per il reparto R&D di Aschheim, perché non cerchiamo solo ingegneri, ma anche sciatori e amanti del dislivello» conferma Manuel. Il test sulla neve è la parte più delicata del risiko perché nessuna macchina misura le emozioni. Così i prototipi fanno avanti e indietro dalle montagne ad Aschheim. La velocità di reazione sta nella vicinanza alla neve, ma anche nella capacità di modificare, evolvere. Il reparto prototipazione è in grado di produrre singoli pezzi in poche ore e un attacco completo in un paio di giorni. Si lavora non solo sull’affidabilità e la risposta alle sollecitazioni meccaniche, ma anche sull’usabilità dei prodotti. Grazie alle stampanti 3D vengono realizzati fino a 20 tipi diversi di leve prima di arrivare in produzione. Una sfida ancora più ambiziosa ora che le materie prime scarseggiano a causa della pandemia e la mancanza di una minuscola vite può ritardare la produzione di un attacco o la progettazione di un componente. «Siamo sempre alla ricerca di nuovi materiali e fornitori, ma è difficile cambiare perché le parti di un attacco devono resistere alle sollecitazioni meccaniche e a condizioni atmosferiche proibitive». Come dire che il libro degli ingredienti è ben definito.
E allora la sfida si sposta in un alto campo. «Dobbiamo semplificare, ridurre il numero di attacchi, che può disorientare lo scialpinista, e allo stesso tempo rendere ogni prodotto il più specifico possibile». Ecco la vera sfida per il futuro, per certi versi piccola rispetto a quella titanica di Fritz Barthel che ha immaginato due pin per farci risalire e sciare leggeri. Una sfida che non verrà più affrontata ad Aschheim, ma a Kiefersfelden, al confine tra Germania e Austria. Ancora più vicino alle montagne. Lì sorgerà il nuovo headquarter di Dynafit. Sapendo come è venuto quello di Oberalp, la holding bolzanina che controlla il marchio, c’è da giurare che sarà un bel parco giochi. Magari anche più bello di quello di Bolzano. Ecco, un’altra sfida... +

Winter Home
Gennaio 2021. Non è poi così freddo: meno dieci. È una notte più mite rispetto alle punte di meno venticinque che hanno graffiato la pelle arsa dal sole e dal vento dei loro volti. Il tempo è passato veloce, come gli altri giorni: pellata, sciata, ripellata, altra sciata. E poi a prendere l’acqua che, inspiegabilmente, scorre sotto la neve, anche a meno venti, per scaldare, lentamente, a bagno maria, la bombola, che così riesce a sprigionare tutta la sua potenza per cucinare sull’altro fuoco del fornello. Un po’ di zuppa e i kaminwurzen, i salamini affumicati, da sgranocchiare con flemma, come un sigaro davanti al camino. Una serata avvolti nel sacco a pelo a ricordare le curve più belle e poi d’improvviso quella nebbia che ti avvolge e ti trasporta nel sonno più profondo dopo una giornata nella quale hai dato tutto. Aaron e Matthias chiudono le lampo dei loro sacchiapelo, testati fino a temperature polari. Dentro però, se non metti prima qualcosa di caldo, si incunea il freddo, e non c’è altra soluzione per scaldarli se non quella di usare il calore del proprio corpo. Oppure di infilarci prima qualcosa di rovente, come la boule dell’acqua calda che Aaaron ha rubato a suo figlio o la borraccia tonda, a fiaschetta, di alluminio, che Matthias usava quando era bambino, di quelle che potevi ricoprire anche con la custodia di loden. I sogni si susseguono veloci, uno dietro l’altro, nella mente di Aaron. Poi il sole, appena sorto, buca prepotentemente la porta della tenda. Uno sbadiglio, la mano fuori dal saccoapelo. Per terra c’è uno spesso strato di ghiaccio. «Cosa è successo, è caduta dell’acqua?» chiede a Matthias con la voce ancora rauca.
«Questa notte si è rotto il camelbag che avevo con me dentro il sacco a pelo» risponde impassibile Matthias. Quella sacca idrica che di giorno mette nello zaino e che la notte tiene nel sacco per mantenere l’acqua a una temperatura accettabile e bere di tanto in tanto, ha ceduto. Tutta la notte a rimanere immobile e fradicio. Con il dubbio di alzarsi e scendere a valle. Ore interminabili che tra le parole di un racconto scorrono come un lampo dagli accenti comici, ma che dal vivo assumono l’aspetto della tragedia.

Flashback. Aprile 2020. Sotto il piumino, con le guance affondate in un morbido guanciale e la schiena che poggia su uno spesso materasso, la sensazione è molto diversa da quella di qualche centimetro di materassino pieno d’aria, di un saccoapelo e di un cuscino gonfiabile. Eppure è bello sentire l’aria fredda sul viso, vedere il sole sorgere dalla porta della tenda, sciogliere la neve con il fornelletto per fare colazione. E poi mettere le pelli fuori dall’uscio e partire alla scoperta di linee infinite. Aaron è nel dormiveglia, ha ancora negli occhi le emozioni dell’ultima uscita. Partenza quando in valle era buio, un po’ di portage, poi su con le pelli.
E infine una notte in tenda, per sfruttare al massimo quella libertà così preziosa nel cuore di una pandemia. Non è una fuga dalla legge, perché questo è il lavoro di Aaron, ma c’è quell’adrenalina che solo la trasgressione ti sa dare. Quella stessa adrenalina che gli saliva nelle vene quando, da ragazzino, si allenava a Merano 2000 e guardava su verso le creste dell’Ivigna, dove lo zio Renato Reali aveva conosciuto Heini Holzer, che poi quella parete l’ha sciata, e sognava di mettere le sue lamine in quel groviglio di roccia e neve. Con gli occhi già chiusi ma la mente ancora connessa, Aaron inizia a pensare all’inverno 2021. Non si sa se si potrà viaggiare, è ancora tutto incerto. Lassù, proprio sopra casa, appena sopra il brusio di Merano, sembra di essere in Patagonia. Il contrasto tra giù e su è quello tra il mondo sviluppato e quello selvaggio, nel raggio di pochi chilometri. O di un volo in parapendio. Sarebbe bello ricreare le sensazioni delle spedizioni negli angoli più remoti a due passi dal proprio giaciglio e dalla propria famiglia.

Novembre 2021. Hanno pedalato un po’. Giusto un po’, perché la neve è scesa fino in basso. Così con le e-bike sono riusciti a salire appena qualche tornante, diciamo dai 300 metri di Merano fino a quota 600. C’è il lockdown e Aaron e Matthias, anche se potrebbero muoversi in auto, visto che stanno facendo il loro lavoro, hanno deciso di spostarsi solo con mezzi alternativi, ed ecco spuntare le bici. Bisogna andare su fino a 2.100 metri e le due ruote lasciano presto il posto alle pelli. Per tutto il mese di ottobre sono saliti più volte ai Laghi di Sopranes, nel Parco Naturale Gruppo di Tessa. Un modo per tenersi in forma e allestire poco alla volta il campo base. Quell’idea nata nel dormiveglia ha preso forma nel progetto Winter Home, un campo base fisso sulle montagne sopra casa, dal quale sciare tutte le linee immaginabili. Ogni volta si portavano dietro degli zaini da 10 chili e il parapendio, per rientrare più veloce- mente. Ora è tutto in quota, protetto sotto un masso. Ci sono le bombole, il fornelletto, la tenda e un po’ di provviste. Eppure quando arrivano in quota sembra di essere sulla luna. Di quel masso di quattro metri non c’è traccia, è tutto piatto. Forse si intravede un comignolo. Sarà lui? L’inizio dell’inverno pandemico coincide con la stagione più bianca da quando si registrano le precipitazioni nevose e allestire il campo base è più difficile del previsto. L’idea iniziale di Aaron è di montare la grande tenda all’interno di un igloo, in modo che la temperatura non scenda sotto lo zero. Così, insieme a Matthias, lavora sodo a spalare neve e creare grandi blocchi. Aaron e Matthias non sono eschimesi e non sanno che gli igloo, dopo la costruzione, si assestano. Così quella volta possente piano piano scende. Non c’è verso di lasciarci dentro la tenda, ma almeno può diventare un’ottima cantina. Però, con il passare dei giorni, la volta scende sempre più e l’idea di vedersi franare quei blocchi pesanti come macigni sulla testa o sulle preziose provviste non è il massimo. Il campo base si riduce alla tenda, molto spaziosa e comoda.
«In tutto l’inverno saranno passati al massimo trenta scialpinisti, mettere una tenda ai Laghi di Sopranes ci ha permesso di scoprire una zona selvaggia come i posti più lontani del mondo» dice Aaron ripensando a quei lunghi mesi a cavallo tra 2020 e 2021. Il perché il Gruppo di Tessa sia così poco frequentato è frutto di un’equazione semplice: il limite della neve spesso è tra i 1.300 e 1.500 metri, l’ultima strada finisce a 650 metri. «Per iniziare a divertirti devi fare anche 1.700 metri» sentenzia Aaron. Avere una base, uno ski lodge, a 2.100 metri, permette di partire ogni giorno alla scoperta di una linea nuova, salendo fino a 3.400 metri. «La zona di Merano è abbastanza ventosa e di solito la neve si trasforma velocemente e alcuni pendii diventano pericolosi, invece per tutta la prima parte dell’inverno le condizioni sono state stupende».
Impossibile soffermarsi su tutti i fotogrammi di oltre sei mesi. Aaron e Matthias hanno dormito nella loro casetta invernale un totale di una trentina di notti. A volte una toccata e fuga, altre tre-quattro giorni di vacanza-lavoro. Tanti ricordi, ma ci sono due istanti cristallizzati nella mente di Aaron. Due momenti vissuti con altrettanti compagni, perché una casa vuol dire ospitalità e Winter Home è stata aperta tutto l’inverno a chi condivide la stessa passione di Aaron e Matthias. La linea più bella? La linea più bella è stata quella del Verdinser Plattinger, che Aaron ha sciato con Bruno Mottini. La partenza da una lunga cresta affilata, poi una prima parte ripida e a metà un salto di roccia da superare aprendo il parapendio, in speed riding, poi ancora un grande e dolce pendio dove giocare con curve in aria e sulla neve. La discesa perfetta, quella che neanche nei sogni o nei videogiochi. E Poi l’Ivigna, la montagna sopra Merano 2000, la prima discesa ripida sciata da Aaaron, quella dove lo zio Renato aveva incontrato Heini Holzer. Questa volta condivisa con Matthias.
Febbraio 2021. Il bollettino valanghe recita pericolo cinque. Aaron ha montato la tenda dove in estate inizia il lago.
Tutto intorno una conca disegnata con il compasso. Il pendio più vicino sarà, a spanne, a 500 metri. È il posto migliore, più sicuro. Però con rischio cinque non si mettono le orecchie fuori di casa. Un rombo avvolge la conca. Parte tutto il pendio lungo 270 gradi di quella scodella bianca. Quando Aaaron e Matthias salgono ai laghi, della tenda non c’è traccia. È un mondo sommerso e devono lavorare a lungo con sonde e pale per tirarla fuori. Winter Home è stata raggiunta dall’ultimo soffio, quello meno potente, ma è sparita sotto la coltre bianca. La montagna ha mandato un segnale, lo spirito dice di rimontare tutto da un’altra parte. Questa volta la scelta ricade sulla zona del Monte Hirzer, 2.781 metri a dividere la Val Passiria dalla Val Sarentino. «In linea d’aria sono pochi chilometri, è proprio dall’altra parte della valle» dice Aaron. Smontare, trasportare e rimontare. Un lavoraccio. Questa volta i due decidono di passare dalla Val Sarentino in auto per essere più veloci a salire ad allestire la nuova Winter Home. Però poi, per raggiungerla, si sale solo by fair means. In bici fino a Tall, a 1.400 metri, e su fino in vetta con le pelli, a quasi 2.800 metri, infine giù con una vela da paraalpinismo da pochi chili e un imbrago leggero. «Ripensandoci, è stata una fatica, ma ne è valsa la pena perché ci ha permesso di esplorare un’altra zona».
È sempre così. Quando parti per le vacanze prepari le valigie con cura, pregustandoti ogni momento e ogni avventura. I dettagli fanno la differenza. Quando finiscono hai solo voglia di disfarle velocemente e pensare alla prossima vacanza. Per smontare Winter Home è bastato un giro con un po’ di amici, a maggio inoltrato. Zaini da parapendio da 150 litri in spalla e giù a valle come degli sherpa, tutti insieme. Perché le cose belle della vita vanno vissute con gli amici. Come quelle serate
a vedere il tramonto e parlare delle sciate, quel disco rosso del sole che buca la porta della tenda la mattina, la zuppa calda dopo una giornata fredda, lo speck e il grana, il rumore della neve sotto le pelli,
il soffio della polvere profonda, il digrignare dei denti della volpe che ripulisce l’osso del pollo appena mangiato. «Niente di speciale, tante piccole cose speciali». Parola di Aaron.
Aaron è Aaron Durogati e Matthias, Matthias Weger. Saranno protagonisti del cortometraggio Winter Home, diretto da Luca Curto e prodotto dalla Digital Lighthouse, in associazione con Blizzard-Tecnica e con la partecipazione di Salewa.
La tenda usata è Salewa Alpine Hut III, il saccoapelo Diadem Extreme RDS e il materassino Diadem Extreme Mat. Aaron e Matthias hanno sciato con Blizzard Rustler 10 e 11, Zero G 105 e Zero G 95 per le discese di ripido, ai piedi avevano Tecnica Zero G Tour Pro, l’outfit di Aaron è il completo Salewa Stella. Appena dopo avere smontato Winter Home, Aaron è partito per la Red Bull X-Alps insieme a Bruno Mottini, che faceva parte del suo team di assistenza. Ne abbiamo parlato su Skialper 137 di agosto.
Queso articolo è stato pubblicato su Skialper 138 di ottobre 2021

SCARPA vede un futuro verde
Comprare meno, per inquinare meno. Che significa anche fare prodotti di qualità, perché la qualità dura nel tempo e riduce la necessità di nuovi acquisti. C’è un sottile equilibrio nell’approccio di SCARPA alla sostenibilità, un approccio che è nel DNA dell’azienda di Asolo, ma che da qualche mese è stato scritto nero su bianco e ha preso forma nel Green Manifesto. Un manifesto che ha tradotto le lettere dell’acronimo aziendale in altrettanti obiettivi verdi. S come sostenibilità, C come cura, A come aria, R come rispetto, P come performance, A come autenticità. «Produciamo scarpe da outdoor e scarponi da scialpinismo e da telemark, la natura ce l’abbiamo dentro e vorremmo lasciare un’impronta positiva, non creare soltanto rifiuti o sfruttare le risorse come l’acqua» esordisce Sandro Parisotto, presidente del marchio, parafrasando la A di aria. Mentre parla, la luce filtra dalle grandi finestre che richiedono l’utilizzo dell’illuminazione artificiale per poche ore e l’aria è piacevolmente fresca ma non fastidiosa. L’ultima ristrutturazione ha trasformato l’headquarter in un esempio di architettura green, con tetti ricoperti di erba per isolare meglio l’edificio e boschi verticali. Sul tetto dello stabilimento dal 1996 i pannelli fotovoltaici coprono circa il 40% del fabbisogno energetico, a breve, con l’ampliamento alla parte del magazzino e la sostituzione dei vecchi specchi, arrivati a fine vita, si dovrebbe passare al 60-70%. Da gennaio 2020 il 100% dell’energia elettrica utilizzata in Italia proviene da fonti rinnovabili certificate. È la S di sostenibilità, che si traduce non solo in numeri e impianti, ma anche in qualcosa di più sottile, impalpabile come l’aria. «Vogliamo che il luogo di lavoro, non solo lo stabilimento, ma anche gli uffici, sia un posto piacevole, dove i collaboratori possano trovarsi a loro agio e crediamo che il percorso della sostenibilità parta da ognuno di noi, per questo abbiamo individuato 16 ambassador, distribuiti in ogni funzione aziendale, per trasmettere a ognuno i migliori comportamenti per rispettare l’ambiente, a partire da una corretta organizzazione della raccolta differenziata» dice Parisotto.
Una missione ambiziosa quella di trasmettere il germe della sostenibilità, sia che si guardi ai collaboratori, sia ai consumatori. «SCARPA è un’azienda di vendita, ma anche di produzione - continua Parisotto - con l’85% delle calzature realizzate in stabilimenti di proprietà, perché è difficile trovare partner con i nostri standard di produzione e, controllando tutto il processo, siamo convinti di poter dare la massima qualità e al tempo stesso aumentare il ciclo di vita dei prodotti, però conta anche la sensibilità dell’utente finale che si traduce in cura del prodotto e attenzione ai piccoli dettagli che possono fare la differenza, a partire dalla risuolatura di alcuni tipi di scarpe. Per questo abbiamo una rete di un centinaio di risuolatori autorizzati in tutta Italia e invitiamo, per qualsiasi problema o dubbio, a contattare il nostro customer service». È la S di sostenibilità, ma anche la C di cura che dalle parti di Asolo non fa rima con obsolescenza programmata. Il fatto che la produzione avvenga per il 60% circa in Italia riduce inoltre gli spostamenti, con un impatto positivo sull’ambiente. Stabilimenti di proprietà, in buona parte in Europa e in Italia, ha qualcosa a che fare anche con la R di rispetto, non solo per la natura, ma anche per le persone, con un controllo diretto e puntuale sulle pratiche per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
La sostenibilità è un percorso e non un punto d’arrivo. Questo in SCARPA lo sanno bene, però la nuova Mojito Bio della collezione Urban Outdoor è già un punto fermo. È il primo prodotto di SCARPA certificato 100% biodegradabile. Una volta che Mojito Bio ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, l’impatto sull’ambiente di questa calzatura è praticamente pari a zero e dopo 450 giorni l’assorbimento nel terreno arriva già all’85%. «L’obiettivo è di aggiungere un prodotto bio e sostenibile all’anno, per ora mi sembra difficile salire troppo nella tecnicità della calzatura con queste scelte, diciamo che a breve vedo possibile un percorso fino al light hiking, per andare oltre sarà importante il contributo dei nostri fornitori, ma anche la ricerca e la collaborazione con enti universitari - aggiunge Parisotto - Più le condizioni diventano estreme, più dobbiamo essere sicuri di poter garantire un ciclo di vita lungo e per arrivare alla produzione abbiamo bisogno di testare intensivamente sul campo le soluzioni nate dalla ricerca». È la P di performance, che fa rima con ricerca, nella quale l’azienda di Asolo investe circa il 5% del fatturato.
Rimarrebbe un’altra lettera per spiegare il percorso che SCARPA sta facendo verso la sostenibilità, la A finale di autenticità. Autenticità che significa essere trasparenti, senza filtri. «Il prossimo passaggio è la certificazione B Corp che dovrebbe diventare effettiva tra fine anno e l’inizio del 2022, è una scelta che abbiamo voluto con tutte le nostre forze per tradurre i comportamenti virtuosi su base volontaria in pratiche codificate e certificate». Sulla homepage della B Corporation si legge: «Le B Corp certificate si distinguono sul mercato da tutte le altre perché, oltre a perseguire il profitto, innovano continuamente per massimizzare il loro impatto positivo verso i dipendenti, le comunità in cui operano, l'ambiente e tutti gli stakeholder. Infatti l’azienda B Corp sceglie volontariamente e formalmente di produrre contemporaneamente benefici di carattere sociale e ambientale mentre raggiunge i propri risultati economici». Non ci sono altri calzaturifici italiani del mondo outdoor tra i marchi certificati e anche il mondo dell’abbigliamento con ramificazioni outdoor è poco rappresentato. «Lo step successivo potrebbe essere la modifica dello statuto aziendale in società Benefit, dedita non solo alla creazione di profitto, ma anche di benefici per il territorio, l’ambiente e il sociale» aggiunge Parisotto.
In fin dei conti scarpe che durano nel tempo, per un marchio, significa anche vendere e produrre di meno. Un obiettivo non facilmente conciliabile con le normali dinamiche aziendali. «È vero, ma esistono anche mercati dove SCARPA non ha ancora una quota di mercato rilevante e i margini di crescita posso avvenire lì, ma sempre con l’obiettivo di vendere prodotti di qualità e che durano nel tempo e poi la qualità e la necessità di controllare tutto il processo produttivo non si conciliano con crescite troppo veloci» conclude Parisotto. È la filosofia SCARPA, da oltre 80 anni.
Every Single Street
Le sterminate distese di sabbia e le gelide onde di Ocean Beach, a San Francisco, hanno qualcosa di catartico. E il gesto simbolico di Rickey Gates, che qui ha chiuso il primo agosto del 2017 la sua corsa da costa a costa degli Stati Uniti e da qui il primo novembre del 2018 è partito per il progetto Every Single Street, un’ultra-maratona per toccare ogni singola strada di San Francisco, è stato premonitore. O forse profetico. Passare dalle immense distese di uno dei Paesi più grandi del mondo alle 49 miglia quadrate di una città di poco meno di un milione di abitanti assume un significato ancora più profondo ora che, a causa delle restrizioni dei lockdown e delle conseguenze dell’era Covid, abbiamo riscoperto tutti una dimensione più local. E l’hashtag #everysinglestreet, oltre che un cortometraggio della Salomon TV, è diventato virale, con seguaci in ogni parte del mondo. Per correre dalla South Carolina a Ocean Beach, Rickey Gates ha coperto 3.700 miglia (poco meno di 6.000 chilometri), per raggiungere tutte le strade di Frisco, come i local chiamano la città del Golden Gate, 1.317 miglia (poco più di 2.100 chilometri) e 147.000 piedi di dislivello, quasi 45.000 metri.
Dopotutto in sette miglia per sette miglia ci sono ben 1.100 miglia (1.770 chilometri) di strade e per percorrerle tutte, anche se sei efficiente al massimo, devi coprire alcuni tratti più volte. «Correre su ogni singola strada di San Francisco in 45 giorni è stato come fare un’ultra ininterrotta tra le montagne, perché non puoi mai staccare con la testa, devi essere sempre concentrato e il dislivello è importante - dice Rickey - Però per altri versi è molto diverso, perché la nostra idea di trail running è spesso legata alla fuga, è semplicemente esistere in un posto e non essere perfettamente presenti e consapevoli in quel luogo: correre per le strade della città è l’opposto di fuggire». Ed è un rompicapo degno del cubo di Rubik, al quale si stanno appassionando centinaia di adepti che si ritrovano su citystrides, dove è possibile tenere traccia di tutte le strade percorse collegando il proprio account Strava o di altri servizi simili. «Si tratta di risolvere il problema del postino cinese e, si badi bene, non quello del postino americano. È un problema classico della matematica che consiste nel tracciare un percorso per raggiungere ogni lato di una strada e non semplicemente ogni indirizzo a cui va consegnato un pacco». Un problema di difficile soluzione pratica se è vero che Gates ha cercato di risolverlo elaborando un algoritmo con l’amico Michael Otte e alla fine ha dovuto ripiegare su un più empirico metodo fatto di mappe da tracciare con penne colorate. «È incredibile, sei in un quartiere e dici ancora un po’ e ho finito, e invece ti prende tutta la giornata». Every Single Street è la sfida e l’avventura dietro casa, dove non avresti mai immaginato. «Probabilmente ora è il momento migliore per partire alla scoperta della propria città, siamo uomini e il viaggio è nel nostro DNA, ecco perché accettare con curiosità la sfida è quello che abbiamo bisogno durante questi momenti di restrizioni».

Naturalmente correre a Frisco non è esattamente come farlo in qualsiasi dannata città o cittadina, perché San Francisco, come dice Rickey dopo averne percorso in lungo e in largo tutte le strade, compresa Gates Street, è il mondo. «Per me correre è sempre stato un mezzo, per incontrare le persone, per conoscere i luoghi o me stesso: ci sono stati tempi in cui il cronometro mi motivava, ma ora a 39 anni la corsa è diventata molto di più e farlo in una città densamente popolata ti porta in contatto con volti, odori, rumori. Siamo creature abbastanza semplici, le persone vogliono solo un po’ di attenzione, che le guardi e che sorridi con loro e correre nella città ti mette nelle condizioni di andare in profondità nel concetto di empatia, di cercare di dare a ogni persona che incontri la stessa importanza, come se fossimo tutti nello stesso orologio e vivessimo allo stesso livello momenti ed emozioni». Correre in città è uno stimolo incredibile per la curiosità, quella stessa curiosità che ci muove verso obiettivi impensabili. Rickey Gates, correndo per le strade di Frisco, si è preso i ritmi e i tempi per fermarsi e curiosare, scattando migliaia di fotografie. Ci sono raccolte con titoli curiosi, come per esempio la scritta Jesus saves, i cartelli di animali domestici persi o le decine di Karmann Ghia, ma anche temi più seri come i tanti barboni che dormono per strada. «Alcune cose hanno attirato la mia attenzione come mai prima: Jesus saves l’ha scritto la stessa persona, su alcune strade vicine, mi sono divertito a immaginarlo seduto sull’asfalto a tappezzare l’asfalto di quella scritta; la Karmann Ghia è la macchina sportiva più sexy di sempre e il mio furgone VW del 1974 ha un motore molto simile».
Correndo su ogni dannato chilometro di asfalto o di sterrato di una città diventi anche la migliore guida di quel luogo. E sai che a Frisco non puoi non fare un salto a Bernal Heights, dove ci sono dei murales e si vede dall’alto la skyline, o a Bayview, zona afro-americana perfetta per una soul session o un BBQ. «Quando esco a correre mi porto dietro qualcosa da mangiare, ma una delle piccole gioie di Every Single Street è stata mangiare cinese, messicano, arabo, provare il cibo di El Salvador: peccato che i migliori ristoranti etiopi siano fuori dalla città, a Berkeley e Oakland». C’è un altro aspetto di Every Single Street nel quale Gates è stato profetico: correre con una mascherina FFP2. Quando l’ho visto in una fotografia non volevo crederci: «C’era un grande incendio a circa 100 miglia di distanza, il risultato di una cattiva gestione delle foreste e della siccità. Spesso le città si credono lontane dalle calamità naturali e così ho pensato che fosse importante sperimentare la vibrazione di San Francisco durante questo periodo e l’unico modo per farlo era indossare una maschera. Non è così male, è difficile solo se vai forte, ma non faceva parte dei miei piani». Forse non ci voleva il Covid per riscoprire l’avventura in città e Rickey l’aveva capito in anticipo, ma dopo la pandemia la vita sarà la stessa e soprattutto, le città saranno ancora così popolate? «Penso che il mondo non tornerà mai più all’era pre-Covid e che sia un bene; avevamo bisogno di un tasto con scritto su pausa, anche se naturalmente sono addolorato per tutte queste morti. Credo che nelle città succederà quello che è successo al tempo della prima White Fight negli anni ’50 quando sono diventate un luogo più sicuro per gli afro-americani e i bianchi che potevano permetterselo si sono trasferiti nelle vicinanze, perché la minaccia di essere troppo vicini agli altri è un’autentica paura, però siamo un Paese in crescita demografica e anche le piccole città stanno crescendo, così la differenza tra i luoghi è sempre minore». L’idea di Rickey è diventata matura e ora c’è un sito interamente dedicato a Every Single Street con resoconti da tutto il mondo. E lui non abita più a San Francisco, ma a Santa Fe, nel Nuovo Messico, dove ha replicato il progetto. «È stato simile e diverso allo stesso tempo, simile perché è un modo per conoscere meglio un posto, diverso perché sono due città diverse. Santa Fe ha una lunga storia di poche persone che hanno combattuto per la terra e il potere, gli indiani Pueblo, gli spagnoli e gli americani, e questa tensione la senti ancora.
Ci sono strade pubbliche dove non sei benvenuto, perché chi abita lì le sente come proprie e ti lanciano contro i cani o chiamano la polizia». Se uno che ha corso a San Francisco lo ha fatto anche in tutte le strade di una sonnolenta cittadina del Sud inseguito da cani e polizia, allora ognuno di noi può provare a farlo a casa propria. Io ho iniziato subito dopo avere scritto questo articolo.
QUESTO ARTICOLO È STATO PUBBLICATO SU SKIALPER 131